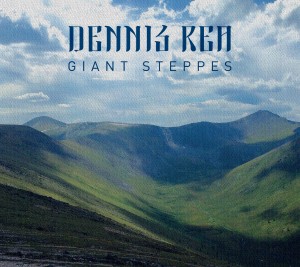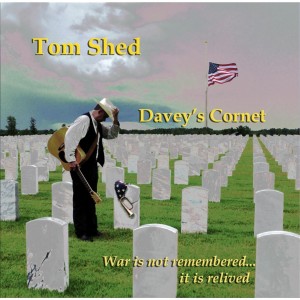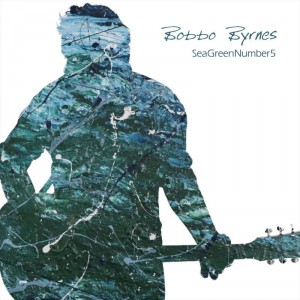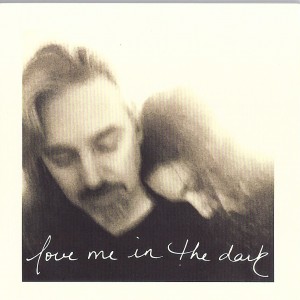DENNIS REA – Giant Steppes
di Paolo Crazy Carnevale
28 febbraio 2021
Dennis Rea – Giant Steppes (Moonjune 2020)
Gradito ritorno quello del chitarrista newyorchese Dennis Rea che a distanza di dieci anni torna ad esplorare la musica asiatica contaminandola con una sonora dose della sua sei corde elettrica.
Rea, che vanta un lungo curriculum musicale influenzato dal krautorck e dalla scuola progressive di Canterbury, ha pubblicato diversi dischi a proprio nome ma ha anche fatto parte di progetti internazionali come Moraine, Zhangyou, Iron Kim Style di cui ci siamo già occupati su queste colonne, sempre con ampi riferimenti alla musica asiatica, ma anche all’art rock (con i Moraine), nel 2004 aveva dato alle stampe un live registrato a Pechino e nel 2010 era uscito Views From The Chicheng Precipice un omaggio molto sentito alle sonorità dell’estremo oriente.
Ora con questi “passi da gigante”, quattro lunghe composizioni che costituiscono il suo nuovo lavoro, Dennis Rea sposta il tiro verso l’Asia Centrale, tra la Cina e le alture della Mongolia, fino alle regioni più asiatiche della Russia.
Rea, che da anni ha stabilito la propria base a Seattle, di fatto uno dei punti degli USA continentali più vicini all’Asia, ci ha messo quattro anni per portare a termine questo lavoro complesso ed elaborato, per altro molto riuscito.
Giant Steppes è il frutto di un lavoro accurato e studiato al dettaglio, in cui si mescolano i suoni prodotti da Rea e dal suo gruppo con voci, cori e musiche raccolti sul campo nelle regioni asiatiche che stanno alla base di questa esplorazione sonora. Le registrazioni sono state effettuate a Seattle, Tacoma, Krasnoyarsk e fungono anche da colonna sonora ad un libro che viene distribuito col disco in cui il chitarrista racconta il suo viaggio musicale. Maestosa la traccia d’apertura, intitolata Live At Goachang, qui Rea (che suona ogni chitarra) è accompagnato da Don Berman alla batteria, Stuart Dempster al didgeridoo, Greg Campbell (corno elettrico), Greg Kelley (tromba) e Dick Valentine (sassofoni). Ci sono poi cori raccolti nell’Altai, che costituiscono una parte importante della seconda traccia del disco, Altai By And By, in cui è poi fondamentale il coro Pava guidato dalla cantante Juliana, con unici elementi estranei la chitarra di Rea e l’hurdy gurdy .
Altro brano d’effetto è il terzo del disco, Wind Of The World’s Nest, in cui troneggia la voce quasi death metal di Albert Kuvezin in cui sono state usate anche le melodie del tradizionale della regione di Tuva Baezhin. Il disco si chiude con i quasi quindici minuti di The Fellowship of Tsering elaborata composizione ottenuta assemblando estratti da una performance di Rea al festival jazz di Krasnoyarsk, con altre cose registrate invece a Tacoma e Seattle. Anche qui è presente la voce di Kuvezin, mentre gli strumenti sono oltre che la chitarra di Dennis (qui anche alla kalimba), la batteria di Daniel Zongrone, il basso di Wadim Dicke, il flauto di Valentine, le tastiere di Steve Fisk e un particolare corno asiatico suonato da Greg Powers.
Paolo Crazy Carnevale