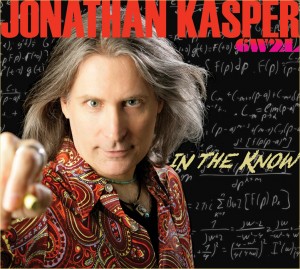DAVID BERKELEY – Cardboard Boat
di Paolo Crazy Carnevale
31 marzo 2016
DAVID BERKELEY – Cardboard Boat (Straw Man Music/Hemifran 2015)
Curioso personaggio questo David Berkeley: un cantautore originario del Garden State lontano anni luce dalle sonorità degli alfieri musicali del suo luogo d’origine e da tempo stabilito nella meno caotica Santa Fé, New Mexico. Curioso perché nonostante abbia inciso nel corso degli anni quasi una decina di dischi, sembra preferire la parallela carriera che conduce come narratore, come dimostra proprio questo suo ultimo prodotto, nato all’inizio come “companion” – per dirla all’americana – del suo recente libro per bambini The Free Brontosaurus. Il disco però non contiene propriamente musica per bambini e così ha finito per divenire quasi una cosa a sé stante col titolo di Carboard Boat.
Si tratta di un disco molto intimo, composto da dieci brani dalle atmosfere rilassate, cantati con voce ispirata e con un accompagnamento non minimale ma quasi con l’intento di proporre delle canzoni che siano ispirate dal punto di vista di dieci differenti personaggi del libro (ritratti al centro del booklet)
Le composizioni di Bekeley sono apprezzabilissime e ce ne sono alcune che fanno breccia nell’ascoltatore, merito senza dubbio della produzione e dall’accompagnamento strumentale tutt’altro che scontato.
Per comprendere bene andiamo a dare un’occhiata alle note di copertina, scoprendo così che il disco è stato registrato a Chupadero, vi dice nulla questo posto? Si tratta del luogo dove è situato lo studio di Jono Manson, che è appunto coproduttore del disco e vi suona in qualche brano. Tra i musicisti coinvolti troviamo poi Sara Watkins (Nickel Creek), il polistrumentista Jason Crosby (che con Manson aveva collaborato anche al disco dei Gang), il chitarrista Bill Titus, Jordan Katz (presente in dichi di Iggy Pop, Indigo Girls, Jimmy Cliff, Dan Bern) e il batterista Matthias Kunzli, dal curriculum infinitamente lungo.
Se il primo brano è di quelli molto intimisti, e nel disco ve n’ è più d’uno (ad esempio la title track, sorretta da un drumming su cui però si inseriscono mano a mano gli altri strumenti fino a sfociare in un crescendo impreziosito da un vero e proprio tour de force del violino di Jason Crosby), con la successiva To The Sea arriviamo subito ad uno dei momenti topici del disco, con la voce della Watkins che quasi duetta con quella del leader. E non sono da meno Colored Birds, il valzerone Last Round di nuovo con la Watkins in bell’evidenza e la delicata Wishing Well, caratterizzata dall’organo di Will Robertson e dall’uso di violino, cello e tromba che conferiscono al brano una sorta di atmosfera cameristica per il risultato che ne esce. Altro brano di grande effetto è Hole In My Heart, altro valzer contrappuntato da banjo e violino, mentre un’altra grande composizione è Brighter Day che inizia appena sussurrata e conta sul curioso mélange tra la folta sezione d’archi e gli altri strumenti. Dinosaurs And Sages lascia invece meno il segno, al pari della conclusiva Broken Crown, altro brano molto intimista.


![robbie fulks [257008] robbie fulks [257008]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/robbie-fulks-257008-300x300.jpg)

![LOLA cover [216515] LOLA cover [216515]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/LOLA-cover-216515-300x300.jpg)
![greg trooper live [181251] greg trooper live [181251]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/greg-trooper-live-181251-300x300.jpg)
![beledo [160642] beledo [160642]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/beledo-160642-300x260.jpg)
![merk davis [151713] merk davis [151713]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/merk-davis-1517131-300x271.jpg)
![boris savoldelli garriosn fewell [149111] boris savoldelli garriosn fewell [149111]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/boris-savoldelli-garriosn-fewell-149111.jpg)
![wsh-work-cover1500x1500 [145301] wsh-work-cover1500x1500 [145301]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/wsh-work-cover1500x1500-145301.jpg)
![SAN VITTORE 3_V3 [149742] SAN VITTORE 3_V3 [149742]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/SAN-VITTORE-3_V3-149742-731x1024.png)

![tiffany-huggins-grant_jonquiil-child-400x359 [97845] tiffany-huggins-grant_jonquiil-child-400x359 [97845]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/tiffany-huggins-grant_jonquiil-child-400x359-97845-300x269.jpg)
![SAN VITTORE 3_V3 [83646] SAN VITTORE 3_V3 [83646]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2016/03/SAN-VITTORE-3_V3-83646-214x300.png)