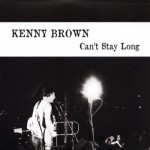JAMES MADDOCK
Live At Rockwood Music Hall (Casa Del Fuego 2010)
Wake Up And Dream (Casa Del Fuego 2011)
Il nome di James Maddock ha iniziato a circolare alla fine degli anni novanta. Nato a Leicester e ancora domiciliato in Gran Bretagna, incise un album con i Wood, Songs From The Stamford Hill, pubblicato dalla Columbia. Le recensioni furono molto positive, ma durante la preparazione del secondo disco la band si sciolse. Nel 2003 James si è trasferito a New York dove risiede tuttora ed ha ripreso a comporre, attendendo una nuova occasione che gli è stata offerta sette anni dopo dalla Ascend. Così è stato pubblicato il suo primo album da solista, Sunrise On Avenue C, seguito a pochi mesi di distanza da un disco dal vivo e da Wake Up And Dream, entrambi oggetto di questa recensione. La possibilità di scegliere tra le numerosi canzoni composte negli ultimi anni ha reso Sunrise ed il successivo Live (comprendente ben 9 brani del disco in studio) due album di ottima qualità con materiale di prima scelta, che hanno consentito a Maddock di ottenere buoni riscontri critici e di girare soprattutto in Europa, compresa l’avventura dello springsteeniano Light Of Day Tour. James ha una voce caratteristica, un po’ roca e ben modulata, con tracce di un giovane Tom Waits, di Rod Stewart e Frankie Miller (con qualche dose di whiskey in meno), di Springsteen e Ian Hunter, mentre gli arrangiamenti sono indiscutibilmente debitori di Van Morrison e del Boss (come riconosce lo stesso artista). Dal vivo il suono è più liquido e rilassato, con fluide code strumentali, mentre in studio è privilegiato un formato più compatto e radiofonico con venature pop (se le radio fossero più coraggiose e non trasmettessero solo i soliti noti o i pompati dalle majors Maddock potrebbe vendere parecchio, come anni fa succedeva a Seger, Petty o Mellencamp…ma questa è un’altra storia). Vanno riconosciuti i giusti meriti all’eccellente band comprendente il funambolico pianista Oli Rockberger, il chitarrista John Shannon, il batterista Aaron Comess ed il bassista Drew Mortali, ai quali spesso si aggiunge l’ottimo mandolinista David Immergluck dei Counting Crows. Live At Rockwood Music Hall, registrato nel locale newyorkese, è un live brillante, alternando brani trascinanti a ballate sofferte e coinvolgenti. Tra le prime spiccano l’opener When The Sun’s Out e Chance ai confini tra rock e pop (non sfigurerebbero in un disco di Rod Stewart), e le divertenti Prettier Girls e Dumbed Down (che chiude il disco), mentre l’inedita Straight Lines ha una melodia azzeccata, ma è un po’ leggerina. Le seconde meritano tutte una citazione, a partire da Never Ending, unica ripresa dal disco dei Wood, una ballata nostalgica sull’adolescenza a Leicester che ricorda lo Ian Hunter più ispirato, per proseguire con la sofferta Stars Align debitrice di Van Morrison nella parte strumentale guidata da chitarra acustica e piano, Sunrise On Avenue C (ennesimo brano su New York), concludendo con la splendida Fragile, nella quale piano e chitarra (acustica ed elettrica) forniscono un tappeto perfetto per la voce melanconica di Maddock. Ma anche il mid-tempo Hollow Love, introdotto dalla chitarra acustica ed arrangiato con sapienza, fa la sua figura. Riguardo a Wake Up And Dream è evidente la ricerca di un suono più vicino al pop, sempre di classe e ben arrangiato, ma un po’ leggero, privato delle aperture strumentali che contribuiscono in modo significativo alla qualità del live. E anche il materiale risente forse di un un periodo più breve ed intenso di scrittura, risultando meno ispirato. Un buon disco, ma inferiore al precedente, pur comprendendo alcune tracce significative come l’opener Beautiful Now, composta con Mike Scott dei Waterboys, la melodica Step Into The Water e la pianistica Stella’s Driving. Ma proseguendo nell’ascolto la prevalenza di mid-tempo piacevoli e poco più mi sembra prevalente: prese singolarmente le varie Living A Lie, Wake Up And Dream, Stoned On You o Love Is The Flower sono carine, una dopo l’altra un po’ ripetitive. L’ottima ballata elettroacustica Keep Your Dream guidata da piano e mandolino chiude un disco complessivamente inferiore alle attese da parte di un musicista che può sicuramente fare meglio.
Paolo Baiotti

CESARE CARUGI
HERE’S TO THE ROAD
Roots Music 2011
Da qualche anno non si può più dire che in Italia manchino validi musicisti ispirati dal suono roots americano dei grandi cantautori rock (Dylan, Young, Springsteen, Petty, Seger, Prine, Van Zandt, Earle…). Mi riferisco a gruppi come Cheap Wine, Mandolin Brothers e Lowlands e solisti come Andrea Parodi, Massimilano Larocca, Lorenzo Bertocchini, Evasio Muraro, Fabrizio Poggi e Daniele Tenca (pur essendo questi ultimi più vicini al blues). A questo gruppo sempre più numeroso si aggiunge Cesare Carugi, musicista di Cecina che, dopo il mini album Open 24 Hours (comprendente anche una cover di Open All Night di Springsteen) pubblica il suo primo disco solista. Se non conoscessi le sue origini avrei potuto considerare Here’s To The Road l’esordio di un cantautore dell’Illinois o del Minnesota. Aiutato principalmente da Lele Bianchi (batteria) e Leonardo Ceccanti (chitarra), Cesare canta, suona chitarra, basso, armonica e dobro e produce il disco, oltre ad avere scritto le undici tracce, senza neppure una cover. Una prova di coraggio e di bravura notevole, visto il livello qualitativo dei brani. In particolare la prima parte del dischetto non ha punti deboli: l’opener Too Late To Leave Montgomery è un mid-tempo degno dei migliori cantautori americani con una melodia riconoscibile ed un arrangiamento nel quale spicca la pedal steel di Gianni Gori che avvolge la sicura interpretazione vocale di Carugi, London Rain ha un’immediatezza da singolo pop rock, Blue Dress è una ballata dall’incedere egualmente drammatico nella musica e nel testo, Goodbye Graceland un brano trascinante che mi ha ricordato i Clash di London Calling. Ancora meglio la parte centrale con una ballata romantica di livello notevole come Caroline con il violino prezioso di Fulvio A.T. Renzi e la seconda voce della cantautrice Giulia Millanta, seguita dalla pianistica Dakota Lights & The Man Who Shot John Lennon, nella quale Cesare è aiutato dalla caratteristica voce di Michael McDermott. Forse il prosieguo dell’album non ha la stessa fluidità, ma almeno la springsteeniana 32 Springs (con l’amico Riccardo Maffoni, altro nome emergente del panorama italico), l’incalzante Every Rain Comes To Wash It All Clean con la lap steel di Daniele Tenca e la conclusiva ballata acustica Cumberland sono degne di nota. Una buona qualità sonora ed un libretto degno di produzioni più ricche completano un esordio significativo e promettente. Il cd è reperibile sul sito www.cesarecarugi.com.
Paolo Baiotti
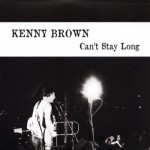
KENNY BROWN
CAN’T STAY LONG
Devil Down Records 2011
Cresciuto nel North Mississippi, Kenny ha imparato a suonare a dieci anni a Nesbit dal suo vicino Joe Callicott. Influenzato dai bluesman più conosciuti nella regione (Jr. Kimbrough, Fred McDowell, Muddy Waters) ha suonato per oltre vent’anni come secondo chitarrista con R.L. Burnside (specializzandosi alla slide), uno dei pochi chitarristi bianchi che poteva presentarsi senza problemi in un juke joint (come qualche anno dopo è successo a Luther Dickinson, suo grande amico e sostenitore), da esperto conoscitore ed esecutore dello stile downhome tipico di questi musicisti. Un blues essenziale, secco, rozzo, diretto, ipnotico, senza grandi variazioni strumentali, influenzato dal rock n’ roll e da una spruzzata di funky. Nel ‘96 ha pubblicato l’esordio solista Back To Mississippi, seguito sette anni dopo da Stingray per la Fat Possum e poi da Goin’ Back To Mississippi e da Meet Ya In The Bottom. Ed ora questo doppio diviso in un album elettrico (Money Maker) reigistrato dal vivo all’Hill Country Picnic e in uno acustico (Porch Song). Nel primo è accompagnato da una band tosta che comprende Terence Bishop al basso, John Bonds alla batteria e Mark Yakavone alle tastiere, oltre agli amici Luther Dickinson e Dywayne Burnside (figlio di R.L.Burnside) entrambi alla chitarra ritmica, nel secondo è da solo alla voce, chitarra acustica e lap steel. Brown convince in entrambe le situazioni: il disco elettrico comprende versioni trascinanti, piene di grinta e di calore di brani tipici del downhome blues di Burnside come Skinny Woman e Jumper On the Line, Alice Mae di Samuel Jackson e dei classici Shake Your Money Maker e Let’s Work Together (famosa la versione dei Canned Heat). La voce di Brown a tratti assomiglia a Johnny Winter (un po’ meno rauca) e si adatta perfettamente al materiale aspro ed ipnotico, mentre la sezione ritmica non perde un colpo e le chitarre imperversano senza particolare fantasia ma con grande solidità e concretezza. La sorpresa è il disco acustico nel quale Kenny dimostra di essere meno grezzo di quello che sembra, riuscendo a non annoiare pur nell’essenzialità degli arrangiamenti, a partire da una bella versione di Backdoor Man.di Willie Dixon (classico del repertorio di Howlin’ Wolf). La chitarra acustica e la slide (o la lap steel) si sovrappongono con efficace semplicità, basta ascoltare i deliziosi tradizionali Jesus On the Mainline e Jesse James, la cover di World War I del suo mentore Joe Callicott, il folk blues di When You Got A Good Friend, il gospel Prodigal Son del Rev. Robert Wilkins o l’intimista versione di Baby Please Don’t Go con una lunga introduzione acustica. Skinny Woman è presente anche in versione acustica e precede l’ipnotica Shake’Em che chiude il dischetto. Un bluesman da seguire con attenzione che si conferma molto più di un semplice sideman.
Paolo Baiotti

AUTORI VARI
Warren Haynes Presents: The Benefit Concert Vol. 4
Evil Teen 2011
Nell’89 Warren Haynes, all’epoca chitarrista emergente appena entrato negli Allman Brothers, decide di organizzare un concerto nella città natale di Asheville in Carolina del Nord con scopi benefici. Il momento più facile per radunare musicisti locali è il periodo natalizio; la prima edizione si svolge alla Civic Center Arena con grande successo…da allora sono passati 22 anni ed altrettante edizioni della Christmas Jam, diventato un evento attesissimo con ospiti sempre più prestigiosi ed una coda di musicisti interessati a partecipare. Risolti i soliti problemi burocratici, Warren ha iniziato a pubblicare anche dei dischi, uno per anno a partire dal 1999, il volume 4 è del 2002 e c’è stato anche un dvd per il 2006 (il volume 8). I guadagni dei concerti, dei dischi e del merchandising vengono consegnati puntualmente ad Habitat For Humanity, organizzazione che si occupa dei senzatetto della regione. Questo doppio inciso il 21 dicembre del 2002 è uno dei migliori per varietà degli ospiti e qualità delle interpretazioni. Warren apre la serata con una rara versione acustica di Carolina In My Mind di James Taylor, seguito dal gruppo bluegrass locale Sons Of Ralph che si esibisce in 111, uno strumentale western nel quale spicca il mandolino del leader Don Lewis e nella cover di Nine Pound Hammer di Merle Travis con l’aggiunta della slide di Haynes. Jerry Joseph, ex leader dei Jackmormons, esegue The Kind Of Place ed un’intensa Climb To Safety dei Widespread Panic con Robert Randolph, Haynes, Dave Schools al basso e Matt Abts alla batteria. Proprio il formarsi di band estemporanee e lo scambio di partecipazioni è una delle caratteristiche di queste serate piene di sorprese. Robert Randolph, virtuoso della pedal steel, ha imparato a suonare in chiesa con il gospel, mischiando in seguito il suono sacro con funky e soul. Ha una gran voce ed alla chitarra è vulcanico, forse alla lunga un po’ ripetitivo, ma i due brani frenetici che esegue si ascoltano con piacere. Seguono i Moe., una delle migliori jamband americane, che aprono con un segmento di Dark Star dei Grateful Dead in medley con la loro Mexico, dimostrando qualità non comuni, riaffermate da Opium, un mid tempo rilassato jammato in scioltezza (con Haynes alla slide). Il secondo dischetto è veramente da antologia: inzia John Hiatt che all’epoca aveva riformato i Goners con Sonny Landreth alla chitarra ed era reduce dall’ottimo The Tiki Bar Is Open. La title track viene riproposta con il sax di Jon Smith, preceduta dalla bluesata Ride Along (tratta da Slow Turning) e seguita da una trascinante Memphis In The Meantime con Landreth e Haynes protagonisti alla chitarra. Bob Weir rappresenta la famiglia dei Grateful Dead, accompagnato da Warren alla solista, Dave Schools al basso (Widespread Panic), Rob Barraco alle tastiere e John Molo alla batteria. Shakedown Street non mi entusiasma, ma la parte strumentale è interessante, meglio Truckin’ e un’intensa The Other One. A questo punto salgono sul palco i Gov’t Mule, che in quel periodo non avevano ancora sostituito Allen Woody con un bassista fisso. Haynes e Abts sono affiancati da Danny Louis alle tastiere (ancora oggi nella band) e Greg Rzab al basso. Partono con una strepitosa Worried Down With The Blues, uno slow di un’intensità pazzesca, davvero un blues da antologia, seguito dall’improvvisata Sco-Mule, strumentale nel quale vengono affiancati da Dan Matrazzo alle tastiere, Jon Smith al sax, Mike Barnes alla chitarra e DJ Logic. La serata è chiusa da un classico del rock sudista, la ballata Simple Man dei Lynyrd Skynyrd con il batterista Artymus Pyle e l’ex Black Crowes Audley Freed insieme ai Gov’t Mule, una versione coinvolgente con Haynes ottimo alla voce e quel suono di chitarre sudiste che non guasta mai. Una degna conclusione di una grande serata. Un’edizione limitata aggiunge un terzo dischetto con cinque brani acustici incisi il giorno prima per la stazione radio WNCW, tra i quali due tracce di Alvin Youngblood Hart ed un pregevole medley di In My Time Of Dying>It Takes More Than A Hammer di Hart con Warren e Schools.
Paolo Baiotti
MATT SCHOFIELD 
Anything But Time
Nugene 2011
Nato a Manchester nel ‘77, Matt ha intrapreso seriamente la professione di musicista a 18 anni. Ha accompagnato la cantante blues Dana Gillespie per quattro anni prima di formare un trio con il quale ha pubblicato quattro album in studio e un paio di live. Considerato con Ian Siegal il miglior chitarrista di blues della nuova generazione britannica, ha dimostrato progressi costanti, aggiudicandosi un paio di British Blues Awards due anni fa con il disco Head Tails & Aces. Accompagnato dal fedelissimo Jonny Henderson (tastiere e bass keys con le quali supplisce alll’assenza di un bassista) e da Kevin Hayes (batteria, già con Robert Cray) e con la produzione dell’esperto John Porter (B.Guy, BB King, Otis Rush…), ha inciso a New Orleans e pubblicato a fine anno Anything But Time, un disco di blues moderno, dal suono pulito influenzato dall’atmosfera della Louisiana in alcune ritmiche ondeggianti tra soul e funky. Forse manca un pizzico di grinta e certe sonorità appaiono un po’ freddine e troppo laccate (rispetto ad altri bluesmen), ma le qualità ed il gusto del chitarrista, più che valido anche alla voce, sono indiscutibili.
La jazzata Anything But Time richiama il suono di Robben Ford e di certo blues swingato forse un po’ soffice, ma See Me Through mette subito le cose a posto, uno slow incisivo nel quale Matt si dimostra capace di fraseggi convincenti, accompagnato brillantemente dall’organo di Henderson e dal piano dell’ospite Jon Cleary, esperto musicista locale. At Times We Do Forget è un recente brano di Steve Winwood da Nine Lives eseguito con eccessiva pulizia e leggerezza (d’altronde non è che l’originale sia migliore…), mentre Slipwrecked risente delle influenze di New Orleans, come la ritmata One Look. Preferisco la ballata Dreaming Of You di matrice hendrixiana con un eccellente assolo ed il mid tempo Wrapped Up In Love, cover di Albert King (uno dei riferimenti di Schofield). Where Do I Have To Stand è un blues lento jazzato (e un po’ freddino), Don’t Know What I’d Do un mid tempo raffinato con una voce che può ricordare Johnny Winter (dal vivo Matt si avvicina maggiormente nei toni vocali al grande albino texano). Si chiude con Share Our Smile Again, un blues veloce valido nella scrittura, ma sempre un po’ troppo pulito ed asettico. Un buon disco nella consapevolezza che finora Schofield ha dato il meglio dal vivo, sia in concerto che su disco (Live From The Archive è eccellente).
Paolo Baiotti

VAN HALEN
A Different Kind Of Truth
Interscope 2012
Tra il ‘78 e l’84 i Van Halen sono stati una delle band americane più popolari. Il quartetto formato dai fratelli Alex e Eddie Van Halen, da Michael Anthony e dal cantante David Lee Roth è diventato un’icona del nuovo hard rock, basato sul suono metallico, tecnico ed iperveloce della chitarra di Eddie (che ha influenzato una miriade di chitarristi che ne hanno amplificato i difetti, non riuscendo a ripeterne i pregi), contrapposto alla voce roca e bluesata di David. Dopo l’esplosivo successo di 1984 (ricordate i singoli Jump e Panama?) il cantante ha lasciato la band intraprendendo una carriera solista gradatamente evaporata, mentre il gruppo ha proseguito con Sammy Hagar alla voce, mantenendo una vasta popolarità, ma cedendo progressivamente terreno anche sul piano qualitativo. Nel ‘96 Hagar è stato liquidato e sostituito nuovamente da Roth per l’incisione di due brani per una raccolta, ma i pessimi rapporti tra Eddie e David hanno portato ad una nuova rottura ed al penoso disco con il cantante Gary Cherone, subito licenziato. I problemi di salute di Eddie e l’abbandono del bassista Anthony hanno bloccato per alcuni anni l’attività della band, ma le voci su una reunion con Roth non si sono mai interrotte. In effetti nel 2007, dopo l’insediamento nella Rock And Roll Hall Of Fame, è stato organizzato un tour con il figlio di Eddie al basso. Dopo un’altra pausa ed una lunga preparazione ecco il nuovo disco in studio, a ventotto anni da 1984, seguito da un tour che si sta svolgendo in arene quasi sempre esaurite. Cosa si può dire di A Different Kind Of Truth? Indubbiamente il suono ci riporta ai primi due dischi della band, l’omonimo esordio e Van Halen II …d’altronde alcuni brani sono dei demo precedenti all’esordio completati recentemente e quindi non possono che richiamare il passato. E anche le altre tracce sono state scritte nello stesso stile secco e diretto: hard rock essenziale con le riconoscibili schitarrate di Eddie nelle quali si inserisce la voce di Roth, che ha forse perso un po’ di potenza, ma ha acquistato profondità. Un disco un po’ di maniera (ma poteva essere altrimenti?) che suona sorprendente fresco e potente; Eddie torna ai fasti del passato risultando a tratti esplosivo, aiutato dalla ritmica pulsante di Alex e del giovane nipote Wolfgang mentre Roth è meno gigione, più maturo e concentrato. Tra i brani segnalerei l’opener Tattoo (rifacimento del demo di Down In Flames), la melodica You And Your Blues (con i tipici cori della band), la trascinante The Trouble With Never con un assolo lancinante, il delizioso blues elettroacustico Stay Frosty (con richiami evidenti ad Ice Cream Man dal primo album) e Big River che sembra un’outtake del primo album (non a caso è un altro demo dei seventies). La versione deluxe aggiunge un dvd con le downtown sessions, nelle quali vengono eseguite versioni acustiche di due brani vecchi (Panama e Beautiful Girls) e della nuova You And Your Blues.
Paolo Baiotti
AUTORI VARI

The Best Of Rock And Roll Hall Of Fame + Museum Live
Time Life 2011
Inaugurata nell’86, la Rock And Roll Hall Of Fame ha ammesso nel corso degli anni molti artisti che hanno fatto la storia del rock (con alcune dimenticanze…) nel corso di una cerimonia che da sempre è organizzata a New York in una grande sala dell’Hotel Waldorf Astoria. In genere uno o più artisti introducono i premiati con un discorso; ogni premiazione è seguita dall’esecuzione di uno o più brani con gli ospiti che si mischiano fra loro creando formazioni inedite interessanti o quantomeno curiose. La Time Life ha pubblicato nel ‘09 un triplo dvd con gli highlights di queste serate (e di altri concerti organizzati dal Museo della Hall Of Fame), seguito da un nonuplo ovviamente più esaustivo (ma sempre incompleto) ed ora da un triplo cd che in poco meno di quattro ore ripercorre la storia della manifestazione. Purtroppo non lo fa cronologicamente e le stringate note del libretto non indicano né gli anni né le formazioni complete delle singole esecuzioni. Come sempre in queste raccolte si alternano brani di diversa qualità ed interesse, ma bisogna dire che i tre dischi si mantengono su un livello medio più che accettabile, a volte un po’ inferiore alle attese visti i protagonisti. Scegliere tra i cinquantuno brani non è facile, ma non potendo elencarli tutti bisogna farlo. Dal primo dischetto mi hanno colpito Train Kept A Rollin’ con Jeff Beck, Jimmy Page, Joe Perry, Ron Wood, nonostante la voce non adatta al brano di Lars Ulrich dei Metallica, A Change Is Gonna Come di Al Green, una deliziosa For What It’s Worth di Crosby Stills e Nash con Tom Petty, Break On Through dei Doors con Eddie Vedder perfetto alla voce ed il soul di In The Midnight Hour con Wilson Pickett e Bruce Springsteen. Il secondo cd parte con Sunshine Of Your Love, prima reunion dei Cream che in seguito torneranno anche a suonare in tour e prosegue ancora meglio con una splendida While My Guitar Gently Weeps con Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, il figlio di Harrison e Prince superbo alla chitarra. John Fogerty spicca con Green River e Born On The Bayou (con Bruce), mentre i Traffic si riformano per Mr Fantasy, gli Allman Brothers eseguono un’intensa Midnight Rider con Sheryl Crow e i Doors convincono in Roadhouse Blues sempre con Vedder alla voce. Nell’ultimo disco Bruce Springsteen è protagonista con la E Street Band di un’energica 10th Avenue Freeze Out e dell’ennesima The Promised Land, prima di duettare con gli U2 in una splendida I Still Haven’t Found What I’m Looking For, forse il brano migliore del triplo. American Girl di Tom Petty non è da meno, come Pink Houses di Mellencamp e la conclusiva Man Of The Moon, nella quale i R.E.M sono affiancati da Eddie Vedder. Un box divertente, sicuramente non indispensabile.
Paolo Baiotti

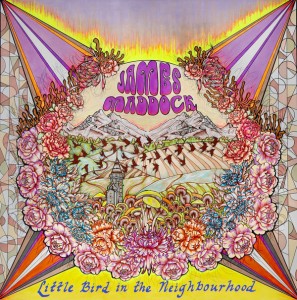
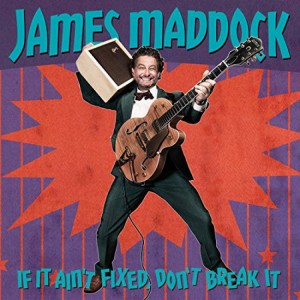
![jamesmaddock_photo_gal__photo_738089493[634] jamesmaddock_photo_gal__photo_738089493[634]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2018/02/jamesmaddock_photo_gal__photo_738089493634-300x300.jpg)