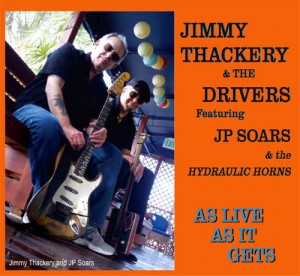Pere Ubu 1995/20..: Verso l’infinito, ed oltre.
di Marco Tagliabue
19 novembre 2013
Fra gli scarsissimi video che un insolitamente così avaro YouTube dedica ai Pere Ubu, è abbastanza facile incappare nella puntata di un David Letterman Show di qualche anno fa con la band di David Thomas, per nulla a proprio agio sotto quei popolari riflettori televisivi, impegnata ad eseguire il proprio brano pop per eccellenza, quella Oh Caterine che, nel tentativo di sospingerlo verso le zone alte delle classifiche, stava trascinando il gruppo verso una nuova, salutare, autodistruzione. Si era più o meno intorno al 1991: l’epoca di “Worlds In Collision”, terzo album del periodo Fontana e secondo tentativo, per fortuna non riuscito, di diffondere il verbo Ubu alle masse. Forse saranno state anche le battute non sempre irreprensibili del sagace anchorman televisivo a far capire a David Thomas che quello non era il suo mondo ed a riportarlo sulla retta via: dopo un lavoro messo insieme alla bell’e meglio l’anno successivo, “Story Of My Life”, il processo di disgregazione della band giungeva a naturale compimento ed il corpulento cantante tornava a rifugiarsi in seno a quella carriera solista che, in quegli anni, costituiva probabilmente la naturale propagazione dell’originale spirito dei Pere Ubu. Un periodo da dimenticare, quindi, quello della seconda incarnazione degli Ubu? Tutt’altro: un grande disco (“The Tenement Year”, 1988), un paio d’album di “pop” di classe (“Cloudland”, 1989 e “Worlds In Collision”, 1991) e quello che rimane probabilmente il punto più basso, ma poi non così rasente il suolo, di una carriera fino a quel momento esemplare, il fiacco “Story Of My Life” (1992). Poi la naturale implosione ed il nulla, quello definitivo? Forse il Re questa volta era morto per davvero, ma per Thomas non si profilava certo la pensione. Titolare di una carriera solista semi clandestina che aveva generato cinque album fra il 1981 ed il 1987, in seguito raccolti nel cofanetto “Monster” (Cooking Vinyl, 1996), più un live addirittura fantasma, quel “Winter Comes Home” di cui il Nostro arriverà perfino a negare l’esistenza, David riscopre una vena più sperimentale con i Two Pale Boys, l’esperienza nata dall’incontro, avvenuto già agli inizi degli anni novanta, fra il leader dei Pere Ubu ed i due polistrumentisti Keith Molinè e Andy Diagram. Il primo album della nuova formazione, “Erewhon” (Cooking Vinyl, 1996), oltre ad essere un disco bellissimo, è il lavoro che definisce l’estetica che ispirerà la vicenda umana ed artistica di Thomas negli anni successivi e che, giusto dodici mesi prima, era anche stata alla base del ritorno in grande stile della più grande Araba Fenice che abbia attraversato i cieli della musica rock.
“Ray Gun Suitcase” (Tim Kerr/Cooking Vinyl, 1995) è il primo, quasi inconsapevole tassello, di quella geografia del “nessun luogo” le cui mappe immaginarie verranno districate da Pere Ubu e Two Pale Boys nel decennio successivo, alla ricerca delle coordinate di un suono speculare ma profondamente distante che ha pochi termini di paragone nella popular music degli ultimi due/tre lustri. “Erewhon è l’anagramma di Nowhere. Si tratta di un album ‘utopico’: erewhon, nowhere, un posto che non esiste. Amo i luoghi, soprattutto quelli che non esistono, ecco perché arriverò a ‘Pennsylvania’ dopo Erewhon. Tutto quanto ha a che fare con la geografia, il suono stesso ha a che fare con la geografia; in particolare i suoni moderni, i suoni dell’era magnetica, hanno a che fare con lo spazio, e lo spazio viene compreso da noi in termini di geografia. Dietro a tutto il rock’n’roll c’è la nozione del suono come geografia. Oggi però le persone vivono progressivamente in luoghi che non esistono, in città che non esistono. I luoghi, le culture del mondo stanno tutti scomparendo, sono tutti Erewhon. Oggi viviamo in un mondo in cui la cultura è stata ridotta alle scelte da fare dentro una boutique, la cultura oggi è comprare un paio di jeans, la cultura è ridotta ad un’unica boutique mondiale. E l’Italia non è più l’Italia, l’America non è più l’America, le persone considerate ‘di cultura’ , quelle che sanno usare bene le parole, sono mentitori. Lo scopo delle parole scritte è mentire alla gente normale, sono un’arma in mano agli ingegneri sociali. L’unica cosa che non può mentire è la geografia, la terra, la tua terra non mente mai. /…/ La mia generazione è l’ultima a potersi definire americana. I ragazzi che hanno meno di tredici anni in America non sono più americani, così come gli italiani che hanno meno di tredici anni non sono più italiani, sono tutti abitanti di un immaginario villaggio globale. Nel villaggio globale non si è più niente, e guarda che non è una critica, è una constatazione. Quindi l’unica cosa che ci collega al passato è la terra, dove ci sono le colline che ti osservano, dove ci sono le montagne che dominano, dove il vento soffia, dove ci sono gli alberi e i frutti, dove cresce l’erba. Tutte queste cose sono le uniche che non ti mentiscono mai. Ecco perché Erewhon-Nowhere.” (David Thomas, da un’intervista a Blow Up, 1997).
La formazione dei nuovi Pere Ubu viene, una volta di più, completamente rivoluzionata: oltre al geniaccio al microfono, il solo Jim Jones, chitarra, proviene dall’esperienza precedente, per il resto una totale rifondazione affidata al basso di Michele Temple, al synth ed al theremin di Robert Wheeler, alle percussioni di Scott Benedict. Fra le comparse un altro ex, Scott Krauss, che suona la batteria in un paio di brani, oltre al violoncello di Garo Yellin ed al basso di Paul Hamann, produttore dell’album insieme a David Thomas. Una copertina che evoca immagini urbane con nome della band e titolo dell’album a caratteri cubitali, come a dire “credete pure ai vostri occhi: siamo tornati!”; qualche nota completamente svasata, a ributtare in primo piano quello spirito nonsense che del resto non aveva mai abbandonato il gruppo, come quella che recita testualmente: “Pubblicammo i testi sul retro copertina di “Song Of The Bailing Man” perché non sapevamo come altro fare per riempire quello spazio/…/Pubblicare i testi è un brutto affare”. Sotto un profilo più squisitamente musicale, “Ray Gun Suitcase” è il convincente compromesso fra la vena melodica degli album precedenti e lo sperimentalismo dei lavori storici della band: una sintesi perfetta, insomma, fra il Mark I ed il Mark II. Ma è soprattutto, come del resto gli altri tre dischi in studio che seguiranno, un album di grande musica. Folly Of Youth è un ottimo inizio: un’atmosfera torbida, cupa e opprimente con il martello di un basso claustrofobico, svisate di synth, la chitarra che mena fendenti, rumori ed effetti, e la voce di Thomas affogata in un ritornello spastico nel magma ribollente degli strumenti in libertà vigilata. La successiva Electricity è uno dei vertici dell’album e della produzione della band: un brano più intimista, protagonista la chitarra, perduta in struggenti crescendo percorsi dalla demoniaca presenza del synth, il basso sempre in primo piano, vero protagonista della base ritmica, ed il canto che raggiunge vette di liricità assoluta. Beach Boys ha invece una struttura più canonica, quella di un rock’n’roll senza particolari guizzi strumentali, eccezion fatta per l’assolo chitarristico centrale, ed un refrain orecchiabile ed accattivante. Turquoise Fins è forse il brano che meglio rappresenta lo spirito dell’album: una marcata componente melodica, pur distante anni luce da certe amenità pop del periodo Fontana, e parti strumentali assai poco convenzionali, quasi deviate, insieme ad una voce insolitamente sgraziata, assai poco accomodante. Vacuum In My Head è un blues lento e stralunato, con una lunga introduzione strumentale ed il canto di Thomas a lambire nuovi mezzi espressivi. Niente batteria, solo qualche percussione sfasata, con il basso a farsi strada ed una chitarra lamentosa in sottofondo. Memphis è un altro rock’n’roll diretto e lunatico mentre Three Things ha una struttura più complessa, aperta a molteplici cambi di atmosfera, in mezzo a frammenti elettronici, impennate ritmiche, piccole giungle strumentali e la voce di Thomas a legare le parti, come si addice ad un Grande Cerimoniere. La misteriosa Horse ha una lunghissima introduzione strumentale per basso e grilli notturni, poi la chitarra sale in un’unica, lunghissima nota tirata allo spasimo per tornare subito dietro le quinte. Avanti senza parole, fra arpeggi delicati e sinistri, in un’atmosfera opprimente che riesce a stemperarsi solo con la successiva Don’t Worry, un rock’n’roll chitarristico percorso da un synth poco rassicurante. Ray Gun Suitcase inizia come una litania perversa, con la voce perduta in un lamento su una base lenta e sconclusionata, per acquistare ritmo e vitalità nel finale, che sfocia in una curiosa cover acustica e ultra rallentata di un brano dei Beach Boys, quella Surfer Girl alla quale Thomas riesce a conferire un’intensità strana insieme alla sua pazza vitalità. Red Sky è una delle vette dell’album: un affascinante gioco di voci fra recitato e cantato, una melodia sottile e circolare che pervade l’intero brano fra continui cambi di tempo e preziose aperture chitarristiche che, nel finale, esplorano gli inediti territori di una psichedelia soffice e vellutata. Montana, primo fra i luoghi ufficiali e non da appuntare sulla cartina geografica, sprofonda in una bellissima atmosfera bucolica con un valzerone folk astratto e visionario, intenso e malinconico, condotto da fisarmonica e strumenti ad arco. My Friend Is A Stooge For The Media Priests è un nuovo rocckettone ironico e potente, mentre la splendida melodia di Down By The River II chiude l’album nella maniera migliore, con una ballata agrodolce di grande efficacia ed intensità.
“La Pennsylvania è uno Stato molto lungo, chiunque voglia andare a New York o sulla costa atlantica deve passare per la Pennsylvania, ma nessuno ci si ferma. Quindi l’album ha a che fare con cose che devi attraversare per andare da qualche parte, posti per cui devi viaggiare per arrivare in qualche altro posto. Questo è il concetto che sta dietro l’album. Pennsylvania è un po’ un altro posto che non esiste, un altro ‘nowhere’. Quando noi parliamo di Pennsylvania sappiamo cosa significa, significa solo un lungo viaggio per andare da qualche parte.” (David Thomas, interv.citata).
E’ una metafora, quindi, di tutti i luoghi di passaggio e, perché no?, forse anche della vita stessa, il secondo atto dei nuovi Pere Ubu. Per “Pennsylvania” (Tim Kerr/Cooking Vinyl 1998), c’è però da registrare anche un’importante novità che riguarda la formazione, la quale, tolto l’avvicendamento dietro le pelli di Steve Mehlman al posto del dimissionario Scott Benedict, rimane praticamente immutata fatto salvo l’ingresso, o meglio il ritorno, di Tom Herman alla chitarra. Proprio lui, uno dei membri fondatori degli Ubu ed uno dei primi ad andarsene, all’indomani di “New Picnic Time”, terzo preistorico album del 1979. Le chitarre raddoppiano, quindi, e graffiano ancora di più, contribuendo a dare all’album una dimensione elettrica abbastanza inusuale, forse proprio a scapito del synth, il cui lavoro è puntuale e perfetto, ma non così centrale come nel lavoro precedente. Una grinta rock per nulla canonica, sia chiaro, ma sghemba e disarticolata come nella migliore tradizione del gruppo. Si può anzi dire che quella bilancia fra spirito melodico e tensione sperimentale i cui piatti erano perfettamente in linea in “Ray Gun Suitcase”, pende ora pericolosamente verso un sound ancora più torbido e claustrofobico, solo occasionalmente tentato dall’attitudine pop dei dischi del periodo Fontana. Ne è un ottimo compendio l’atmosfera perversa ed inquietante dell’iniziale Woolie Bullie: le chitarre stendono tappeti distorti su una base ritmica lenta ed oppressiva, i violenti stacchi dissonanti del theremin straziano il brano ad intervalli irregolari, il canto è un mesto recitativo per un testo che non lascia scampo. “La realtà è definita secondo i desideri dei media/La Storia viene riscritta prima ancora che avvenga/La cultura è un’arma usata contro di noi/La loro cultura è solo una palude di superstizioni, ignoranza e menzogne/La geografia è il linguaggio che loro non possono distruggere/La terra e quello che sappiamo aggiungerle non possono mentire”. Dopo il breve intermezzo acustico di Highwaterville, sono gli affascinanti contrappunti elettrico/acustici di Sad/Txt a destare meraviglia, il suo ritmo quasi in levare sporcato da effetti e rumori d’ogni tipo con la voce di Thomas filtrata in un sussurro. Con la wave disturbata di Urban Lifestyle le pulsioni salgono su un efficace tessuto chitarristico, che un synth scatenato tenta invano di scomporre ed aggrovigliare, mentre la successiva Silent Spring, lenta ed inquietante, costruita su un giro di basso ossessivo dal quale, come i tentacoli di una piovra, si dipanano gli altri strumenti in piccole fughe improvvisative, sprofonda in un’atmosfera oscura e sperimentale, con i toni perversi della voce di Thomas che non fanno altro che aumentare la tensione. Mr. Wheeler prosegue nella stessa scia densa e melmosa, in una dimensione che poco o nulla concede alla forma canzone, con i medesimi ingredienti opportunamente miscelati, mentre con Muddy Waters l’album riacquista una forma più umana, grazie ad una più canonica cavalcata elettrica che, seppur non esente dai soliti elementi di disturbo, vede le chitarre girare a mille e portarsi dietro tutti gli altri strumenti. Seguono Slow, un angosciante break strumentale fra tastiere ed inserti elettronici, e Drive, con le chitarre che sfrigolano e pungono su un fondale sintetico abbastanza inquietante e la voce di Thomas che si sforza di dare un senso lirico al tutto. Dopo il breve bozzetto strumentale di Indian Giver, tocca alla splendida Monday Morning scomodare ingombranti fantasmi del passato, forse addirittura quello di 30 Seconds Over Tokyo. Con Perfume la voce di Thomas recita, quasi spaurita, su una fragile base strumentale, fra tappeti sintetici, effetti ed interferenze varie, mentre in Fly’s Eye (che secondo una dichiarazione dello stesso Thomas sarebbe stata scritta per Kylie Minogue, ma sarà vero?) sceglie un refrain vincente in una scarica di genuino rock’n’roll. Con The Duke’s Saharan Ambitions, invece, il Narratore diventa muezzin e libera la sua litania per un’incredibile the nel deserto. Tocca a Wheelhouse dare l’illusione che il disco sia finito, con un brano lungo e coinvolgente perfetto compendio di tutti gli elementi del suono Ubu, prima di liberare, dopo una manciata di secondi d’attesa, tutta la magnificenza della ghost track. Gli oltre quindici minuti di My Name Is…partono come un bluesaccio sporco alla Tom Waits per sfociare, dopo uno stacco netto, nelle atmosfere liquide ed ossessive di affascinanti strati di tastiere a mezza strada fra i Doors ed i Neu!.
“Se si va a nord sull’highway 61, l’Arkansas è dalla parte opposta. Il punto di vista di St. Arkansas è quello della testa voltata di lato, delle parole sussurrate all’orecchio, di posti visti mentre corri a testa bassa.” (note di David Thomas dal sito internet del gruppo)
Ideale completamento di quel trittico ispirato alla geografia del “nessun luogo” iniziato nel 1995 con il grande ritorno di “Ray Gun Suitcase”, lo svincolo di “St. Arkansas” (Glitterhouse, 2002), perfetto crocevia per tutte le strade che conducono in un luogo immaginario, è anche la prima porta che i Pere Ubu aprono nel nuovo millennio. Ed è evidente al primo ascolto che, nonostante siano passati quasi trent’anni dal debutto, poche cose suonano fresche, eccitanti ed innovative come la musica di questa band; che nel duemila, come del resto probabilmente anche nel tremila, ci sarà ancora un dannato bisogno di loro. Formazione praticamente immutata rispetto a “Pennsylvania” con il solo Jim Jones un po’ defilato rispetto al resto del gruppo in cui compare solo come ospite, probabilmente a causa dei problemi di salute che si fanno sempre più pressanti e di quel cuore matto che se lo porterà via, nell’indifferenza generale, nei primi mesi del 2008. Copertina zeppa di segnali stradali, numeri di autostrade e indicazioni per raggiungere luoghi che non esistono, uno dei quali porta anche il nome della band. Nello smilzo package del CD trova anche posto, corredata da deliziose foto vintage, un’affascinante ma strampalata teoria secondo la quale il nostro cervello riceve le sollecitazioni acustiche da sinistra a destra, quindi, per un ascolto ideale, è necessario posizionarsi più vicini alla cassa destra. E la musica? Parafrasando i Rolling Stones si potrebbe dire che It’s Only Pere Ubu. Sarà pure rock’n’roll e basta, insomma, ma nulla suona come loro. Tocca a The Fevered Dream Of Hernando De Soto aprire l’album con un basso vorticoso che si porta dietro tutti gli strumenti, il synth che sbuffa, la chitarra che punge e sfrigola qua e là, la voce di Thomas insolitamente “sana” in una melodia che colpisce e spiazza al primo ascolto. Slow Walking Daddy è un bluesaccio tutto giocato sui tasti, con il synth come elemento di disturbo, che con il volgere dei minuti si arricchisce di campanelli e percussioni, echi e rifrazioni, di una melodia facile ma non banale. Michele mostra almeno due anime nel violento stacco di atmosfera fra le parti cantate, voce calda e carezzevole sommersa da una valanga di effetti, e le stordenti aperture strumentali, protagonista una chitarra con pochi freni inibitori. 333 rientra in canoni più tradizionalmente rock, mentre Hell sfodera un ritmo esasperatamente lento tutto giocato sui piatti, qualche battuta scoordinata sulle pelli, le tastiere a stendere tappeti disarmonici e la voce di Thomas, un recitativo su toni molto bassi, a coordinare il disordine. Lisbon inizia come un synth pop deviato, un ritmo lento con qualche impennata, tetri fondali di tastiere e intermittenze elettroniche a rendere l’atmosfera ancora più malsana: una spirale sempre più perversa che sembra convergere tutto a sé. Steve vede la chitarra tornare protagonista in un brano dalla forte impronta blues: un blues secondo il vangelo Pere Ubu, naturalmente, con qualche rifrazione industriale ed un costante inquinamento elettronico. Phone Home Jonah è un rock’n’roll tirato, mentre con Where’s The Truth il ritmo torna a rallentare, l’atmosfera ad intorbidirsi sulle pulsioni di un basso paludoso e di un synth che sbuffa e fa le linguacce dietro le spalle. I quasi dieci minuti della monumentale Dark chiudono l’album con uno dei capolavori degli Ubu di sempre: un lungo mantra circolare con una superba melodia che continua ad avvitarsi su se stessa, portandosi dietro tutti gli strumenti in un vortice che sembra non avere mai fondo, in una progressione convulsa che si vorrebbe, magicamente, prolungare oltre ogni limite.
“L’idea di ‘Why I Hate Women’ era quella di rendere in musica un romanzo di Jim Thompson che Thompson non ha mai scritto; è un disco ossessivo, ma la migliore musica rock è brutalmente ossessiva” (note di David Thomas dal sito internet del gruppo)
Altri quattro anni e l’ennesimo cambio nella formazione, che vede ora alla chitarra Keith Moliné, già accanto a Thomas nei Two Pale Boys, per avere fra le mani “Why I Hate Women” (Glitterhouse, 2006), quello che nel momento in cui scriviamo –agosto 2009- è l’ultimo lavoro a firma Pere Ubu (ma il sito del gruppo annuncia novità imminenti) e quello che, senza mezzi termini, è uno dei tre, massimo quattro, dischi più belli dell’ormai sterminata discografia della band. In un lavoro di cui l’ossessione è dichiaratamente il tema principale, gli ingredienti dell’Ubu sound sono più o meno sempre i medesimi, ma l’insieme, il corpo principale, raramente è stato così diretto, unitario ed efficace. Il loro avant-rock ormai più che trentennale, insomma, riesce tranquillamente a farsi beffe delle schiere di ragazzini che affollano i-pod e download illegali, che danno da mangiare a MTV, che riempiono del nulla tonnellate di carta stampata oltre, naturalmente, alle orecchie di tanti ascoltatori. Lo strumento principe di “Why I Hate Women” torna, incredibilmente, ad essere il synth/theremin di Robert Wheeler, la cui presenza, oltre ad essere costante ed ossessiva, è in molti casi davvero prioritaria nell’economia di un suono continuamente sfregiato, appesantito, cosparso di un bitume tossico e radioattivo da quei tasti che dai gloriosi tempi dello scienziato pazzo Allen Ravenstine non erano mai stati così “pesanti”. Two Girls (One Bar) è un’apertura squillante: un ritmo convulso sulle corde del basso, frange chitarristiche in sottofondo, un synth che sbuffa e freme, la voce di Thomas come sempre in gran spolvero in una melodia sottilmente malinconica. Babylonian Warehouses è già un attacco al cuore: un brano intenso, disturbato e disturbante su un ritmo lento e convulso, la chitarra che puntella, le evoluzioni del theremin in primissimo piano a dipingere pareti torbide ed evocative al tempo stesso, il canto filtrato in una melodia nostalgica. Blue Velvet è ancora più lenta, ancora più tossica, ancora più intensa, con Wheeler che cerca di strappare lacrime da una roccia e Thomas mai così vicino alla disperazione. Con Caroleen riesplodono ritmo ed energia in un punk rock percorso da una voce scorticata e da un theremin impazzito, mentre Flames Over Nebraska è un wave rock perverso inzuppato dal synth disturbato e malefico che sembra fagocitare, insieme a tutto il resto, anche una melodia gioiosa e accattivante. In Love Song il ritmo si placa, ma la tensione aumenta sulle ali del solito theremin, che si frappone fra musica e parole lasciando la sua maleodorante scia, creando un’atmosfera talmente carica da sembrare sempre sul punto di esplodere. Mona è un brano breve e veloce con il fantasma di Ravenstine mai così vivido e presente, e My Boyfriend’s Back concentra, in uno spazio ancor minore, rabbia ed energia che farebbero invidia a molti nipotini. Stolen Cadillac fa il paio con Babylonian Warehouses quanto a grigiore, intensità, pazzia e perversa bellezza, mentre in Synth Farm, che omaggia fin dal titolo il protagonista del disco, la presenza dello strumento è più discreta, quasi un supervisore occulto, ma ci pensano percussioni e rintocchi vari, disordinati sbuffi di sax e rifrazioni industriali a rendere l’atmosfera opprimente e malsana. Tocca a Texas Overture sancire un album da trionfo con un blues rock sporco e disarticolato alla maniera dei Nostri, una lunga disquisizione quasi rappata con le controverse ragnatele del synth a dare anima e spessore al brano, lasciando alzare la testa alla chitarra solo nei lunghi assoli in chiusura.
“Il giorno che comporrò un album di cui potrò dirmi pienamente felice sarà il giorno in cui deciderò di fermarmi.” (David Thomas, da un’intervista a Sentireascoltare.com)
Confidando nella proverbiale meticolosità, nel ricercato perfezionismo del leader dei Pere Ubu, pensiamo che quel giorno sia ancora lontano, appuntamento quindi fra quindici anni per la quarta parte della loro storia. Nel frattempo nessuno si scandalizzi se chi scrive è sempre più convinto che, per longevità artistica e qualità compositiva, i Pere Ubu siano la più grande rock band di tutti i tempi. Con tanti saluti a Beatles, Rolling Stones e chi volete voi…
da LFTS n.97