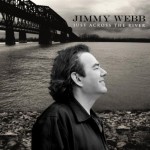BETTYE LAVETTE
Thankful ‘n’ Thoughtful
Anti 2012
La storia di questa cantante afroamericana dovrebbe esservi nota: Bettye Lavette, le cui prime registrazioni risalgono agli anni sessanta, è stata riscoperta e rilanciata con la dovuta attenzione solo nella seconda metà del nuovo millennio, grazie all’etichetta olandese per cui sta continuando ad incidere. Ovviamente i fari si sono riaccesi su di lei, sono stati rispolverati e messi in circolazione molti suoi nastri degli anni settanta, il tutto sull’onda della riscoperta. Questo disco è l’ultimo tassello della rinascita artistica di questa potente cantante dalla voce impregnata di umori neri. Il disco è ben fatto, ben prodotto, lei canta sempre all’altezza della situazione e il risultato, se non fantastico è pur sempre su buoni standard, vuoi per l’accuratezza della scelta dei brani, vuoi per la produzione di Craig Street o per l’accompagnamento di una band ridotta e senza troppi fronzoli tra cui spicca alla chitarra il grande Jonathan Wilson. A ben vedere questo disco tutto è, fuorché un disco di soul music, ma di anima ce n’è talmente tanta nella voce della protagonista che basta a catalogare il prodotto. Si comincia con una bella interpretazione di Everything Is Broken, Dylan deve aver sicuramente apprezzato, e si finisce con Everybody Knows This Is Nowhere (la Lavette aveva già messo la sua voce su un altro classico di Neil Young quando negli anni settanta aveva inciso un’ottima versione di Heart Of Gold). Di notevole spessore è la classica Dirty Old Town (presente anche come bonus track in versione ancor più lenta e lunga, forse troppo), e tra le cose più riuscite c’è la rilettura di Crazy (proprio quella di Gnarls Barkley che ha spopolato qualche anno fa come tema di uno spot televisivo), che diventa una lenta ballata. The More I Search The More I Die è un brano molto intenso trapuntato dal banjo di Wilson e da un organo intrigante. Meno riuscita forse è la resa di Yesyerday Is Here di Tom Waits, meglio I’m Tired col suo treno di batteria e la chitarra a dare la giusta marcia alla canzone.
Paolo Crazy Carnevale

LORENZO BERTOCCHINI
Live At Sidewalk Cafè
GOMB Pirate Series 2007
Risale a un po’ di anni fa questo live americano di Lorenzo Bertocchini, frontman della band varesotta degli Apple Pirates, si tratta della testimonianza di un breve tour (otto concerti in tutto) che questo artista ha fatto negli Stati Uniti alla fine del 2006, nella fattispecie, il disco è la cronaca di una gustosa serata in un piccolo club di New York, in cui il pubblico americano sembra apprezzare questa performance in stile folksinger/songwriter che Bertocchini infarcisce di divertenti brevi intermezzi tra un brano e l’altro. La musica è quella dei cantautori americani che stanno un po’ alla base dei gusti musicali di questo cantante/chitarrista/armonicista che in tempi più recenti ha realizzato anche un personale tributo a Bruce Springsteen. Le canzoni di Bertocchini sembrano tutte uscire dalla penna di uno qualsiasi dei suoi ispiratori – e forse proprio questo è il loro limite – ma sono comunque apprezzabili, in un caso, Sittin’ On The Throne, una quasi talking song che sembra più un tormentone stile La Balilla o La famiglia dei gobboni, la matrice si distacca notevolmente dai cliché nordamericani e il pubblico sembra apprezzare ancor più. Poi c’è l’ospite d’onore, la cantautrice Ruth Gerson, probabilmente più nota in Italia che in patria, che in un paio di occasioni duetta con Bertocchini e non mancano alcune cover che funzionano sempre in una serata da club: la dylaniana Forever Young (uno dei duetti con la Gerson), That’s The Way That The World Foes Round di John Prine, Marie Marie dei Blasters, Something Like Steve McQueen di Elliott Murphy e I Tried To Be True di Will T.Massey. In tutto questo le composizioni originali finiscono un po’ col perdersi perché per forza di cose, quando si assiste a uno spettacolo di questo genere, o si ascolta il disco da esso tratto, se il materiale non originale è troppo e di tale portata si rischia di non accorgersi di quello autografo che comunque – ascoltare Always On My Mind per credere – mantiene una sua dignità.
Paolo Crazy Carnevale

VINCENZO COSTANTINO CINASKI
Smoke (Parole senza filtro)
Autoprodotto Gibilterra/Venus 2012
Cinaski, nato Vincenzo Costantino, vede la luce nelle sinuosità milanesi intorno all’anno 1964 e di lui serbiamo un singolare e appassionante ricordo di quando si dilettava a battere tasti della sua macchina per scrivere alla mo’ di carbonaro nei sottosuoli del capoluogo lumbard. All’età di trent’anni come accadde ai più noti fratelli del Blues vede la luce conoscendo l’asceta Vinicio col quale dopo nottate, crediamo, a parlare e raccontarsi scivolano via quasi in clandestinità a vergare un libro a venti dita che Feltrinelli editerà non sappiamo se in clandestinità. Ci sovvien voce che dopo “In Clandestinità”, questo era il titolo del libro propenda per una raccolta di poesie più underground di quanto non fosse il periodo conclusivo delle vicende di Jean Valjean quando vagava, ma con idee ben precise, nei sottofondi di Parigi. Ma da tali meandri sviscera, stavolta a dieci dita (delle mani) un singolare Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare che rivela già dal suo anticonformista ma acuto titolo dove il personaggio voglia andare a parare o a sfruculiare e… se tanto nella vita a volte da tanto riscuote un eccellente successo di vendite. La strada lo porta a frequentare Folco Orselli, a perorare le sue cause poetiche per anni in notturni, una volta avremmo detto fumosi, ora non si può più, locali milanesi assieme a una band giustamente titolata Caravanserraglio che ben rende l’idea del profondo percorso sostenuto. E da lì localini, osterie, forse sottoscala o stanze nascoste di vita quotidiana. Insomma, un nugolo d’anni e un effluvio di posti a portar idee, poesie, inventive, anche invettive perché no, sin a conoscere il figlio di John Fante tal Dan, ovviamente Fante, suo grande fan d’oltreoceano che lo esorta a continuare a portarsi sera dopo sera a sviscerare le sue visioni miste sempre a grande poesia e ad eccelsi pensieri. Questo percorso di sudore e vitalissima energia ce lo consegna oggi con un lavoro che se ha sempre dalla sua i cardini della poesia, vengono qua però espressi in tal contesto musicati in supporto fonografico, oggi dicasi volgarmente CD, ma un tal lavoro avrebbe meritato solchi e spazi del vecchio buon vinile. Trattasi quindi non di un CD di canzoni ma di poesie musicate e recitate tutte bagnate di autoproduzione ove trovano mirabilmente posto a perfetto incastro due tasselli di Leonard Cohen e Pete Seeger che nobilitano un lavoro che già di suo raggiungeva vertici di nobile, nobilissima caratura.
Tra gli ospiti ubicati qua e la dal Cinaski in deferente e stimato aiuto troviamo Simone Cristicchi, Raffaele Kohler e naturalmente VinicioCapossela.
Non citiamo alcun titolo poiché tutti interessanti e profondamente coinvolgenti e meritori non tanto d’esser citati ma ascoltati.
Ronald Stancanelli
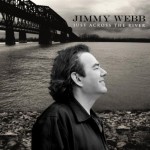 JIMMY WEBB
JIMMY WEBB
Just Across The River
E1 2010
Penso che per i più il nome di Jimmy Webb sia un nome di nicchia, per molti forse uno sconosciuto, tutt’al più un autore di canzoni portate in giro da altri artisti. A ben vedere molto probabilmente è vero, le sue canzoni hanno avuto maggior successo nelle mani di altri autori, a partire da quel Richard Harris – più noto come attore che come cantante – che alla fine degli anni sessanta ha realizzato (proprio quando il mondo lo scopriva come uomo “chiamato cavallo”) un paio di dischi basati su composizioni firmate da Webb. Che dire, persino i nostri Nomadi hanno avuto modo di cimentarsi con una delle canzoni più celebrate di Webb, Wichita Lineman (un successo per Glen Campbell ripreso anche da Johnny Cash nelle sue session per l’American Recordings), facendola divenire l’improbabile L’auto corre lontano ma io corro da te. A testimonianza del grande apprezzamento di cui Webb gode come autore, è uscito, poco più d’un paio di anni fa, questo grande disco in cui il nostro si misura con alcune delle sue più belle composizioni accompagnato qua e là da illustri colleghi e amici che gli danno una mano a rispolverare e far brillare nuovamente le sue perle. Il risultato è incredibile, tanto da rendere il disco uno di quei dischi da avere, da ascoltare, in particolare in queste fredde serate invernali, complici il calore delle canzoni, la calda voce di Webb e dei suoi amici e la bellezza delle composizioni che a distanza di anni non hanno perso una virgola dello smalto originario. Niente super produzioni dietro le quinte, solo suoni sani e vivi; Webb e la sua band rileggono Oklahoma Nights con l’aiuto di Vince Gill, Wichita Lineman insieme a Billy Joel, By The Time I Get To Phoenix con Glen Campbell. Lucinda Williams si unisce a loro per una spettacolare Galveston mentre Jackson Browne ci mette del suo per dare del lustro ad una formidabile P.F. Sloan – resa celebre a suo tempo da Johnny Rivers. E ci sono anche Linda Ronstadt e J.D. Souther, mentre Willie Nelson con la sua voce troppo di naso non mi convince in If You See Me Getting Smaller. Per contro è molto bella Highwayman in cui il protagonista del duetto e un motivato Mark Knopfler che, oltre alla voce, presta a Webb anche la chitarra. La voce di Webb si sposa sempre molto bene con quelle di tutti gli ospiti, tra i quali figura anche Michael McDonald, proprio nella canzone da un cui verso è tratto il titolo del disco.
Paolo Crazy Carnevale

TAG MY TOE
This Fear That Clouds Our Minds
Autoprodotto 2012
Interessante il risultato dell’abbinamento musicale che questo gruppo piemontese ha ottenuto con la sua proposta in chiave acustica contenuta in questo CD. Infatti, il modo di cantare di Fabrizio Zortea, debitore ai vari modelli hard rock/heavy metal a cui chiaramente si rifà, nella veste acustica in cui i brani sono presentati, apre in qualche modo orizzonti musicali molto lontani da questi generi musicali. Il gruppo, nato qualche anno fa come quartetto ispirato da Black Sabbath e Alice In Chains, si è presto ridotto ad un duo di cui Zortea divide le sorti con il chitarrista Riccardo Stura e ora mette sul piatto, o meglio nel lettore Cd, undici tracce autografe e autoprodotte che si fanno apprezzare per l’originalità del progetto e per la bontà di alcune delle composizioni. Del modo di cantare di Zortea ho già detto, ma mi sembra opportuno ribadire ulteriormente come questa voce (doppiata da sé stessa in alcuni punti) sia la principale caratteristica del prodotto, con una chitarra acustica che va ad inserirsi rispettosamente, a volte come semplice accompagnamento altre facendo qualcosa in più: quello che ascoltiamo ricorda a tratti certi cantautori oscuri degli anni settanta, dotati di vocalità particolare e presto caduti nel dimenticatoio (mi viene in mente tale Darius, ma anche Leopold Perry), e la chitarra quando non è mero accompagnamento rilascia degli interventi molto western, come accade nella traccia quattro, If God, uno dei momenti migliori del disco. Tra gli altri brani più interessanti di questo debutto dei Tag My Toe, ci sono il brano d’apertura Something Wicked This Way Comes, My Destiny Is Gone e 45 Rounds e lo strumentale 780.
Paolo Crazy Carnevale