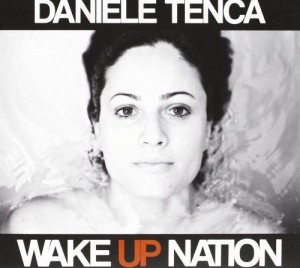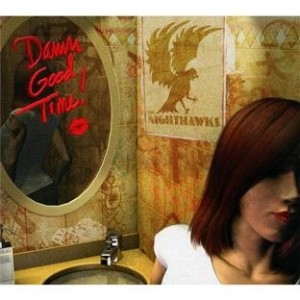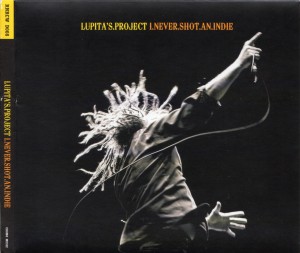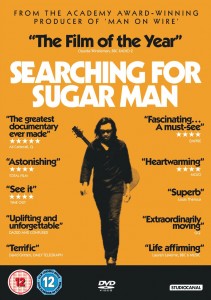Rock & Pop, le recensioni di LFTS/23
di Paolo Baiotti
20 marzo 2013
AEROSMITH
Music From Another Dimension
Columbia 2012
Riepiloghiamo il nuovo millennio degli Aerosmith: un mediocre disco in studio (Just Push Play ’01), un discreto disco di covers (Honkin’ On Bobo ’04), un live appena decente (Rockin’ The Joint ’05), tante raccolte più o meno inutili, un po’ di concerti e soprattutto tante parole e tanto gossip. Protagonista assoluto il cantante Steven Tyler: tra ricadute in vecchi vizi e periodi di riabilitazione, cadute dal palco, partecipazione da giudice a talent shows e dichiarazioni avventate non si è privato di nulla. In questi anni si è più volte parlato di scioglimento, il chitarrista Joe Perry ha pubblicato due dischi solisti non indimenticabili mentre Tyler si è limitato ad un singolo, ma alla fine la band è tornata in studio con l’esperto Jack Douglas alla produzione. Nella scrittura si nota la presenza di molti coautori esterni, più vicini al rock radiofonico che all’hard rock, circostanza che mi ha fatto dubitare: in fondo dopo più di dieci anni qualche buon brano pronto Tyler e Perry avrebbero dovuto averlo. Dubbi confermati dall’ascolto del disco, troppo lungo e con alcuni brani che potevano essere tralasciati. Ma il problema di fondo è la sensazione che si tratti di un album forzato, quasi di una caricatura degli Aerosmith che cercano di riprodurre il loro suono senza avere particolari stimoli e creatività. Alla fine sono pochi i brani hard rock convincenti: la stonesiana Oh Yeah, classico rock di Joe Perry, Out Go The Lights tra rock e funky con un bel riffone e la trascinante Lover Alot. Meno brillanti l’opener Luv XXX, la rappata Beautiful, la dura e veloce Street Jesus confusa nel suo sviluppo, la stradaiola Freedom Fighter scritta e cantata da Perry senza fantasia, il singolo Legendary Child e Something, un pasticcio tra blues e Beatles. E poi ovviamente ci sono le ballate che non guastano, anche perché Tyler le interpreta molto bene, ma hanno un sapore di già sentito, come Another Last Goodbye con voce e piano in primo piano, Tell Me che profuma di anni novanta e We All Fall Down composta dall’esperta Diane Warren, mentre Can’t Stop Lovin’ You, duetto con la cantante country-pop Carrie Underwood, è troppo zuccherosa. L’edizione deluxe aggiunge un secondo cd con tre brani non certo indispensabili (erano già troppi gli altri quindici) e un dvd molto carino con quattro tracce registrate dal vivo e interviste ai musicisti della band. Spero che non sia l’ultimo disco in studio degli Aerosmith, non sarebbe una conclusione degna di una carriera formidabile.
DANIELE TENCA
Wake Up Nation
Route 61 Music 2013
Se la crescita del roots rock italiano è sotto gli occhi di tutti, Daniele Tenca è sicuramente uno degli artefici di questa ondata di artisti e bands che comprende Lowlands, W.I.N.D., Mojo Filter, Cheap Wine, Francesco Piu, Nerves & Muscles e tanti altri. Autore e chitarrista milanese inizialmente ispirato da Bruce Springsteen e dal blues, ha gradualmente ampliato il suo raggio d’azione con Blues From The Working Class seguito dall’eccellente Live From The Working Class ed ora da questo Wake Up Nation, un disco che cerca davvero di svegliare un paese (il nostro) cloroformizzato da vent’anni di false promesse, di politica ridotta a scambio di favori, di veline promosse ad altri ruoli, mentre una crisi sempre più forte massacra la maggior parte della popolazione. Per Tenca i testi sono importanti quanto la musica, influenzano il suono e l’atmosfera delle canzoni, sono veramente imprescindibili. In Wake Up Nation testi crudi e taglienti parlano di immigrazione, paparini che creano a loro piacimento nuove regole, persone che non si riconoscono più in una nazione alla quale sono stati rubati il cuore e l’anima e che devono risvegliarsi facendo qualcosa invece di lamentarsi sul social network. E le musiche rispecchiamo questa durezza con un rock blues aspro nel suono della slide, dei boogie incalzanti e un tosto roots rock venato di folk che richiama Mellencamp e lo Springsteen acustico. Accompagnato da una band solida ed affiatata formata da Leo Ghiringhelli alla chitarra, Pablo Leoni alla batteria, Luca Tonani al basso e Heggy Vezzano alla batteria, Tenca canta in modo caldo e appassionato suonando slide ed elettrica con bravura indiscussa ed appare sempre più consapevole della forza della sua musica. Tra i brani di un disco uniforme nella sua compattezza citerei l’opener acustica Dead And Gone che ci riporta al blues prebellico, il fluido roots rock di Big Daddy, il blues di What Ain’t Got con l’armonica di Andy J. Forest e la morbida Silver Dress. In questo contesto si inseriscono alla perfezione le tre covers: il blues Last Po’ Man di Seasick Steve, la ritmata It’s All Good del maestro Dylan e l’acustica Society già interpretata da Eddie Vedder nella colonna sonora di Into The Wild. Un disco di denuncia forte e rigoroso che cresce con gli ascolti.
LOWLANDS
Better World Coming
Gypsy Child Records 2012
Beyond
Gypsy Child Records 2012
Nati a Pavia e guidati da Ed Abbiati (italo-inglese con varie esperienze all’estero), in pochi anni i Lowlands sono diventati una delle band italiane di roots rock più apprezzate. Ispirati da gruppi come Wilco, Whiskeytown, Green On Red e Waterboys, hanno esordito con The Last Call, seguito da Gypsy Child. L’anno scorso hanno pubblicato ben due dischi: il primo è un interessante omaggio a Woody Guthrie, registrato quasi per divertimento con l’aiuto di altri musicisti della scena locale, il secondo è il duro e trascinante Beyond. Partiamo da Better World Coming, un album fresco e godibile che ha il merito di riproporre non solo i brani più famosi, ma anche tracce meno conosciute del grande cantautore folk americano, registrato prevalentemente con strumenti acustici dal nucleo della band formato dal leader Ed Abbiati (voce e chitarra), Francesco Bonfiglio (piano, organo, accordion) e Roberto Diana (chitarra, dobro) con partecipazioni sempre funzionali al progetto. Tra le undici tracce spiccano un’intensa e drammatica This Train Is Bound For Glory, una dolente I Ain’t Got No Home, la meno conosciuta More Pretty Girls resa come un’outtake di Tom Waits, la delicata ballata Better World Coming, Two Good Men venata di sapori irlandesi e la corale Deportee. Gli arrangiamenti sono semplici ed efficaci, con un utilizzo sobrio di dobro, fisarmonica e chitarra acustica, mentre la voce roca di Abbiati dimostra sufficiente duttilità e sensibilità nell’interpretare il repertorio di un’icona della musica americana.
Beyond è il vero terzo album in studio prodotto da Joey Huffman, amico della band ed ex tastierista di Soul Asylum, Matchbox Twenty e Drivin ‘n’ Cryin, session man ed esperto ingegnere del suono che contribuisce a dare un suono degno di una produzione internazionale. Accompagnati da una sezione ritmica esperta e affiatata formata da Robby Pellati alla batteria e Rigo Righetti al basso (entrambi ex Rocking Chairs e Ligabue) i Lowlands dimostrano ulteriori progressi, pubblicando un disco compatto, energico, pieno di grinta e rabbia. Un roots rock di matrice americana con venature folk e irish, pieno di melodie corali che restano in testa, ma con la rabbia del punk (l’opener Angel Visions è puro punk). Abbiati è un songwriter in grado di colpire sia con brani ritmati come le intense e trascinanti Keep On Flowing e Lovers And Thieves profumate di irlanda e con la springsteeniana Hail Hail, sia con ballate folk come Ashes e l’acustica Homeward Bound. Ma anche il complesso e drammatico mid-tempo Waltz In Time e il crescendo irresistibile di Down On New Street sono interpretati con bravura e sensibilità. Da citare anche la title track Beyond, riflessiva e notturna anche nel testo e la sofferta Fragile Man, quasi sussurrata da Ed, arrangiata con un impasto di fisarmonica e violino di rara efficacia.
NERVES & MUSCLES
New Mind Revolution
Holdout‘n’Bad 2012
Sono convinto che ascoltando questo album senza conoscere i musicisti nessuno immaginerebbe che dietro alla sigla Nerves & Muscles non si nascondono dei bluesmen del Mississippi o dell’Alabama, ma un gruppo di esperti musicisti italiani. Questa è la realtà! Max Prandi (batteria e voce), Angelo “Leadbelly” Rossi (chitarra e voce), Tiziano Galli (chitarra), Milena Piazzoli (voce), Marcus Tondo (armonica) e Joy Allucinante (basso) con l’aiuto di Paolo Cagnoni (ideatore, produttore e coautore di numerosi brani) hanno inciso un disco di blues sudista formidabile, come se ne ascoltano pochi di questi tempi. Blues acustico ed elettrico che sembra uscito dagli Zebra Ranch Studios dei fratelli Dickinson, con forti richiami al gospel e alle contaminazioni africane, con testi significativi da leggere con attenzione, un suono che non ha niente da invidiare a produzioni milionarie e una confezione in digipack molto curata. Il livello dei brani è elevato, non ci sono momenti di stanca o riempitivi. Ma una citazione la meritano Nerves & Muscles, un blues memore della lezione di R.L. Burnside, l’aspro boogie hookeriano Ask The Dusk, la deliziosa filastrocca Frankie And Isabel che si trasforma in un gospel percorso dalla voce di Milena Piazzoli, Black Line con una chitarra cooderiana, la title track aspra nel suono e nel testo che racconta la situazione drammatica della nostra società, l’esemplare blues White Flowers On Your Dress, la sofferta Over My Poor Bones interpretata ottimamente dalla voce di Prandi e dalle chitarre di Galli e Rossi e il gospel Searching My Salvation. Un disco sorprendente anche per chi conosce la qualità dei musicisti coinvolti, a dimostrazione che un lavoro di squadra può raggiungere risultati superiori alla somma delle individualità.
LYNYRD SKYNYRD
Last Of A Dyin’ Breed
Roadrunner 2012
Giunti al settimo album in studio dopo la reunion dell’87, da aggiungere ai cinque della formazione originale degli anni ’70 prima dell’incidente aereo dell’ottobre ’77, non contando le innumerevoli compilations, ristampe più o meno deluxe e i dischi dal vivo, tutte testimonianze di un popolarità leggendaria, gli Skynyrd proseguono imperterriti nella loro carriera, funestata da tragedie pari o superiori al grande successo ottenuto. Ma oggi bisogna porsi una domanda che, a dire il vero, già da qualche anno aleggia sul gruppo: ha senso continuare, soprattutto con dischi inediti, mantenendo il nome quando della formazione originale è rimasto il solo chitarrista Gary Rossington (anche lui con problemi di cuore)? Dopo Gods & Guns del ‘09, disco ancora accettabile con alcuni spunti notevoli, ci hanno lasciato il tastierista originale Billy Powell (un tassello indispensabile della formazione) e il giovane bassista Ean Evans che a sua volta aveva sostituito il deceduto bassista originale Leon Wilkeson. Oggi lo zoccolo duro oltre a Rossington comprende il cantante Johnny Van Zant, fratello di Ronnie, presente dalla reunion e il chitarrista Rickey Medloke, ex leader dei Blackfoot che ha fatto parte per un breve periodo della formazione originale ed è tornato nel ’97. Gli altri sono il batterista Michael Cartellone, il chitarrista Mark Matejka, il tastierista Peter Keys e il bassista Johnny Colt (ex Black Crowes). Il problema è che questi musicisti, a parte Colt, sono più adatti ad un hard rock radiofonico che al southern rock venato di blues e di country degli Skynyrd. Se aggiungiamo l’aiuto di musicisti esterni che di southern hanno poco (dai produttori Bob Marlette e Tom Hombridge ai chitarristi John 5 e Marlon Young) il risultato è un inevitabile appesantimento del suono e un avvicinamento ad un rock spersonalizzato che non rende onore alla storia della band. Intendiamoci, se fosse un gruppo qualunque a pubblicare questo disco, si potrebbe essere soddisfatti, ma dai Lynyrd Skynyrd mi attendo qualcosa di diverso da brani scontati come Good Teacher, la title track Last Of A Dyin’ Breed, la cadenzata Nothing Comes Easy o la dura Homegrown. Qualcosa di meglio c’è come Mississippi Blood, la potente Honey Hole, le ballate Something To Live For e Ready To Fly (composta con Audley Freed) nelle quali spicca l’ottima voce di Van Zant e la conclusiva Start Livin’ Life Again. Sono disponibili anche una deluxe edition con quattro brani aggiunti e un’edizione speciale inglese unita alla rivista Classic Rock con un paio di tracce live inedite. Ma la sostanza non cambia; purtroppo Last Of A Dyin’ Breed è un disco fondamentalmente inutile.
JOHNNY NEEL
Every Kinda’ Blues
Silverwolf 2012
Nato a Wilmington in Delaware, cieco dalla nascita, Neel ha esordito con un singolo a dodici anni; qualche anno dopo ha formato la Johnny Neel Band, spostandosi a Nashville nell’84. Session man molto conosciuto, entra nella Dickey Betts Band e poi negli Allman Brothers, partecipando come secondo tastierista, armonicista e compositore a Seven Turns, l’album della reunion ed al successivo tour. Tornato alla carriera solista scrive per John Mayall, Montgomery Gentry e Delbert McClinton, registra alcuni dischi, partecipa alla formazione dei Blue Floyd con Marc Ford, Allen Woody e Matt Abts ed agli X2 con Abts (batterista dei Gov’Mule). Negli ultimi anni ha collaborato in studio e dal vivo con l’eccellente band friulana dei W.I.N.D. Every Kinda’ Blues è l’ottavo disco in studio del tastierista ed è anche uno dei migliori. Registrato a Nashville con l’aiuto, tra gli altri, di Jack Pearson alla chitarra, Daryl Burgess alla batteria e Shawn Murphy (Little Feat) ai backing vocals, è un album impregnato di blues, soul e gospel, con ballate convincenti e qualche up-tempo di buona qualità, che evidenziano la voce piena di anima di Neel e il suono caldo del suo hammond. Non mancano un paio di tracce meno ispirate come la title track, il soul-rock alla Delaney & Bonnie di Right Out The Window e la molle I Wanna Know The Way, riscattate dalla jazzata I’m Gonna Love You, dalla superba ballata sudista Sunday Morning Rain (ottima voce, organo perfetto e slide suadente di Jack Pearson), dallo slow How To Play The Blues e dal rabbioso swamp-blues Mighty Mississippi, con un testo sulle tragedie che hanno colpito le regioni del sud. Ma il vertice del dischetto sono i due brani registrati dal vivo ad Udine con i W.I.N.D., il superbo blues spruzzato di gospel Won’t Lay Me Down interpretato con adeguata sofferenza da Neel specialmente nella lenta introduzione, nel quale Anthony Basso construisce un assolo in crescendo da urlo e il lungo soul-blues Murdered By Love, introdotto da piano ed armonica, altro esempio mirabile di brano non solo suonato ma sentito profondamente. La dolente ballata pianistica My Kinda’ People chiude brillantemente un disco superiore alle attese.
WILLIE NELSON & WYNTON MARSALIS (featuring Norah Jones)
Here We Go Again
Blue Note 2011
Se il nostro piatto principale prevede un’icona del country come Willie Nelson e uno dei migliori trombettisti jazz come Wynton Marsalis con l’aggiunta di Norah Jones alla voce in sei brani il risultato difficilmente sarà da ristorantino di basso livello. Se poi l’occasione è la celebrazione del repertorio di Ray Charles, in due serate registrate dal vivo nel febbraio del ’09 al Lincoln Center di Manhattan, allora si può andare sul sicuro. La classe dei musicisti e del repertorio garantisce un’ora di ottima musica, sicuramente più vicina al jazz che al country (il gruppo di accompagnamento è quello di Marsalis, responsabile anche degli arrangiamenti). Peraltro si tratta di artisti eclettici che hanno sempre amato accostare altri generi e che quindi si divertono anche in ambito blues, rhythm and blues e gospel (generi toccati dalla musica di Charles) e che già avevano collaborato due anni prima nell’eccellente Two Men With The Blues. Il disco scorre che è un piacere pur non offrendo nulla di eclatante, con qualche limite in un paio di occasioni per la voce di Nelson, un po’ flebile ed affaticata. Note di merito per Unchain My Heart con spazi solisti di tromba e chitarra acustica, Come Rain Or Come Shine cantata con voce languida dalla Jones, il raffinato country Cryin’ Time cantato a due voci, il blues Losing Hand interpretato con sagacia da Nelson, accompagnato dalla tromba di Marsalis, dal sax di Walter Blanding e dal piano di Dan Nimmer e la lunga Hit The Road Jack, specialmente per la parte strumentale nella quale si inserisce alla perfezione l’armonica di Mickey Raphael, collaboratore di lunga data di Nelson. La Jones spicca nel duetto country Here We Go Again e nella jazzata Makin’ Whoopee, mentre sembra meno adatta alle inflessioni soul blues del conclusivo classico What’D I Say che si giova di una lunga introduzione strumentale. Ecco, in questo brano manca inevitabilmente la voce di Ray Charles che avrebbe comunque apprezzato questo concerto a lui dedicato.
THE NIGHTHAWKS
Damn Good Time
Severn 2012
La Severn è un’ambiziosa etichetta indipendente di Annapolis che recentemente ha pubblicato i dischi di due leggende del roots/blues Americano, Fabulous Thunderbirds e Nighthawks. Ma se per i primi la delusione è stata grande, in quanto On The Verge è un disco impersonale e di scarso interesse, Damn Good Time conferma i Nighthawks come una delle migliori “hard working bar band” americane. Della formazione originale che incise Rock‘n’Roll nel ’74 rimane il solo Mark Wenner (voce e armonica), accompagnato dai veterani Paul Bell (chitarra) e Johnny Castle (basso), con lui da una decina d’anni e dall’ultimo arrivato Mark Stutso, esperto batterista e vocalist per anni compagno di Jimmy Thackery (che era il chitarrista dei Nighthawks originali) e poi di Tab Benoit. Il gruppo ha superato i venti dischi in studio, con i live e le raccolte supera la trentina, ma ha ancora una freschezza e una voglia di suonare incredibile. Nella loro carriera hanno suonato tra gli altri con John Hammond, Muddy Waters e Hubert Sumlin, accompagnando Elvin Bishop, John Lee Hooker e Pinetop Perkins con modestia umiltà e passione. La miscela è sempre la stessa: roots music americana composta da una base di blues con aggiunte di soul, rock, un pizzico di rockabilly e di country, ma non stancano mai, alternando brani originali a covers più o meno conosciute. Se il precedente Last Train To Bluesville era un live acustico, Damn Good Time è un disco elettrico registrato negli studi della Severn con il coproduttore David Earl. Tra le dodici tracce spiccano la brillante title track, un country soul delizioso con l’armonica di Wenner in primo piano, l’incalzante Bring Your Sister scritta e cantata da Castle con in mente il pop rock di Nick Lowe, la cover swingata di Send For Me, la divertente Georgia Slop di Jimmy McCracklin e l’ennesima Let’s Work Together (Canned Heat) che non sfigura pur non aggiungendo nulla a mille altre versioni. E poi ci sono tre brani scritti da Stutso con l’amico di lunga data Norman Nardini, rock and roller di Pittsburgh che confermano il rapido inserimento del batterista. Uno dei dischi più solidi, compatti, vari e divertenti della loro copiosa produzione.