Mark Wingfield with Jane Chapman and Adriano Adewale – Zoji
di Paolo Crazy Carnevale
28 gennaio 2021
Mark Wingfield with Jane Chapman and Adriano Adewale – Zoji (Moonjune Records 2020)
Ecco qui, nuovo di zecca un nuovo capitolo della discografia del poliedrico chitarrista britannico accasato presso la Moonjune, tra dischi da titolare e collaborazioni con altri artisti legati all’etichetta, Wingfield ha trovato il tempo di portare recentemente a termine questo nuovo lavoro non del tutto a proprio nome, anche se ne è sicuramente il principale artefice.
A fargli da sparring partner ci sono la tastierista Jane Chapman, collaboratrice di lunga data di Wingfield (già nel 2008 avevano condiviso un disco), e il percussionista Adriano Adewale.
Non è un caso che “Guitar Player”, la rivista di riferimento per i cultori dello strumento chitarra abbia definito lo stile di Wingfield misterioso e maestoso: questo nuovo disco esplicita sonoramente la definizione, mettendo sul piatto una serie di composizioni elaborate e importanti, caratterizzati dall’ottima miscela stilistica realizzata dagli interventi soprattutto della chitarra e dell’harpsichord.
Si tratta in tutti i sensi di un’escursione spazio-temporale in cui i filtri e gli effetti applicati all’elettrica di Wingfield si intersecano senza problemi con il suono “antico” dell’harpsichord, virando talvolta verso rimembranze di musica barocca, talaltra verso mondi lontani, su tutti vale l’esempio della corposa ed elaborata Persian Snow Leopard, composizione in cui il concept è particolarmente riuscito.
D’altronde va detto, a mo’ di aneddoto, che quando Wingfield e Chapman hanno cominciato a sperimentare insieme, è stato nel 2006 in occasione di alcune esibizioni tenutesi nell’abitazione che fu residenza del compositore barocco Friedrich Handel per diversi decenni: nella casa di fianco, due secoli più tardi abitò per un periodo Jimi Hendrix!
Ascoltate Pasquali Dream, il brano più breve e più barocco del disco, oppure Zoji Pass da cui il titolo del disco, o ancora Prelude Sinueux, per avere esempi ulteriori dell’ariosità del progetto e delle sue direzioni musicali e del suo stare in bilico tra stili e atmosfere.


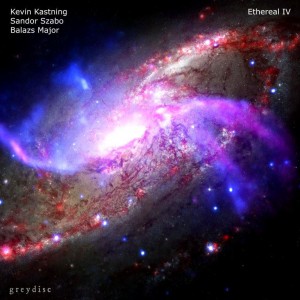


![copertinamollytuttle[524] copertinamollytuttle[524]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2021/01/copertinamollytuttle524-300x300.jpg)
