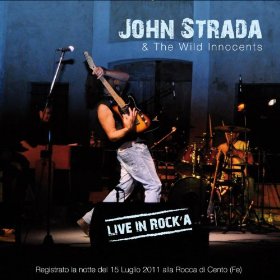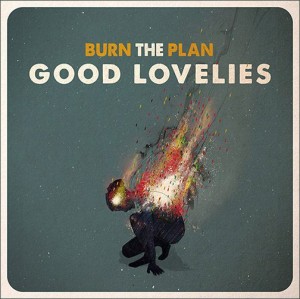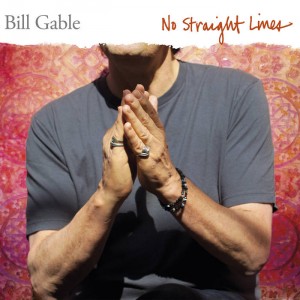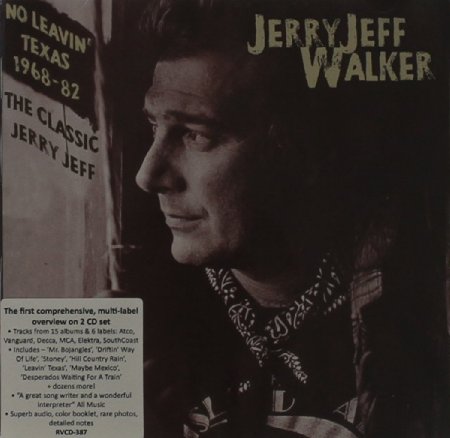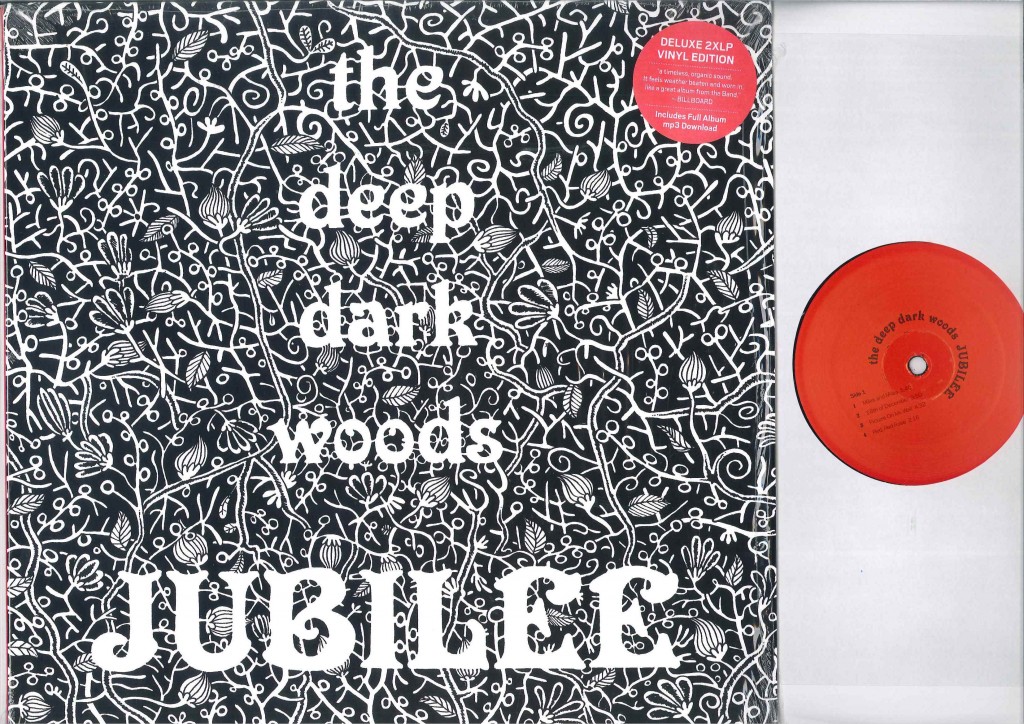Riceviamo dalla svedese Hemifram, una società distributrice di ottima musica, un po’ di CD di autori noti e meno noti, ma che riteniamo possano essere graditi dai nostrri lettori. Per saperne di più (il sito Internet è anche in inglese) potete sintonizzarvi sul sito: www.hemifran.com
Di seguito, le prime recensioni, a cura di Ronald Stancanelli. (More in the way…)
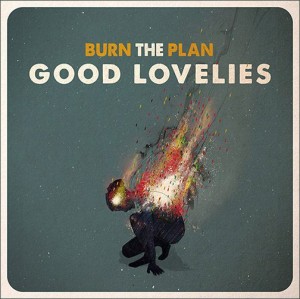
THE GOOD LOVELIES
Burn The Plan
2015 Good Lovelies In Association With Six Shooter Records
Ritmato e pregno di ampie armonie con finanche sfumature reggae questo CD di tre ragazze canadesi di Toronto che si fanno chiamare The Good Lovelies. Tredici brani per chi apprezza gli impasti di voci e in special modo quelli femminili. Trio folk che nel 2010 con l’album omonimo vinse il premio Juno, nel 2011 con Let’s The Rain furono sempre nominate per lo stesso premio e nel 2012 col Live At Revolution ebbero ottimi punteggi negli Awards Folk canadesi. Adesso con Burn The Plan, Caroline Brooks, Kerri Ough e Susan Passmore assieme ad altri sette musicisti propongono un piacevolissimo lavoro che riempie di gioia e leggiadria facendosi ascoltare con grande piacere. Tutti i brani a loro firma compresi i quattro scritti assieme al chitarrista Les Cooper che presta chitarra elettrica, acustica e mandolino a questo incantevole CD da lui prodotto. Ardente la copertina!

ANNIE KEATING
Make Believing
2015 Autoprodotto (8th Street Studios) BMI
Annie Keating è una esecutrice-cantautrice di Brooklin che grazie all’album Make Believe ha aumentato la sua reputazione e notorietà musicale negli Stati Uniti con questo disco di genere country/americana. Questa informazione troviamo in rete su questa cantautrice che scopriamo oggi grazie a questo CD ricevuto per parlarne anche da noi. Scopriamo che oltre ad avere una bella voce è anche molto brava nel finger-picking e nelle undici canzoni che compongono questo suo lavoro la direzione presa abbraccia più stili; dal sound bluesato di I Want To Believe al countryrock di Sunny Dirt Road, dalla ballata cadenzata di Foxes al ritmo sincopato di Sink Or Swim. Splendida la ballatona Just Up Ahead che ricorda lo stile della canadese Ferron, come la sfolgorante Coney Island in odore di Tom Russell o Rosie Flores. Gran bel disco, piacevolissima voce, canzoni che affascinano al primo. ascolto. Vivamente consigliato.
Tutti brani a sua firma come lo stesso dicasi per la produzione, in questo caso assieme al bassista Jason Mercer, ex del gruppo di Ani Di Franco, presente nel disco con anche altri strumenti tra cui il mellotron! Bellissima l’immagine di copertina della ruota panoramica di Coney Island, Wonder Wheel.

ASTRID YOUNG
One Night At Giant Rock
2014 Autoprodotto
Vendela Astrid Paterson Young è la sorellastra di Neil utilizzata da lui come corista in varie occasioni. Quello che non sapevo era che la stessa fosse autrice di ben tre album a suo nome, 1995, 2002 e 2015 e due con il gruppo glam-metal dei Sacred Child, 1986 e 1997, oltre a un album accreditato al gruppo degli Ist del 2002 ove, oltre a cantare, suonava il basso. Questo One Night At Giant Rock parte maluccio con i primi tre pezzi decisamente insipidi, poi recupera un po’ con The Nerve, solido rock e con Your New Drug e Why Run When You Can Hide, ballatone di maniera. Diremmo comunque che già il peso di un cognome così pesante certo non aiuta e poi mettendoci anche la leggerezza di un album oserei dire inutile si può tranquillamente passare oltre. Il brano Patchouli Boy è spudoratamente copia di Don’t Let Me Down dei Beatles, forse un omaggio si spera, chissa! Un velo pietoso anche sulla copertina.

WHITEHORSE
Leave No Bridge Unburned
2015 Six Shooter Records
I Whitehorse sono un duo canadese dal suono caratterizzato dalla totale assenza di batteria o percussioni. Questo dato trovato sul loro sito mi fa sorridere, considerando che Melinda McClelland e Luke Doucet per la prima volta prodotti da Gus Van Go e che si avvalgono dello stesso Van Go al basso hanno nel novero dei musicisti coinvolti ben quattro, dicasi quattro batteristi coinvolti, ma si sa il mondo è bello perché vario quindi ben vengano ‘ste notizie che tramortirebbero ogni recensore di buona volontà! Ottimo il brano iniziale Baby What’s Wrong? che introduce in un album di notevole impatto e grandi ritmie nel quale la fa da padrone la bella voce della Melinda e in odore di desert western movie molto belle anche Tame As Wild Ones, Evangelina e The One I Hurt, questa cantata con Doucet. Intensi e bravissimi i musicisti coinvolti. Uscito a febbraio per la Shooter Records il CD, il loro quinto, si presenta con un’allegra cover disegnata. Furono nominati nell’anno 2013 ai Polaris Music Prize che sarebbero gli Award canadesi, come disco dell’anno ed è di questi giorni che lo sono di nuovo anche per questo ultimo piacevolissimo album che mi ricorda il duo ora scioltosi dei Civil Wars.

ANNIE GALLUP
Ghost
2015 Gallway Bay Music
Annie Gallup, parentela coi panettoni piemontesi?, è una cantautrice di Ann Arbor, Michigan, che con questo Ghost tra album singoli e col gruppo delle Hat Check Girl è al quindicesimo lavoro, il primo del 1994. Album piacevole con 11 brani di cui nove suoi e due cover tra cui la nota Rock, Salt And Nails di B.U.Phillips portata al successo da Steve Young nel 1969. La signora oltre a cantare suona banjo, dobro chitarra e ukulele aiutata dal bassista Peter Gallway che produce il CD con lei, da Gabe Witcher al violino e da David West al mandolino ed è anche impegnata spesso col teatro in piece teatrali da lei create. CD molto pacato, a tratti un po’ lento ma sicuramente un bell’album di musica d’autore che si chiude con la piacevole Caledonia di Dougie MacLean. Se dovessimo fare un parallelo con artista similare ci viene in mente Mary Mc Caslin. Cervelloticamente astrusa e scomoda la confezione del CD in cartonato che si apre in varie parti creando gran confusione per seguirne i dati.
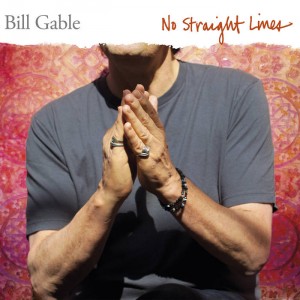
BILL GABLE
No Straight Lines
2015 Idle Speculation Music
Bill Gable è un cantautore e produttore multistumentista americano. Questo suo terzo lavoro No Straight Lines è stato principalmente scritto in un itinerario musicale tra Spagna, Portogallo e Marocco che l’artista ha recentemente compiuto ed è indubbiamente influenzato da dette culture musicali, anche se in questo percorso assoggettato anche a striature jazz ricorda moltissimo i primi Loggins & Messina. Una marea di musicisti collabora con lui che compone e scrive tutti i brani producendo e mixando il tutto. CD che si lascia ascoltare con piacevolezza, è lavoro molto caratterizzato dalla sua accattivante voce che sembra un misto tra Kenny Loggins e James Taylor anche se a tratti forse troppo crooner. Jazz oriented la foto di copertina.

SLOWMAN
Happy Boy
2014 Autoprodotto
Slowman ovvero Svante Torngren è un cantautore svedese che oltre a scrivere tutti i dodici brani di questo CD e aver suonato le chitarre e l’armonica, si è avvalso dell’aiuto di Mats Lundstrom alle tastiere, Jan Enegard al basso e di Stefan Rosen alle percussioni e batteria ottenendo un album di chiara impronta cantautorale americana(!). Ove il nostro amico dotato di una eccellente voce percorre sentieri di nobile cantautorato. Album decisamente in sintonia con quello che da sempre i lettori di Late amano, ovvero ampie ballate ben suonate e ben cantate dove il pathos espresso dall’autore colpisca profondamente gli animi degli ascoltatori. Cosa che accade puntualmente in questo CD di gentili e liquide armonie.