BEN BEDFORD – The Hermit’s Spyglass
di Paolo Crazy Carnevale
22 aprile 2019
BEN BEDFORD – The Hermit’s Spyglass (Cavalier/IRD 2018)
Non conoscevo assolutamente questo barbuto songwriter americano, e la copertina spartana, con altrettanto spartane note mi diceva solo che il disco è tutto opera sua, suonato, composto e cantato in assoluta solitudine. Va da sé che non volendomi fare influenzare cercando notizie ulteriori sul disco mi sono buttato nell’ascolto e basta.
Sorpresa! Che signor disco questo The Hermit’s Spyglass, una raccolta di brani cantati e strumentali totalmente acustici (poteva trattarsi anche di uno di quegli autori alla Prince o Jonathan Wilson, che si suonano tutto da soli), decisamente gradevoli, ben concepiti e altrettanto ben eseguiti. L’eremita del titolo a questo punto non può che essere lui stesso, il titolare, che se ne vive in solitudine col suo gatto, Darwin, nella sua fattoria sperduta nelle praterie dell’Illinois, concependo piccoli gioielli come quello di cui stiamo appunto parlando. Bedford non è alla sua prima esperienza, ci sono almeno quattro altri dischi prima di questo, ed è già stato acclamato come un erede di Dylan, Townes Van Zandt, John Prine. Ora, forse tutta questa acclamazione può sembrare fuori luogo, eccessiva, ma il Bedford è davvero un soggetto a cui dedicare attenzione. Magari Prine e Dylan non c’entrano più di tanto, piuttosto ci trovo delle similitudini con Bruce Cockburn (che non è sicuramente da meno), soprattutto per l’uso della voce e per la capacità con la chitarra. Lo scorso anno è stato anche uno dei vincitori del Kerrville Folk Festival, autentica pietra miliare tra le storiche manifestazioni musicali texane.
Quello che importa però, al di là dei paralleli e dei paragoni è il contenuto del disco, undici tracce, alcune decisamente riuscite, altre, magari, troppo brevi per brillare da sole, ma teniamo pur sempre conto che si tratta di un disco concepito come un progetto, come una storia della prateria, la storia del girovagare di Bedford e del gatto. Se composizioni come Morning Rise (cantata) o The Hermit’s Cat (strumentale) sono appunto degli sketches di breve durata, altre sono decisamente autentiche piccole perle che sarebbe un peccato trascurare.
Little Falcon è invece già una canzone di tutto rispetto, molto bella, le fa seguito lo strumentale Larkspur Awakes (tutt’altro che interlocutorio) e più avanti brillano in particolare un altro brano cantato intitolato Coyotes (qui l’influenza di Cockburn è quanto mai evidente), davvero sorprendente, come anche lo strumentale The Mule And The Horse, assolutamente ben costruito, con una notevole padronanza dello strumento. Più intimista è invece Moon And March End, di nuovo cantata, e sulla stessa lunghezza d’onda è Thunderstorm. Morning Conversations, meno di un minuto e mezzo è cantata e racconta dei dialoghi tra il gatto e gli uccelli, di cui il felino pare conoscere il linguaggio. Il finale è affidato ad un ultima creazione strumentale struggente, Quiet on The Green Hill, vagamente folkie, avvincente, bella insomma.
Chapeau!

![Ben Bedford[1245] Ben Bedford[1245]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/Ben-Bedford1245-300x260.jpg)
![joshua britt[1247] joshua britt[1247]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/joshua-britt1247-300x267.jpg)
![michael-mcdermott-out-from-under[1243] michael-mcdermott-out-from-under[1243]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/michael-mcdermott-out-from-under1243-300x300.jpg)
![Elvin Bishop Something Smells Funky[1214] Elvin Bishop Something Smells Funky[1214]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/Elvin-Bishop-Something-Smells-Funky1214-300x300.jpg)
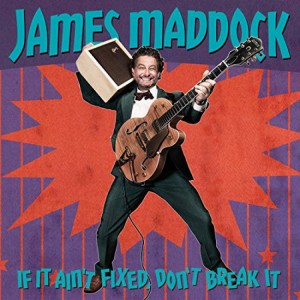




![autograph Two Tons Of Steel_0003[1166] autograph Two Tons Of Steel_0003[1166]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/autograph-Two-Tons-Of-Steel_00031166-300x269.jpg)
![IMG-20190324-WA0003[1169] IMG-20190324-WA0003[1169]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG-20190324-WA00031169-168x300.jpg)
![IMG-20190324-WA0004[1168] IMG-20190324-WA0004[1168]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG-20190324-WA00041168-168x300.jpg)
![locandina-varese-aprile-2019-WHO[1161] locandina-varese-aprile-2019-WHO[1161]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/04/locandina-varese-aprile-2019-WHO1161-182x300.jpg)