KINGFISH – Kingfish
di Paolo Crazy Carnevale
23 luglio 2019
KINGFISH – Kingfish (Alligator 2019)
Un pacioccone dalla faccia piena e dalla pelle liscia. Così occhieggia Christone “Kingfish” Ingram dalla copertina del suo primo disco. Con la Fender ben stretta tra le braccia.
In qualche modo questo ventenne appartiene alla lunga serie di chitarristi blues bambini, o ragazzini, che hanno cominciato ad imperversare fin dalla tenera età: per il debutto serio però ci è voluta la Alligator, che da etichetta protagonista della scena blues non poteva farsi sfuggire questo talento.
Prima di lui abbiamo visto passare per simili trafile vari giovanotti, da Johnny Lang a Kenny Wayne Shepherd, a Derek Trucks, a Eric Steckel: la sorte è stata alterna con loro, sicuramente quello dalla carriera più splendida è Derek Trucks, anche se Kenny Wayne Shepherd, a dispetto dell’indecisione nel scegliere una strada musicale e un genere precisi è sicuramente uno dei migliori e più ispirati manici in circolazione. Gli altri due bisogna ammetterlo, saranno sempre ricordati come bimbi prodigio, ma la loro carriera ricorda molto quella della riccioluta Shirley Temple. Poca storia da grandi.
Bene quindi ha fatto questo Kingfish ad attendere i vent’anni per uscirsene col primo disco, ora può dimostrare di non essere stato solo un fenomeno da baraccone. Sicuramente una delle rivelazioni della chitarra insieme a Marcus King, che di anni ne ha tre di più ma ha esordito nel 2015 e quindi prima dei vent’anni.
Per mettere il giovanotto a suo agio, la Alligator lo ha affidato alle cure del produttore Tom Hambridge, un veterano che ha nel suo portfolio Susan Tedeschi, Shemekia Copeland, Keb Mo’, Buddy Guy, George Thorogood (ma potremmo andare avanti all’infinito): Hambridge dà una mano a Kingfish nella composizione e suona la batteria, ma la sorpresa ulteriore è la gran voce del ragazzo, una voce che profuma di soul, capace di spaziare con scioltezza da atmosfere soffuse al blues più carico, dall’incendiaria chitarra elettrica a sonorità acustiche affascinanti.
Non solo, per tenerlo a battesimo nel migliore dei modi vengono chiamati due padrini d’eccezione, il grande vecchio del blues, Buddy Guy, quanto mai incisivo e determinante nell’ottima Fresh Out (a cui presta sia la voce che il secondo solo di chitarra), e Keb Mo’ che appare in ben cinque tracce del disco, quelle più soul: If You Love Me, Listen (in questa anche in qualità di cantante dando vita ad uno splendido botta e risposta col titolare), Before I’m Old, Believe These Blues, Hard Times (qui solo lui al dobro e Kingfish alla voce, con un effetto da down home blues fenomenale).
Ma anche i brani senza ospiti sono da segnalare, Outside Of This Town apre il disco alla grande facendo intendere immediatamente quale sia la consistenza del ragazzo, e poi, imperdibile Been Here Before in cui primeggia la chitarra acustica, suonata al pari dell’elettrica in maniera divina. Giusto Trouble, col ritmo vagamente mambo sembra non essere perfettamente all’altezza della situazione, in chiusura invece, Kingfish e soci (Hambridge alla batteria, il bassista Tommy MacDonald e il tastierista Marty Sammon si cimentano con uno slow blues dai toni rallentati, ottimo veicolo per il piano e, ovviamente per la chitarra, decisamente mai eccessiva.

![Kingfish_cover-art[1437] Kingfish_cover-art[1437]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/Kingfish_cover-art1437-300x300.jpg)
![WP_20190709_23_09_59_Pro[1404] WP_20190709_23_09_59_Pro[1404]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/WP_20190709_23_09_59_Pro1404-300x168.jpg)
![WP_20190709_23_11_17_Pro[1406] WP_20190709_23_11_17_Pro[1406]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/WP_20190709_23_11_17_Pro1406-168x300.jpg)
![WP_20190709_23_12_51_Pro[1408] WP_20190709_23_12_51_Pro[1408]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/WP_20190709_23_12_51_Pro1408-300x159.jpg)

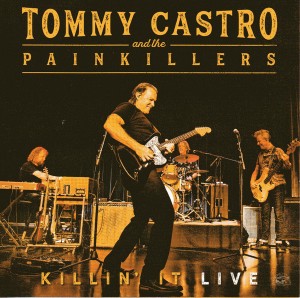
![leaf cover[1400] leaf cover[1400]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/leaf-cover1400-300x300.jpg)

![els[1391] els[1391]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/els1391-300x300.jpg)
![hill[1388] hill[1388]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/07/hill1388-300x300.jpg)