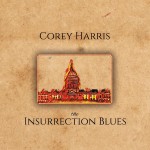ANNIE GALLUP – Oh Everything
di Paolo Baiotti
28 novembre 2021
ANNIE GALLUP
OH EVERYTHING
Gallway Bay Music 2021
Cantautrice di Ann Arbor in Michigan cresciuta con la passione per il country-blues, interprete sensibile e raffinata con una voce che richiama quella di Marianne Faithfull e autrice di testi intimi e significativi, Annie ha inciso una dozzina di album per etichette indipendenti, accompagnata spesso dal marito Peter Gallaway con il quale condivide il progetto Hat Check Girl (otto dischi in studio). A sua volta Peter è attivo da decenni come solista, avendo pubblicato anche per la Warner/Reprise prima di entrare nel circuito indipendente e incidere sia da solo che con vari gruppi (The Fifth Avenue Band, The Real Band…) ed essere coinvolto in produzioni di notevole livello come la raccolta Bleecker Street – Greenwich Village in the ‘60s.
Nel corso della pandemia, un periodo sofferto e oscuro caratterizzato da una forte insonnia, Annie ha scritto una serie di canzoni raccolte in Oh Everything che è stato registrato e mixato nello studio di famiglia Rockland nel Maine dalla cantante (chitarra elettrica e acustica, lap steel, dobro) con Peter (chitarra, basso, sintetizzatori, percussioni e batteria elettronica) e con la preziosa aggiunta di Harvey Jones (synth, tastiere, violoncello), già collaboratore di Sting, Robert Fripp e Carla Bley, che ha inciso le sue parti a New York.
La melodica e avvolgente Magic Saved Me apre il disco in modo eccellente, risultando una delle tracce più convincenti. Se alcuni brani più sperimentali come Rockabye, quasi rappata e la narrata I Dreamed lasciano qualche dubbio, la sofferta e malinconica Sleeplessness cantata con toni accorati e arrangiata con il violoncello e Little Theater, che l’autrice considera la più riuscita del disco, confermano la preferenza di Annie per atmosfere rarefatte e intimiste che caratterizzano altri brani come Who Hurts You, Everybody Wants To Take Her Home e Portrait Of The Artist As A Young Punk che chiude il disco seguendo le medesime coordinate sonore.
Paolo Baiotti