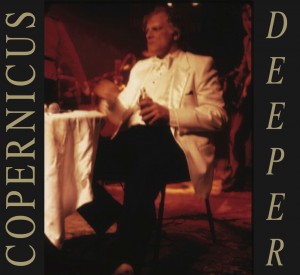LIGRO – Dictionary 2 (Moonjune 2012)
Con l’Italia, l’Indonesia è sicuramente uno dei paesi più rappresentati nel catalogo della label newyorchese Moonjune Records, che continua a sfornare interessanti produzioni nel campo del jazz rock, progressive e art-rock, in questo caso con atmosfere addirittura gotiche già annunciate dalla copertina del disco in questione.
Questa volta tocca ad un trio di Jackarta che ci conferma l’esistenza di una solida ed interessante scena musicale laddove meno ce lo saremmo aspettato.
Il nome del gruppo – un classico trio chitarra, basso e batteria – altro non è che la scrittura al contrario del vocabolo “ogril” che nella lingua nazionale indonesiana significa gente pazza.
Registrato in Indonesia nel 2011, il disco si compone di otto tracce, tutte piuttosto lunghe, in cui si va a trarre ispirazione, di volta in volta in Robert Fripp, Jimi Hendrix, John McLaughlin fino a Terje Ripdal, ma nelle composizioni ci sono ampi riferimenti e citazioni anche alla musica classica e contemporanea, nella fattispecie a Igor Stravinsky e a J.S. Bach.
A fare la parte del leone è il chitarrista del gruppo, Agam Hamzah, seguito diligentemente dai due soci nei continui cambi di ritmo delle composizioni.
Un brano su tutti: la policroma e ispirata Future.
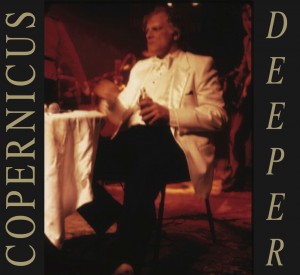
COPERNICUS –Deeper (Nevermore 1987/2012)
Non è il nuovo disco di Copernicus, il poeta undeground rock newyorchese, questo Deeper è la versione in CD di un suo vecchio vinile del 1987 che ora viene ripubblicato con distribuzione Moonjune Records come era accaduto a due lavori che lo avevano preceduto in una serie di ristampe programmatiche che un po’ alla volta hanno il compito di mettere a disposizione in versione digitale tutta l’opera di questo curioso personaggio.
Come nelle altre produzioni, incluse quelle più recenti, il poeta è accompagnato dai fidi Larry Kirwan (quello dei Black 47) e Pierce Turner, due artisti irlandesi, da tempo stabilitisi nella grande mela, con carriere musicali autonome e cospicue, che forniscono la base musicale dei dischi di Copernicus e lo accompagnano anche on stage, come testimonia il DVD praghese uscito un paio di anni fa.
Rispetto ai dischi precedenti ci sono molti più musicisti coinvolti, con uso di violini, varie chitarre, tastiere, addirittura un pianoforte, e poi flauti andini, percussioni, fiati, bodhram – a testimoniare le origini irish dei due accompagnatori principali – e su tutto, ovviamente lo sgraziato recitato/cantato del leader che quasi declama i suoi versi con disperazione.
Ci sono alcuni dei brani più interessanti, non a caso questo Deeper è tra i dischi più gettonati dal nostro durante i concerti: c’è la drammatica Son Of A Bitch Of The North in cui si denunciano gli abusi dei gringos nei paesi latinoamericani, e c’è Chichen Itza Elvis, in cui Kirwan e Turner fanno eco alle declamazioni di Copernicus con citazioni da Hound Dog, Can’t Help Falling In love With You e altri brani di presleyana memoria.
Un paio di ulteriori citazioni per la cupa Once Once Once Again, per la suggestiva Disco Days Are Over, sottolineata magistralmente proprio dal bodhram, quel particolare tipo di percussione originaria dell’area celtica che produce un suono che da solo può tenere in piedi un brano, e per concludere The Death Of Joe Apples, aperta da un’intro di ottoni con un sound che più newyorchese non si potrebbe.

POCO – All Fired Up (Drifter’s Church Productions 2013)
In copertina il profilo del cavallo in fiamme sembra volerci dire che i Poco cavalcano ancora. Quanto a cavalcare, niente da dire. Il problema è il nome del gruppo. Poco. Non per fare giochi di parole, ma oltre al nome del gruppo, poco sembra essere anche quanto è rimasto della gloriosa formazione che abbiamo amato negli anni settanta in quella che cavalca in questo secondo decennio del terzo millennio, sotto la guida di Rusty Young, unico componente originale rimasto nel gruppo.
Diciamolo senza tema di smentite, se Rusty Young ha caratterizzato per anni il suono della band con la sua pedal steel, la sua voce non è sicuramente di quelle che fanno impazzire, troppo zuccherosa: i vocalist nei Poco erano ben altri e molto più dotati. Eppure questo All Fired Up non è un brutto disco, solo non riesce ad essere un disco dei Poco. Young e suoi soci attuali (il bassista Jack Sundrud e il polistrumentista Michael Webb, già coi Brooklyn Cowboys) ce la mettono tutta ma il risultato è anonimo, potrebbe essere chiunque ad aver registrato il disco, i suoni non sarebbero male, il dobro nelle mani di Young viaggia bene, il piano di Webb anche – ma quando mai il piano è stato determinante nella musica dei Poco? -, le canzoni scorrono piacevolmente, ma non è un disco dei Poco. D’altra parte, ammettiamo pure questo, i Poco geniali e innovativi non sono quelli dei dischi con il logo del cavallo in corsa, quel logo è arrivato dopo, col successo di vendite, quando il gruppo pubblicò Legend nel 1978. Nei Poco delle origini, quelli in cui un inconsolabile Richie Furay si struggeva per non riuscire ad ottenere il successo degli ex soci Steve Stills e Neil Young, ed era vessato dal fatto che i Poco dimissionari (Messina e Meisner, ma più tardi anche Schmidt) ottenessero immensi riscontri mentre lui non se lo filava nessuno, nei Poco delle origini dicevo, c’erano gli impasti delle voci, c’erano le chitarre, le grandi canzoni e la produzione di studio era improntata in direzione di una ricerca sonora non da poco. I Poco degli ultimi trent’anni hanno continuato a cavalcare su terreni lontani da quelli delle origini, a volte incidendo dischi da dimenticare, altre ritrovando sprazzi di serenità e motivazione, come nel disco dal vivo – con tanto di dvd – in cui per una volta Furay tornava a fianco degli ex soci. Non mancano buone intuizioni in questo disco, la title track è buona, Hard Country convince particolarmente, Love Has No Reason viaggia bene. Per contro Rockin’ Horse dall’andamento finto blues è abbastanza fiacca, nonostante alcuni cori azzeccati, d’altra parte riuscite ad immaginare la voce al miele di Rusty Young alle prese con un riff dalle pretese black? Neil Young (Is Not My Brother) prende lo spunto dal fatto che in passato è girata di tanto in tanto la voce che Rusty e Neil fossero fratelli: il chitarrista dei Poco sembra quasi polemico a riguardo e il brano è cantato imitando proprio il canadese, con tanto di armonica, magari le intenzioni erano buone ma il risultato convince poco, non andando molto al di là della parodia. Persino lo strumentale a base di dobro, Pucky Huddle Stomp, è ben lontano dagli strumentali che Rusty ha composto in passato.
In definitiva, nessuno vieta a Young (Rusty ovviamente) e ai suoi nuovi soci di continuare a fare musica, ma saremmo loro grati se lo facessero senza scomodare un nome che negli anni settanta ha significato qualcosa per molti.

ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND – Live In Concert (Dare Records 2012)
Un grande in tutti i sensi questo Robert Randolph, sia per come suona la pedal steel sia per come usa questo strumento inserendolo in un contesto totalmente diverso da quello in cui siamo solitamente abituati ad ascoltarlo. E la dimensione live è di certo quella che gli si confà maggiormente. Il suo esordio è avvenuto nel 2001 per caso, quando, scoperto miracolosamente – è il caso di dirlo – nel circuito dei suonatori di pedal steel da chiesa, prende parte al suo primo disco importante, The Word, un progetto a tutt’oggi insuperato in cui fa parte di un supergruppo che comprende i North Mississippi All Stars e John Medeski. Di fatto il disco era stato concepito e costruito ad arte proprio per far emergere questo giovane talento. A quel disco hanno fatto seguito i diversi episodi della Family Band in cui Robert è affiancato dai cugini Marcus e Danyel, dalla giunonica sorella Lenesha e altri amici che lo assistono nel mettere insieme un suono che oscilla tra funk e blues, con inevitabili sfumature gospel. Questo disco dal vivo è il quinto inciso dalla formazione (che per la cronaca aveva esordito con un altro live nel 2002) ed è una delle cose migliori in cui compare il nome di Randolph, seconda solo a The Word. A parte infatti il primo disco di studio, le altre prove del nostro non sono parse troppo convincenti, nemmeno quando a produrlo si è scomodato addirittura T-Bone Burnett: il problema sta probabilmente nelle composizioni, non sempre azzeccate. Dal vivo però viene fuori tutta la grinta, tutta l’arte, tutta la grandezza di questo musicista che oltre a saper fondere diverse influenze, dimostra di aver una vasta conoscenza del patrimonio della black music, che sa sfruttare e adattare alla bisogna, usando brani di illustri colleghi per dare sfogo al proprio talento.
Il disco si apre con Travelin’ Shoes, firmata con Burnett e Tonio K (!) e tratta dal più recente disco di studio, un buon brano che però nella melodia ricorda troppo la Sailin’ Shoes di Lowell George, Squeeze è invece di pasta più solida e memorabile, con passaggi southern rock che ricordano l’Allman Brothers Band di quando c’era ancora Dickey Betts, Shining Star invece rende maggiormente l’idea dell’abilità della formazione nel fondere funk e blues alla maniera di Sly Stone, Don’t Change è un solido rock che si avvale di una grande introduzione strumentale. Il vero talento esplode però più avanti, prepotentemente, con gli strumentali Sacred Steel, in odor di Hawaii e soprattutto con Electric Church e Peckaboo, autentici e riusciti tour de force per Randolph e soci, che nel corso del disco sono affiancati anche da ospiti, ma il booklet preferisce indugiare sulle foto – peraltro belle – del gruppo che non nello specificare chi suona e dove suona.
Sicuramente ci sono altri suonatori del circuito pedal steel da chiesa – che con Randolph scambiano assoli a ripetizione – e c’è Susan Tedeschi. Ma le delizie scaturiscono anche quando il protagonista fa duettare la sua pedal steel con l’organo di Brett Haas. Tra gli artisti a cui si rende omaggio ci sono gli Staple Singers con una bella versione di I’ll Take You There, Prince di cui viene eseguita Walk Don’t Walk e l’immancabile Jimi Hendrix, con una Purple Haze per nulla scontata.

![Robert Randolph - Brighter Day 0001[1618] Robert Randolph - Brighter Day 0001[1618]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2019/12/Robert-Randolph-Brighter-Day-00011618-300x212.jpg)
![robert randolph got 1[586] robert randolph got 1[586]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2018/01/robert-randolph-got-1586-300x212.jpg)