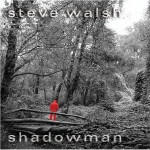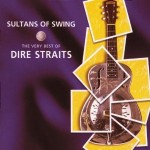Una nuova infornata di recensioni di dischi usciti più o meno recentemente. Fra i nostri big J.J.Cale ed Eric Clapton, Richard Thompson, il vecchio Ozzy, i Black Crowes e poi tanti altri. E che la musica tenga alto il vostro spirito!
J.J. CALE & ERIC CLAPTON
The Road To Escondido
2006 Reprise CD
Cronaca di una collaborazione annunciata: doveva andare a finire che prima o poi i due chitarristi si trovassero insieme a registrare un disco. D’altra parte Slowhand non ha mai fatto mistero della propria ammirazione e predilezione nei confronti del collega dell’Oklahoma, anzi, è un dato di fatto che due dei suoi maggiori successi di sempre siano proprio le versioni di After Midnight e Cocaine. In molti si erano chiesti perché non ci fosse mai stata una collaborazione tra i due e questo ottimo disco è la risposta all’interrogativo. Una risposta che gronda musica vera e diretta, come Cale ci ha sempre, o quasi, abituati ad aspettarci da lui e come Clapton ha (quasi) sempre evitato di fare nella sua carriera solista. I primi anni del nuovo decennio sono forse tra i migliori per Slowhand che ci ha consegnato una serie di luminose collaborazioni che non possono non mettere in ombra tutti i suoi prodotti laccati e perfettivi dei decenni precedenti, indirizzate più al pubblico qualunquista che a chi ama la musica per davvero. Basta pensare ai tour con Derek Trucks, ai concerti con gli Allman Brothers, al ritorno con Winwood e a quello dei Cream, o ancora ai concerti recenti con Jeff Beck. The Road To Escondido si inserisce magnificamente in questo filone e ci propone una quindicina di ottimi brani, alcuni nuovi, altri tratti dal repertorio passato di Cale, qualcosina a firma Clapton e un blues di Brownie McGee. Il genere è quello solito, né più né meno, nessuna novità, solo due vecchi amici in stato di grazia che hanno voglia di divertirsi e lo fanno con una maestria unica. Al loro fianco una manciata di altri amici come Albert Lee, Taj Mahal, Derek Trucks, John Mayer (che firma con Clapton Hard To Thrill), Billy Preston nella sua ultima performance di studio, Pino Palladino e altri. Poco importa se tra i brani nuovi When The War Is Over suona esattamente come Call Me The Breeze, poco importa se Don’t Cry Sister e Anyway The Wind Blows non sono nuovissime, il disco suona incredibilmente bene, la presenza di Clapton si fa sentire in sede di produzione, ma senza strafare, e la sua chitarra dosa sapientemente gli interventi. C’è il country e c’è lo slow blues che da sempre è il marchio di fabbrica di J.J., e ci sono soprattutto questi due ispiratissimi amici. Dall’iniziale Danger alla finale Ride The River il disco scorre senza momenti di fiacca tanto che, per quel che può valere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, si è guadagnato pure un Grammy come miglior disco di blues contemporaneo. E non poteva essere diversamente.
TRE NOVITÁ SU ETICHETTA MOONJUNE RECORDS
Sempre più versatili le proposte musicali dell’etichetta newyorchese che fa capo a Leonardo Pavkovic, innanzitutto grande fan dei Soft Machine e del movimento musicale a essi legato e il nome dell’etichetta la dice lunga in proposito. Dopo i primi dischi dichiaratamente connessi ai musicisti di quel gruppo, la Moonjune Records pubblica ora anche altri dischi che hanno la principale caratteristica di sfuggire a ogni catalogazione diretta. Non sfuggono a questa caratteristica nemmeno gli ultimi tre usciti.
BARRY CLEVELAND
Hologrammaton
2010 Moonjune Records CD
Un disco di rock d’avanguardia in cui il chitarrista Cleveland si fa accompagnare da una variegata formazione che oltre alla cantante Amy X Neuburg, include una sezione ritmica e una pedal steel guitar suonata da Robert Powell (già con David Bowie e Jackson Browne). Hologrammaton è una sorta di concept in cui Cleveland riflette e fa riflettere sullo stato del mondo occidentale all’alba del ventunesimo secolo, stando in bilico tra momenti cupi da rock industriale e atmosfere più rilassate che costituiscono la parte miglior del disco: Stars Of Sayulita, Abandoned Mines e la cover, in puro stile Badalamenti, del brano di Malvina Reynolds What Have They Done With The Rain.
DENNIS REA
Views From Chicheng Precipice
2010 Moonjune Records CD
Il prolifico chitarrista di Seattle che per la stessa Moonjune ha recentemente pubblicato con il gruppo Moraine (art rock) e con gli Iron Kim Style (free jazz) presenta ora questo personale omaggio alla Cina e al mondo orientale a cui è particolarmente legato. Un disco del tutto differente da quelli che lo hanno preceduto, differente e ugualmente affascinante, in cui la musica cinese e coreana si fondono con la strumentazione tipicamente occidentale e la chitarra elettrica di Rea, dando vita a una serie di brani che pur mantenendo molti elementi di carattere esotico vanno decisamente oltre la definizione di world music.
TOHPATI ETHNOMISSION
Save The Planet
2010 Moonjune Records CD
Come nel disco di Barry Cleveland, anche qui il tema portante del disco è lo status del mondo attuale, o meglio del pianeta, ma a musicarlo è stavolta un gruppo indonesiano che fa capo al chitarrista Tohpati che, accompagnato da un ensemble di connazionali, realizza un disco di fusion moderna sapientemente mediata con leggeri colpi di progressive in cui chitarre elettriche e sintetizzatori si innestano senza molestare su strumenti tipici della tradizione indonesiana.
Paolo Crazy Carnevale
CHEIKH LO
Jamm
2009 World Circuit/ I.R.D.
Un disco formidabile. Non occorre essere dei patiti di musica africana per apprezzare l’ingegno di questo musicista senegalese, anche perché si commetterebbe una gran bella imprecisione. A differenza di molti artisti africani che propongono musica tradizionale, Cheikh Lo si schiera piuttosto a fianco di personaggi come Ali Farka Touré, o Youssou N’Dour, alla ricerca di una nuova sonorità moderna, che coinvolge strumenti e ritmi che non appartengono al patrimonio africano, ma sono tratti dal blues, dal rock, dal reggae e da molti altri generi ancora. Certo ci sono stati altri che hanno tentato questa via in precedenza, e continuano a reinterpretare la musica tradizionale dei loro paesi, fondendola con generi occidentali, ma è quantomeno raro incontrare un artista con questa varietà e questa freschezza, capace di giocare con i suoni in maniera originale e allo stesso tempo senza pretese e senza retorica. Non a caso proprio Youssou N’Dour ha creduto nelle straordinarie doti di questo troubadour senegalese producendo il suo primo disco 1996. Oggi a distanza di molti anni Jamm si presenta come un eccezionale punto di arrivo per il suo autore, soprattutto per il cantato di grandissimo pregio e per l’abilità nel cercare una sperimentazione sicuramente non delle più facili. Nella title track, dopo un’introduzione a base di percussioni africane, l’autore si sbizzarrisce in una brillante sovrapposizione di sonorità che va dai ritmi dal sapore cubano, alla chitarra funky, a un cantato in wolof in stile rythm and blues di grande efficacia. Allo stesso modo, in Seyni si può apprezzare la singolarità di un brano caribico cantato per metà in wolof; quando dopo il break incomincia la seconda parte in spagnolo, si ha davvero l’impressione di aver di fronte una figura di spessore che sarebbe un vero peccato liquidare come “nera africana”, per usare una definizione alla Franco Battiato. Particolarmente gradevole il finale del disco, con un brano come Bourama in perfetto stile afrobeat scritto a quattro mani con il sassofonista Pee Wee Ellis, che apre la strada al lento e malinconico congedo di Folly Cagni, una lenta ballata scandita solo dal basso, dalle percussioni e qualche accenno di chitarra: come un ritorno in Africa dopo un lungo viaggio attraverso le musiche del mondo.
Eugenio Goria
BLACK CROWES
Croweology
2010 Silver Arrow 2CD
A confermare il buono, se non ottimo stato di salute della band dei fratelli Robinson, è giunto lo scorso agosto questo sconvolgente doppio antologico. Qualcuno dirà: ma come, un’antologia? Sì un’antologia. Una raccolta in cui vengono riletti e rivestiti in versione quasi acustica una ventina di brani pescati tra i migliori del repertorio dei corvi neri. Se i dischi precedenti erano stati due spettacolari live di brani inediti registrati informalmente presso gli studi di Levon Helm, a meno di un anno questo doppio di studio con le vecchie canzoni rilette è la definitiva consacrazione della band e la testimonianza della nuova linfa infusa da quel genio della sei corde che risponde al nome di Luther Dickinson. I suoni che scarutirscono dai solchi (sì esiste anche l’edizione in vinile, triplo) di questo prodotto sono affascinanti, avvolgenti, caldi: sia che si tratti di grandi successi che di brani minori, i Black Crowes arrangiano le loro canzoni con rigore, dando spesso vita a lunghe jam su cui pianoforte e chitarre ricamano code strumentali sconosciute. Non abbiate paura di ritrovarvi davanti a un doppione, questa sorta di antologia è qualcosa di completamente nuovo, ascoltate ad esempio la nuova veste sonora di Hotel Illness! E tutto senza che la band perda per un solo momento il proprio status di formazione rock. Nell’intro a base di pedal steel (Donnie Herron, un altro del giro Dylan, come nel disco precedente c’era Larry Campbell, sarà un caso?) chitarra acustica e armonica di Good Friday sembra di ascoltare i Pink Floyd. Welcome To The Good Times è un altro dei brani più riusciti del disco, e che dire di Thorn In My Pride, Bad Luck Blue Eyes Goodbye, Ballad In Urgency? Ci sono poi Cold Boy Smile che appariva solo sul live dei soli Chris e Rich Robinson e la struggente She, un grande brano di Gram Parsons. L’unica nota dolente è che il gruppo ha annunciato, dopo aver portato a termine in dicembre il lungo tour promozionale, di voler prendersi una pausa di durata indefinita, cosa che ci lascerà per un pezzo a bocca asciutta. Dimenticavo: con la prima stampa del disco è stato distribuito un singolo contenente altri due brani registrati durante le stesse session: Willin’ e Boomer’s Story, titoli che dovrebbero dirvi qualcosa…
Paolo Crazy Carnevale
STING
Symphonicities
2010 Deutsche Grammophon CD
I riarrangiamenti sinfonici di un gruppo rock non sono certo l’idea più originale. Può sembrare una buona idea, ma ormai se ne sono viste di tutti i colori, a volte ai limiti del cattivo gusto. Eppure, questa nuova raccolta di versioni inedite dei successi di Sting non riesce a non convincere: è quasi emozionante riscoprire in una nuova chiave dei brani che ormai sembravano dei pezzi da museo come Roxanne o Englishman In New York. A rendere brillante il disco è quella sana compostezza britannica di cui Sting è maestro: invece di pompose tirate wagneriane, l’autore ha preferito un tocco più da camera, sfruttando la Filarmonica di Londra e gli altri due ensemble presenti in modo sobrio e funzionale ai brani scelti. Relativamente poco è lo spazio concesso ai vecchi successi, ma forse è meglio così: mentre Roxanne è un pezzo ben riuscito, ma privo dell’energia dell’originale, Every Little Thing She Does Is Magic lascia un po’ a bocca asciutta, e anche dal grande classico Englishman In New York ci si aspetta in definitiva qualcosa di più; molto piacevole è invece Next To You, che traduce ma non altera la carica del brano. Sentendo il disco si ha cioè l’impressione che i brani più celebri non siano i più indicati per un rimaneggiamento del genere: fanno una figura di certo migliore quei brani che per il loro tono pacato e quasi meditativo calzano sicuramente di più in una veste colta e meno immediata: I Hung My Head è quasi meglio dell’originale, con un ritornello che trascina al primo ascolto, così come I Burn For You, che presenta un arrangiamento tutto da scoprire. Chiude il disco The Pirate’s Bride, un brano del 1996 estremamente malinconico e accattivante. Valore aggiunto dell’ intero lavoro la partecipazione della cantante Jo Lawry, che proprio in questo brano dà il meglio.
Eugenio Goria
OZZY OSBOURNE
Scream
2010 Sony Music CD
Decimo album in studio per l’ex leader dei Black Sabbath che a sessant’anni compiuti continua a stupire, dandoci lavori di ottima fattura come il precedente Black Rain che ha ottenuto ottimi riscontri di vendite, favoriti da tour mondiali che confermano lo stato di grazia del Prince Of Darkness, sempre vivo e vegeto malgrado decenni di abusi in ogni senso. Si tratta anche del primo album senza il grande chitarrista Zakk Wylde, con lui dall’incisione di No Rest Of The Wicked del 1998. Il disco è uscito in Europa lo scorso 11 Giugno con la produzione del fido Kevin Churko e, con i trainanti singoli Let Me Hear Your Scream e Let It Die, ha subito raggiunto tutte le top ten mondiali, grazie a concerti che hanno confermato l’incredibile carisma dal vivo del Mad Man e della sua band. Inciso ai Bunker Sudios di Los Angeles ci offre undici nuovi brani composti da Ozzy e Churko, e quattro col tastierista Adam Wakeman. Il resto della band è formato dal batterista di origine greca Tommy Clufetos, ex Alice Cooper e Ted Nugent, dal bassista Rob Nicholson e dal chitarrista Gus G, ex Firewind, non geniale come Zakk (un vero mito) ma graffiante e con un suono potente e aggressivo. Let It Die e Let Me Hear Your Scream sono stupende con il loro suono grintoso e coinvolgente, ma non sono da meno le durissime Soul Sucker e Crucify, o le ballate elettroacustiche Time e Life Won’t Wait, con la voce di Ozzy sempre stupenda e accattivante. Grande e basta, mai nostalgico. Al recente Ozz Festival di Boston ha avuto una interminabile standing ovation dai suoi fan.
Daniele Ghisoni

THE HOOTERS
Time Stand Still
2007 Hooter Music CD
Gli Hooters, americani di Philadelphia, sono attivi fin dal 1980, sia pure con una pausa di sei anni (dal 1995 al 2001). I quattro quinti della formazione sono assieme fin dal 1983 e l’ultimo entrato in ordine di tempo, dopo vari avvicendamenti allo strumento, è il bassista Fran Smith Jr. Il gruppo del cantante/ chitarrista Eric Bazilian e del cantante/ tastierista/ fisarmonicista Rob Hyman (incredibile come assomigli al direttore del Mucchio Selvaggio Max Stefani), autore quest’ultimo di un pregevolissimo album solista assolutamente da riscoprire, Largo, ha pubblicato finora solo sette album, il penultimo dei quali (ultimo in studio) è questo Time Stand Still. Oltre ai tre già citati il gruppo è completato dal batterista David Uosikkinen e dal chitarrista/ mandolinista John Lilley. Questa è una band formata da provetti musicisti, molto esperti, che suonano però per il puro piacere di farlo, con un entusiasmo da debuttanti. Il suono è infatti fresco e decisamente positivo e orecchiabile. Mette di buon umore. A partire dai due gradevolissimi pezzi posti in apertura di CD, I’m Alive e il brano che dà il titolo a tutto il lavoro. Si prosegue con una raffinatissima cover di un vecchio successo del Don Henley solista, The Boys Of Summer. A parte questo brano, le composizioni portano tutte la firma della coppia Hyman/ Bazilian, e che questi siano in grado di comporre brani piacevoli e in grado di restare a lungo in testa, senza però essere commerciali nel senso deleterio del termine, è fuori discussione. Ricordate Time After Time, il successo di Cindy Lauper interpretato da moltissimi artisti, dalla sfortunata Eva Cassidy all’immenso Miles Davis? Bene, porta la firma di Rob Hyman. Until You Dare è una ballata di gran classe, Morning Dew è folk con chiare influenze irish. Splendida poi Where The Wind May Blow con le due voci che riportano agli anni ‘60 e un intro di chitarra che mi ricorda, giuro, non sono impazzito, The Reaper dei Blue Oyster Cult. Ordinary Lives è la più bella canzone che i Jayhawks non hanno mai scritto (nel testo vengono citati Il Giovane Holden e Lucy In The Sky With Diamonds). Il compito di chiudere il lavoro, prima dell’immancabile hidden track, è affidato alla lunga Free Again, gran ballata pianistica, interpretata al solito in modo impeccabile. Davvero molto bella. In definitiva, un disco che fa trascorrere in modo molto piacevole una cinquantina di minuti. Assolutamente consigliato. Concludo ponendomi una domanda. Si mangerà bene al ristorante/ trattoria Totaro’s?
Gianfranco Vialetto
STEVE WALSH
Shadowman
2005 Muse Wrapped Records CD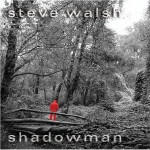
Steve Walsh è famoso per essere stato il cantante/ tastierista dei Kansas nel loro periodo di maggior fulgore. Autore di un paio di discreti album solisti, uno del 1980, Dreamer Schemer, e l’altro, sicuramente prescindibile, Glossolalia, pubblicato nel 2000. Reclutati pochi ma fidati amici come il chitarrista e bassista Josh Kosche, il batterista ex Twisted Sister Joe Franco, nonché il violinista dell’ultima incarnazione dei Kansas, David Ragsdale più, direttamente dai Symphony X, Michael Romeo se ne esce nel 2005 con un lavoro sorprendente, questo Shadowman. Sorprendente perché va ben oltre il canonico suono del gruppo di provenienza del nostro, inserendo molte sonorità assolutamente moderne e in linea con i tempi. Si resta piacevolmente spiazzati fin dal brano di apertura, Rise, che costruisce un ponte fra i Kansas e un gruppo come gli A Perfect Circe. Ancora più bello il brano che dà il titolo all’album, dura ballata hard/prog/industrial che suona come se il Peter Gabriel dei primi album solisti avesse avuto come gruppo spalla i Nine Inch Nails. Stupenda, fino alla coda finale dove si sente il tocco delle orchestrazioni di Michael Romeo. La cosa strana di questo disco, lavoro come dicevamo di un tastierista, è che le tastiere non sono affatto dominanti, tutt’altro, ma svolgono egregiamente il loro compito al servizio delle canzoni, senza essere assolutamente invadenti. Si prosegue con alcuni grandi hard rock chitarristici come Davey And The Stone That Rolled Away, Keep On Knockin’ e la ritmatissima Hell Is Full Of Heroes. Pages Of Old è una piacevole ballata chitarristica; la lunga cavalcata After potrebbe provenire da uno dei primi album dei Kansas, come Masque o Songs Of America, se questi fossero pubblicati oggi, con anche alcune influenze, non disturbanti, di rock sinfonico alla Nightwish. Comunque molto bella e particolare. La chiusura è affidata al brano più convenzionale del lotto, la piacevolissima ballata The River, degna conclusione di un album al di là delle più rosee aspettative. Steve Walsh ha forse perso negli anni un po’ della sua estensione vocale (che l’aveva fatto invitare da Steve Hackett per cantare un paio di brani nel suo bell’album solista Please Don’t Touch), ma sicuramente ha guadagnato moltissimo come maturità in fase compositiva. Speriamo si conservi a lungo così.
Gianfranco Vialetto
DIRE STRAITS
Sultans Of Swing The Very Best
2010 Vertigo 2CD + DVD 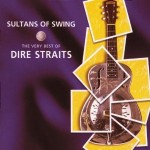
La band si forma a Newcastle nel 1977 e poi si trasferisce a Londra, con David Knopfler, il fratello Mark, e gli amici John Illsey, basso e Pick Withers, drums.Iin piena era punk i Dire Straits (letterariamente “terribili ristrettezze”) riuscirono a creare una sonorità unica, unendo il classico rock & roll a influenze country, jazz, swing e blues, grazie anche alla loro notevole capacità strumentale e compositiva che li fece diventare in poco tempo famosi in tutto il mondo. In particolare, i due primi album, Dire Straits e Communiquè, sono piccoli gioielli del genere, supportati da singoli che ormai fanno parte della storia della musica rock, da Tunnel Of Love a Romeo And Juliet, da Local Hero a Sultan Of Swing, solo per citarne alcuni. Questa raccolta fu pubblicata dalla Vertigo nel 1998 come album singolo con sedici brani, ovviamente i più famosi della band, oltre a due tracce live, Your Latest Trick e Local Hero/ Wild Theme. Visto il successo fu ripubblicata in doppio CD, con il disco originale sul primo e sul secondo un concerto inedito registrato a Londra nel 1996 durante il Golden Heart Tour contenente sette brani, e con versioni strepitose di Romeo And Juliet, Sultan Of Swing e Brothers In Arms. La ultimissima versione è questo lussuoso cofanetto con booklet allegato, a prezzo veramente contenuto, con i due CD già citati e uno stupendo DVD contenente sedici canzoni dal vivo, tratte da vari concerti con brani lunghi e dilatati, con grande spazio ai solismo dei musicisti, con Mark in grande spolvero con la sua chitarra e con la sua voce roca e personalissima: Sultan Of Swing, Romeo And Juliet, Tunnel Of Love, Calling Elvis, Love Over Gold e Heavy Fuel ci faranno sempre sognare.
Daniele Ghisoni
TOM FREUND
Collapsible Plans
2008 Surf Road Rcords CD
Tom Freund non è uno di quei cantautori di cui si sente parlare molto dalle nostre parti. E sì che a cavallo tra gli anni ‘90 e il terzo millennio, sulle nostre coste sono approdati molti nomi di nicchia o addirittura illustri sconosciuti del cantautorato americano che senza troppa arte e parte si sono guadagnati gli onori della cronaca sulla stampa italiana. Tom Freund sarebbe sicuramente svettato orgogliosamente e giustamente sopra le loro teste. Questo Collapsible Plans è il suo quarto disco, ma ciò non deve far pensare che la sua carriera sia iniziata da poco, si tratta solo di uno molto rilassato, che a volte preferisce mettere sul mercato degli EP con cinque canzoni anziché attendere di averne abbastanza da fare un disco completo. Questione di punti di vista. Questo suo sforzo del 2008 lo vede collaborare col suo amico di sempre, quel Ben Harper con cui all’inizio degli anni ‘90, quando Harper era ancora uno sconosciuto, aveva registrato un vinile tutto acustico a tiratura limitata che ricalcava le orme di Taj Mahal (e qui scatta la sfida agli indefessi cacciatori di vinile, pare che la tiratura fosse di appena duemila copie). Nel disco di cui mi accingo a parlare Harper siede in veste di produttore e compare in quasi tutti i brani. Questo impreziosisce non poco un disco che comunque già di suo brilla per l’intimità delle composizioni e per le atmosfere molto tranquille, ma mai soporifere. Si tratta proprio di un bel disco, io ho dovuto darmi il mio da fare per trovarlo su ebay in edizione giapponese (!) a un ottimo prezzo. La title track, che apre il disco è già un grande assaggio della bontà di cui sopra, e poi gli altri titoli si susseguono con gusto, notevole è Can’t Cry Hard Enough, in cui Freund suona tutto lasciando la batteria a Michael Jerome (quello che da alcuni anni accompagna Richard Thompson), e che dire di Why Wyoming, in cui le voci che accompagnano Freund sono quelle di Harper e Jackson Browne (quest’ultimo anche al piano) o Copper Moon (con gli stessi accompagnatori). In altri brani Harper ricama con la sua national guitar, con la lap steel, suona addirittura la batteria, lasciando interventi tangibili e preziosi (Without Her I’d Be Lost). Il disco, nella mia edizione nipponica, contiene anche due bonus track di grande spessore: una cover di Thank You, quella dei Led Zeppelin, prodotta da Danny Kalb, e una versione live di Copper Moon in cui è ancora presente Harper. Fateci un pensierino, magari anche un po’ grosso…
Paolo Crazy Carnevale
RICHARD THOMPSON
Dream Attic
2010 Proper CD
Non so se “riff” sia il termine appropriato parlando della chitarra di Richard Thompson, ma una cosa è certa l’attacco del primo brano di questa nuova fatica discografica del chitarrista inglese è proprio uno di quei tipici “riff” alla Thompson. Un grande riff iniziale per un grande disco, seppur torrenziale e lunghissimo, come da tempo Richard Thompson ci ha abituati, forse la sua prova migliore dai tempi di Mock Tudor e della colonna sonora di Grizzly Man. Questo grande artista è uno di quelli che con cadenza biennale torna nei negozi con le sue nuove canzoni, ma stavolta lo fa in modo diverso: Dream Attic è un disco dal vivo composto esclusivamente da nuovi brani. Una scelta insolita, pare dettata dal voler risparmiare sulle spese di produzione. Comunque sia, Thompson, è qui accompagnato dagli abituali partner degli ultimi anni, in particolare il polistrumentista Pete Zorn e il prodigioso e metronomico batterista Michael Jerome. Inutile dire che il disco è tutto registrato negli Stati Uniti, dal momento che i concerti europei col gruppo sono davvero mosche bianche (come le esibizioni milanesi di qualche tempo fa). Il disco è superiore alle pur positive recenti prove del chitarrista, forse per via della bontà del materiale, forse per l’impatto dell’esecuzione live. Richard è in forma notevole, la sua voce e la sua chitarra dominano il disco consegnandoci suoni sempre apprezzati e provenienti spesso da lontano. Sì, perché in questo disco i richiami al passato sono molti, sia a certe composizioni di quando girava in tandem con Linda (ascoltate Burning Man), sia addirittura ai fasti folk rock dei Fairport Conventin, grazie all’inserimento di strumenti tradizionali (flauti, mandolini, violino, quest’ultimo suonato da Joel Zifkin) come nella spiritosa Here Comes Geordie, un brano il cui testo ironizza (con la tipica maestria di Thompson) su certi eccessi di Sting (il Geordie del titolo). Il disco è disponibile anche in edizione doppia, con un bonus CD che raccoglie le tredici tracce in versione semi acustica: viene presentato come la versione demo dei brani inclusi nella parte live, ma vi assicuro che ascoltandolo si ha la sensazione di avere a che fare con brani fatti e finiti, e che brani! In questa versione Dream Attic ha dalla sua il fatto di durare un po’ di meno, risultando più fruibile, ma l’unica cosa innegabile che emerge dall’ascolto è che in una versione o nell’altra ci troviamo davvero davanti ad un grande disco.
Paolo Crazy Carnevale