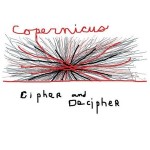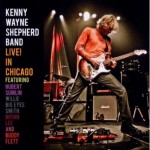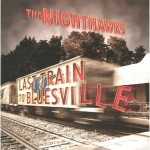THE DUKE AND THE KING
Long Live The Duke And The King
2010 Silva Oak/ Loose LP/CD
Sono mesi che ascolto questo disco. Sempre con l’intenzione di mettermi a scrivere qualcosa in proposito. Uno dei migliori dischi “nuovi” in cui mi sia imbattuto negli ultimi tempi, e per nuovi intendo attribuiti ad artisti giovani e con una proposta musicale fresca, per quanto con le radici ben piantate in tutto quanto è stato prodotto nei quattro decenni precedenti. Si tratta del secondo disco per questa formazione dello stato di New York (Catskill Mountains per la precisione), ma rispetto al debutto la formazione ha raddoppiato il numero dei propri componenti, aggiungendo alla propria musica più punti di forza. Risulta difficile dire chi faccia cosa all’interno del combo il cui nome rimanda a due personaggi truffaldini creati da Mark Twain per il suo Huckleberry Finn, ma è evidente che la voce principale sia quella di Simone Felice, uno dei Felice Brothers di cui avrete senz’altro sentito parlare. Ma anche gli altri (Bobby Bird Burke, cofondatore, Simi Stone e il Nowell Haskins) ci mettono del proprio e la magia del risultato è proprio nello strano melange di voci che si impastano molto bene in questo disco, dando vita a dieci composizioni ben prodotte, con chitarre mai debordanti, sezione ritmica d’impianto folk rock, qualche intromissione fiatistica, armonica e accordeon sparsi qua e là. E che dire della confezione, un bell’album sullo stile dei vecchi vinili (il disco è naturalmente edito anche nel vecchio caro supporto), con libretto contenente i testi e il CD inserito in una busta nera proprio come i vecchi trentatré giri. Ma ciò che vince sono davvero le canzoni: dall’opening di O’ Gloria alla convincente e ben strutturata Shine On You a Right Now giocata sull’amalgama e sull’alternarsi delle voci. Hudson River è una soul ballad che si regge sul cantato davvero black e su una melodia che entra facilmente in testa. No Easy Way Out è invece una canzone folk rock dominata dalla cantante Simi Stone ed è un altro dei punti forti del disco, che come si usava un tempo dura poco meno di quaranta minuti, ma tutti allo stesso livello (personalmente sono sempre stato convinto che i compact disc di più di cinquanta minuti vadano bene per le antologie e per le retrospettive con bonus track, salvo qualche raro caso). E ancora, Children Of The Sun e Have You Seen It?, un brano in cui le influenze younghiane (il gruppo dal vivo esegue spesso brani come Helpless e Long May You Run, ma non fatevi fuorviare da questo, la loro è una proposta originale e non derivativa!) emergono qua e là. In Gran Bretagna le riviste musicali li hanno incensati e anche il “Rolling Stone” tedesco ha speso grandi parole per loro. In Italia sono ancora sconosciuti o quasi. Loro si definiscono folk-soul-glam (quest’ultima definizione soprattutto per ciò che riguarda il look) ma la loro musica va davvero oltre le classificazioni di routine. Provare per credere.
Paolo Crazy Carnevale

MARBIN
Breaking The Cycle
2011 Moonjune CD
Proprio un bel disco questo Breaking The Cycle, intestato alla formazione israeliana che fa capo a Danny Markovitch (sassofonista) e Dani Rabin (chitarrista), tanto che il nome del gruppo è il risultato di una crasi fra i due cognomi: un disco di musica strumentale che, pur essendo i due leader indirizzati nel filone jazz rock, va oltre le definizioni inventandosi un genere tutto suo che pur facendo trasparire (soprattutto nella prima traccia) la matrice jazzistica, si apre poi verso orizzonti molto diversi dove di volta in volta gli strumenti di Rabin e Markovitch dettano legge creando sublimi atmosfere (Western Sky, Outdoor Revolution, Burning Match, la coinvolgente Old Silhouette tanto per fare qualche titolo) a volte cullate dal sax, altre sferzate dalla chitarra tagliente. Virate più d’impronta rock si innestano sapientemente su atmosfere più pop che non mancano di fondersi, senza strafare, con la matrice yiddish che fa immancabilmente parte del DNA dei due musicisti. A rinforzare il gruppo ci sono poi il batterista Paul Wertico (con una lunga militanza nella band di Pat Metheny) e il percussionista Jamey Haddad (dalla corte di Paul Simon). A suggellare questo brillante prodotto c’è l’intensità della conclusiva Winds Of Grace, unico brano cantato affidato sia nelle liriche che per quanto riguarda le corde vocali a Daniel White.
Paolo Crazy Carnevale

GARTH HUDSON
A Canadian Tribute To The Band
2011 Curve Music/Sony CD
Non proprio un’occasione sprecata, ma un’operazione riuscita a metà. Certo, al grande Garth Hudson vanno il plauso e il riconoscimento per aver prodotto un disco tutto canadese dedicato alla musica del suo vecchio gruppo, un disco peraltro caratterizzato, e questo è proprio uno dei suoi pregi, dalle sue tastiere inconfondibili che danno all’opera un senso di continuità che solitamente non si respira nei tribute album tradizionali. Attingendo poi dal repertorio meno scontato di The Band. Il disco inizia alla grande con quattro brani di rilievo: Danny Brooks propone la poco nota e ben realizzata Forbidden Fruit, per non dire del graditissimo e ispirato ritorno di una delle canadesi più interessanti, Mary Margareth O’Hara, che offre subito una delle perle del disco, Out Of The Blue, avvolgente ballata che figurava sulla parte in studio dell’Ultimo Valzer. Acadian Driftwood, brano tutt’altro che facile è invece affidato a Peter Katz che si dimostra molto all’altezza della situazione, come del resto fa Neil Young affiancato dai giovani Sadies nella rilettura di This Wheel’s On Fire, dove la sua chitarra inconfondibile duetta con l’organo di Hudson. Da qui in poi però le cose cambiano e le sorti del disco si fanno alterne: qualche scelta poco oculata nel repertorio, o forse negli esecutori mettono in pericolo il tributo. Ain’t Got No Home, You Ain’t Goin’ Nowhere, I Loved you Too Much, Move to Japan abbassano il livello del disco in maniera irreparabile. Per fortuna, qua e là si aprono altri spiragli notevoli, come in The Shape I’m In (ancora i Sadies, senza Young però), o la brillante Clothes Line Saga dei Cowboy Junkies (anche se il brano è tutto a firma di Dylan), con una Margo Timmins ispirata e Hudson a stendere tappeti di tastiere di cui nessun altro è più capace. Buone anche le due rivisitazioni in cui compare Bruce Cockburn, Sleeping (accompagnato dai Blue Rodeo) e Chest Fever in cui è lui ad accompagnare Ian Thornley. La versione di Yazoo Street Scandal passa invece abbastanza anonimamente. Meglio Tears Of Rage affidata alle corde vocali di Chantal Kreviazuk. Da segnalare, in positive, anche The Moon Struck One, Knockin’ Lost John in chiave irish e King Harvest. Ecco: questo è quanto. Forse è il problema dei CD che hanno più capienza di un trentatre giri, così si tende a riempirli troppo. Questo tributo a The Band dura intorno ai settanta minuti, quarantacinque sarebbero forse bastati e ne avrebbero fatto un ottimo disco, che purtroppo invece non è.
Paolo Crazy Carnevale
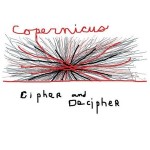
COPERNICUS
Cipher And Decipher
2011 Nevermore Inc.- distribuzione Moonjune
Un nuovo disco di Copernicus, un performer e un poeta soprattutto, prima che un musicista. Questo artista newyorchese, sulla scena fin dagli anni ‘80, dopo aver provveduto tramite la sua etichetta a rendere disponibili i suoi vecchi lavori e a distribuire quelli più recenti in più lingue, è tornato recentemente con un nuovo disco, un lavoro attraversato dal lirismo e dalla nervosità: Cipher And Decipeher è la nuova testimonianza dello smalto che pervade la poetica di questo cantore della grande mela, e del cosmo intero con tutti i suoi mali. Un disco di dieci tracce, per una durata di ben settanta minuti, con Copernicus intento a declamare i suoi versi, accompagnato da un fedele gruppo di collaboratori, alcuni al suo fianco fin dalla prima ora, alcuni titolari di carriere discografiche in proprio a un certo livello, come Larry Kirwan, Thomas Hamlin e Fred Parcells, noti al pubblico per le loro imprese nei Black 47. Il disco, non facile, regge bene anche nella parte finale dominata dal quarto d’ora di The Cauldron, ma le cose migliori sono senza dubbio i brani iniziali Into The Subatomic e Free At Last e le centrali Where No One Can Win e Infinite Streght, forse la traccia più interessante, pervasa dall’inizio alla fine dal sax nervosissimo e tutto newyorchese di Matty Fillou, con la voce di Copernicus che (per fare un paragone) ricorda certe intonazioni tipiche di Moni Ovadia.
Paolo Crazy Carnevale

NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS
Keys To The Kingdom
2011 Songs Of The South CD
Giunti al sesto disco in studio a tre anni di distanza da Hernando, i NMA pubblicano il loro album più personale, fortemente influenzato dalla morte del musicista e produttore Jim Dickinson, padre di Luther (voce e chitarra) e Cody (batteria) che compongono il trio con Chris Chew (basso). Inciso nello studio di famiglia Zebra Ranch, Keys To The Kingdom ha un suono meno duro che in passato, permeato di blues e gospel, incentrato sulle canzoni più che sulla chitarra di Luther, presente ma non dominante. Detto questo non è che manchino brani potenti o ritmati, come l’aspro rock di This A’ Way che apre il disco, il successivo trascinante blues Jumpercable Blues nel quale la slide di Luther è affiancata dall’amico Gordie Johnson o la grintosa Hear The Hills. Ma gli episodi migliori mi sembrano quelli più riflessivi e personali: il gospel blues di stampo sudista The Meeting, cantato con il cuore da Luther aiutato dall’inconfondibile voce di Mavis Staples, la deliziosa How I Wish My Train Would Come, il gospel Let It Roll (già presente nel disco solo di Luther Onward & Upward) e la splendida Ain’t No Grave, con un testo dedicato al padre, arricchita dalla slide di Ry Cooder. Da non trascurare l’originale versione di Stuck Inside Of Mobile di Bob Dylan con un arrangiamento suggerito da Jim Dickinson ai figli pochi giorni prima di morire. Dopo un paio di brani meno riusciti, Jellyrollin’ All Over Heaven chiude il disco celebrando la vita eterna con leggerezza e serenità.
Paolo Baiotti

ISRAEL NASH GRIPKA
Barn Doors And Concrete Floors
2011 Israel Nash Gripka CD
Dopo l’interessante esordio New York Town di due anni fa, Israel ha lasciato la grande mela rifugiandosi in un vecchio granaio nelle Catskill Mountains con il produttore Steve Shelley e un gruppo di amici per registrare il secondo album. L’ambiente rilassato e l’assenza di pressioni hanno sicuramente contribuito alla riuscita di Barn Doors And Concrete Floors, un disco eccellente che ha già ricevuto recensioni molto positive sia negli Stati Uniti che in Europa. Figlio di un pastore battista, Israel Nash ha avuto un’adolescenza complicata tra alcool e carcere, con quei contrasti di positività e negatività che hanno caratterizzato grandi artisti. Influenzato dai cantatutori rock classici (in primis Neil Young e Ryan Adams), ma anche dal gospel, dal country, dal folk e dalla roots music, Gripka dimostra soprattutto una capacità compositiva non comune a partire da Fool’s Gold un mid-tempo accattivante di presa immediata che può anche richiamare gli Stones di Exile On Main Street. L’ambiente bucolico sembra incidere sul country malinconico di Drown e sulla riflessiva ballata Sunset, Regret. Non ci sono tracce deboli in questo disco, ogni brano meriterebbe una citazione, dall’irresistibile melodia di Four Winds con la pedal steel di Rich Hinman al grintoso rock di Louisiana che precede la splendida Baltimore nella quale la voce di Gripka ricorda il maestro Young e la chitarra solista si lascia andare in un brillante assolo affiancata dall’armonica. Ma si possono dimenticare il country rock di Red Dress o la sofferta ballata acustica Bellwether Ballad? Quando si spengono le note di Antebellum (inzio lento, chitarra elettrica distorta e finale in crescendo) viene voglia di schiacciare nuovamente il tasto play per riascoltare un disco che sicuramente finirà nella mia top ten dell’anno.
Paolo Baiotti

PENDRAGON
Passion
2011 Toff Records/ Snapper CD
In attività dagli anni ’80, sempre guidati dal leader Nick Barrett (voce, chitarra, compositore e produttore con Karl Groom), i Pendragon tengono alto con gli I.Q. il nome del progressive britannico. Con Passion proseguono nel cammino intrapreso con il precedente Pure (Toff 2008), che aveva evidenziato un indurimento del suono con alcune sperimentazioni. Un disco aspro e oscuro, almeno nell’iniziale title track e in Empathy, caratterizzata da una chitarra insinuante e da un drumming potente, accostabili al prog metal. Anche Feeding Frenzy, pur non priva di melodia, segue lo stesso schema, mentre il suono si apre alla melodia in The Green And Pleasant Land, uno splendido brano prog con un testo nostalgico sugli aspetti positivi della Gran Bretagna del passato, contrapposti ai difetti odierni. It’s Just A Matter Of Not Getting Caught ha una struttura complessa con una ritmica hard che contrasta la voce melodica, Skara Brae alterna toni diversi con un inserimento di voce rappata, una ritmica ripetitiva e una confusione di fondo. Si chiude con Your Black Heart, un brano evocativo improntato sull’uso del pianoforte, con una chitarra floydiana, caratteristica dello stile melodico di Barrett. Un disco controverso che lascia qualche dubbio, con meno chitarra solista del solito, un approccio più vicino al rock, una presenza quasi di contorno delle tastiere di Clive Nolan e una qualità compositiva inferiore ai momenti migliori della band. Oltre all’edizione normale è reperibile un’edizione limitata con un DVD nel quale Barrett racconta la genesi dell’album.
Paolo Baiotti
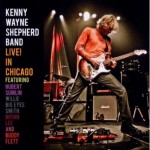
KENNY WAYNE SHEPHERD BAND
Live! In Chicago
2010 Roadrunner CD
Quando esordì a diciassette anni nel 1995 con Leadbetter Heights, Shepherd sembrava destinato a una carriera folgorante. Le promesse sono state mantenute solo in parte; come per altri talenti della chitarra blues più o meno recenti (Joe Bonamassa, Jonny Lang e Jeff Healey i casi più eclatanti) le capacità tecniche indiscutibili non hanno sempre trovato materiale o produttori all’altezza. Così Kenny ha alternato album poco convincenti fino al brillante 10 Days Out, un omaggio ai vecchi bluesmen del Sud diventato un documentario e un album di grande qualità nel 2007. Questo recente live si ricollega al precedente progetto, essendo stato registrato nel corso del tour di 10 Days Out alla House of Blues di Chicago con ospiti due grandi veterani come Hubert Sumlin (ex chitarrista di Howlin’ Wolf) e Willie “Big Eyes” Smith (ex batterista di Muddy Waters) e due chitarristi che hanno aiutato Kenny a inizio carriera, Bryan Lee (che lo invitò on stage a New Orleans a tredici anni) e Buddy Flett. E non si può dire che si tratti di un disco poco riuscito! Shepherd dimostra le sue qualità fin dai primi brani Somehow, Somewhere, Someway e King’s Highway, fortemente influenzati dallo stile di Stevie Ray Vaughan e nella swingata Deja Voodoo, esplosiva nella coda chitarristica. Il concerto sale ulteriormente di tono con gli ospiti; Buddy Flett è protagonista della sua Dance For Me Girl, un blues tosto profumato di Louisiana, mentre Willie Smith svetta alla voce e all’armonica in Baby Don’t Say That No More e nello slow Eye To Eye, classico blues di Chicago. Notevoli le versioni di How Many More Years e di Sick And Tired, entrambe con Sumlin alla chitarra e voce solista. La qualità resta alta fino alla cadenzata Blue On Black, nella quale spiccano la voce di Noah Hunt, cantante del gruppo di Kenny e la chitarra del leader che si distende in un assolo in crescendo molto efficace, seguita dalla conclusiva I’m A King Bee, grintosa e tagliente al punto giusto.
Paolo Baiotti

DRIVE BY TRUCKERS
Go-Go Boots
Sometimes Late At Night
2011 Ato Records
Che la band di Athens sia una delle più interessanti prodotte dal Sud degli Stati Uniti negli ultimi quindici anni è indubbio. Riuscendo a miscelare con notevoli capacità influenze diverse (punk, rock sudista e alternative country) creando un suono riconoscibile e personale, la band di Patterson Hood (figlio di David Hood, celebrato bassista degli studi Muscle Shoals) ha avuto una prima fase underground culminata nel brillante doppio Southern Rock Opera, seguita da un periodo con la New West che ha prodotto album di ottima qualità come Dirty South e A Blessing And A Curse. La separazione con il chitarrista e cantante Jason Isbell, che aveva contribuito a questi ultimi dischi e qualche incertezza di Hood e dell’altro compositore Mike Cooley hanno inciso sulla riuscita di The Big To Do, uscito l’anno scorso, e di questo Go-Go Boots, un disco strano (e troppo lungo) rispetto alla produzione precedente in quanto giocato quasi interamente su brani mid-tempo, a volte privi di incisività, troppo simili tra loro e con un suono un po’ piatto e compresso. Il livello medio è discreto con poche vette: la ritmata e insinuante I Used To Be A Cop, la conclusiva Mercy Buckets e le due cover di Eddie Hinton, Everybody Needs Love e Where’s Eddie. L’edizione inglese è uscita con un interessante Bonus EP in omaggio (reperibile su www.roughtrade.com) comprendente una inedita cover di When I Ran Off And Left Her di Vic Chestnutt, intensa ballata intimista venata di country e cinque brani registrati dal vivo ad Atlanta e Madison: I Used To Be A Cop e Mercy Buckets, più intense e grintose rispetto alle versioni in studio, una suadente Everybody Needs Love, la trascinante Get Downtown e un medley aspro e dissonante di Buttholeville (tratto dall’esordio Gangstabilly) con State Trooper di Bruce Springsteen. Dal vivo i Drive By Truckers si confermano eccellenti, mentre in studio forse è il momento di concedersi un attimo di pausa dopo anni di attività frenetica.
Paolo Baiotti

THE DECEMBERISTS
Live At The Bull Moose
2011 Capitol CD
The King Is Dead, il recente album della band della costa ovest, è considerato uno dei migliori dischi di questi primi sei mesi. Colin Meloy e compagni hanno lasciato da parte le influenze prog presenti in passato (ad esempio nell’eccellente The Crane Wife), privilegiando una scrittura aderente al formato della canzone breve tra folk, country e pop. L’innato gusto per la melodia e la qualità dei brani hanno contribuito alla riuscita di un disco tanto piacevole da ascoltare quanto lontano dalla banalità spesso accostata al pop rock. Questo mini album di sette brani, registrato a gennaio in un negozio di dischi di Scarborough in Maine, e uscito in occasione del Record Store Day in edizione limitata di 2500 copie, conferma i pregi della recente produzione della band. Sette brani dei quali sei tratti da The King Is Dead che, anche dal vivo, non perdono nulla della loro naturale fluidità, guadagnando in carattere e calore. Il singolo Down By The Water (chiaramente ispirato dai REM…non a caso Peter Buck è ospite nella versione in studio) e This Is Why We Fight sono due brani trascinanti dalla melodia irresistibile, Rox In The Box riprende con sapienza la lezione folk-rock dei Fairport Convention, June Hymn è riflessiva e intimista, mentre All Arise! è allegra e coinvolgente e Rise To Me evidenzia le qualità vocali di Meloy e i raffinati arrangiamenti dei compagni (deliziosi la pedal steel di Chris Funk e l’armonica di Colin). Si chiude con la preziosa cover della ballata country If I Could Win Your Love dei Louvin Brothers. Peccato che l’album duri solo mezz’ora!
Paolo Baiotti

JESSE McREYNOLDS & FRIENDS
Songs Of The Grateful Dead
2010 Woodstock Records CD
THE WHEEL
A Musical Celebration Of Jerry Garcia
2011 Nugs.net CD
L’anno scorso, sviluppando un’idea di Sandy Rothman (musicista di bluegrass e compagno di Jerry Garcia nei Black Mountain Boys e nella Acoustic Band), il grande cantante e mandolinista bluegrass Jesse McReynolds ha pubblicato un eccellente tributo alla musica del leader dei Grateful Dead. Nato nel 1929 in Virginia, McReynolds ha formato con il fratello Jim nel 1947 il duo Jim & Jesse ed è considerato un musicista innovativo e influente in ambito bluegrass. Ed è stato uno degli artisti preferiti di Garcia negli anni dell’adolescenza, come racconta Rothman nel booklet del dischetto. McReynolds ha chiamato i componenti del suo gruppo Virginia Boys e alcuni amici che in passato hanno collaborato con Garcia in ambito acustico come Stu Allen e David Nelson, scegliendo dodici tracce (quasi tutte scritte da Jerry con Robert Hunter) riarrangiate tra country e bluegrass con ottimi risultati. In particolare la dolente Black Muddy River, la raffinata Ripple, l’improvvisata Bird Song (che mantiene un sapore psichedelico di fondo), la melanconica Loser (ottima prestazione vocale di McReynolds) e la ballata Standing On the Moon spiccano in un dischetto che si ascolta con grande piacere, chiuso da Day By Day, unico brano composto da McReynolds con Robert Hunter. Di pari livello il concerto organizzato dalla Rex Foundation (l’organizzazione benefica fondata dai Grateful Dead) il 4 dicembre del 2010 al Fillmore di San Francisco che ha riunito McReynolds con David Nelson, Peter Rowan, Barry Sless e altri musicisti presenti nel disco o comunque legati a Garcia. I brani migliori sono stati raccolti in un compact disc reperibile sul sito www.nugs.net che dimostra per l’ennesima volta la valenza universale del songwriting di Jerry. Dodici tracce tra le quali una liquida Ripple con Nelson (uno dei fondatori dei New Riders Of Purple Sage) alla voce solista e Steve Thomas al violino, la ballata Peggy-O (un tradizionale interpretato più volte da Garcia sia da solo che con i Grateful Dead) sempre con Nelson alla voce e un prezioso Mookie Siegel alla fisarmonica, una deliziosa Standing On The Moon con intreccio di violino, mandolino, fisarmonica e pedal steel nella coda strumentale, Franklin’s Tower trascinante anche in veste prevalentemente acustica, il tradizionale Dark Hollow con Peter Rowan (compagno di Garcia nella seminale band di bluegrass Old And In The Way) e la trascinante The Wheel, improvvisata in grande scioltezza.
Paolo Baiotti
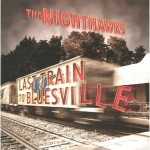
THE NIGHTHAWKS
Last Train To Bluesville
2010 Rip Bang CD
Gli inossidabili Nighthawks proseguono nel loro cammino iniziato nel 1972 quando l’armonicista Mark Wenner formò la band a Washington D.C. con il chitarrista Jimmy Thackery (che ha avviato una carriera solista nel 1986). In questo disco acustico, registrato dal vivo negli studi della radio Sirius/XM, la formazione comprende due membri originali, Wenner e Pete Ragusa (batteria) che si è ritirato proprio dopo questa incisione sostituito da Mark Stutso (che curiosamente proviene dalla band di Thackery), oltre a Paul Bell (chitarra) e Johnny Castle (basso). Anche in veste acustica il quartetto non delude, muovendosi con scioltezza e naturalezza tra blues e roots music, guidato da Wenner principale voce solista a proprio agio sia nello swingato rock and roll The Chicken And The Hawk (famosa la versione di Big Joe Turner) che nello slow blues di Muddy Waters Ninenteen Years Old e nella raffinata Rainin’ In My Heart. Ragusa canta il divertente doo-wop I’ll Go Crazy di James Brown, mentre Johnny Castle è protagonista in You Don’t Love Me e nel classico di Chuck Berry Thirty Days. Il blues jazzato di High Temperature e le note inconfondibili di una ritmata Rollin’ And Tumblin’ chiudono un disco fresco e incisivo che non sfigura nel corposo catalogo di una band che ha dato molto alla musica tradizionale americana.
Paolo Baiotti