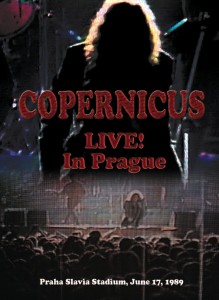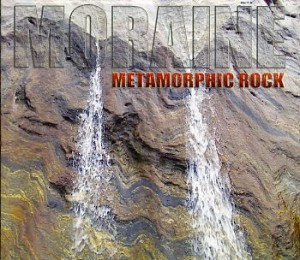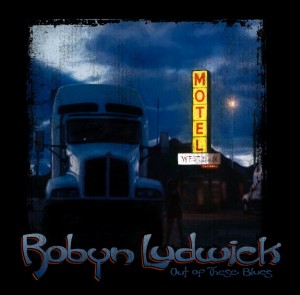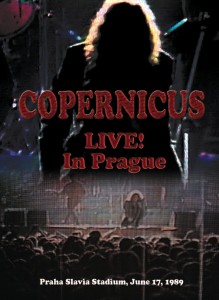 COPERNICUS – Live in Prague DVD (Nevermore 2011)
COPERNICUS – Live in Prague DVD (Nevermore 2011)
Nel 1989, qualche mese prima del crollo del muro di Berlino, il poeta/performer Copernicus intraprese un tour europeo che lo portò a toccare alcune città di quei paesi che all’epoca erano comunemente definiti d’oltrecortina. Un tour di successo con cui promuoveva il suo recente disco Deeper, che grazie ad un’adeguata radiodiffusione era stato accolto molto positivamente in quei paesi, che per quanto riguarda la data nella capitale dell’allora Cecoslovacchia è stato anche videofilmato e trasmesso in televisione. Il contenuto del Dvd Live In Prague, pubblicato lo scorso autunno dalla Nevermore con distribuzione Moonjune, ci riconsegna, del tutto intatta l’atmosfera di quella serata. Chi ha avuto modo di visitare i paesi dell’est nei primi tempi dopo la caduta del muro, ritroverà certe atmosfere in queste riprese. Copernicus è accompagnato qui da un quartetto di musicisti comprendente il fido Larry Lirwan, che oltre a suonare tastiere e chitarra, si occupa di alcune parti vocali più cantate, rispetto a quelle recitate da Copernicus. L’atmosfera è la stessa cupa e pessimista che domina anche nelle produzioni discografiche del performer, che nel corso dell’esibizione non disdegna di cambiare d’abito per calarsi meglio nei testi delle sue composizioni, tanto che in Son Of A Bitch From The North lo ritroviamo con un sombrero calato in testa, quasi fosse un campesino guatemalteco come quello di cui il testo parla. In Chichen-Itza Elvis, invece, è Kirwan che sfodera un riff che ricorda alla lontana Not Fade Away, usando la musica al posto del travestimento. I brani conclusivi, Nagasaki e Blood, provenienti dal disco d’esordio di Copernicus, si confermano come composizioni di grande effetto, rafforzato in questo caso dalle immagini provenienti da diverse riprese della serata montate – come tutto il Dvd – in una duplice inquadratura, quella ripresa e trasmessa dalla tivù praghese e quella di Corbett Santana.
Paolo Crazy Carnevale

DANIELE RONDA & FOLKLUB – Da parte in folk (2011)
Anche se il nome di Daniele Ronda, cantautore piacentino, classe 1983, può suonarvi del tutto sconosciuto, le sue canzoni sono finite nei dischi di alcuni noti personaggi del panorama musicale leggero italiano, da Mietta a Nek, a Massimo Di Cataldo, e prima di questo debutto in chiave folk rock, Ronda aveva al proprio attivo un altro disco solista. Il cambiamento di rotta, la virata verso una sorta di combat folk energico ed ispirato, più in senso musicale che per quanto riguarda i testi, sembra aver fatto bene a Ronda che pur pagando dazio a molta musica italiana riesce ad inanellare una serie di canzoni ben eseguite e sorrette da una strumentazione scarna ed efficace in cui la fisarmonica fa la sua bella parte, senza mai sovrabbondare eccessivamente. Il disco si apre con una canzone in dialetto, La nev e ‘l sul, che non può non farci pensare a i primi Modena City Ramblers o a Van De Sfroos, che guarda caso è ospite in Tre Corsari, una delle canzoni portanti del disco, cantata però in italiano. Altro ospite d’eccezione è Danilo Sacco dei Nomadi, che canta in un intenso brano ispirato alla tragedia di Cernobyl. E la musica dei Nomadi ha sicuramente la sua buona dose di responsabilità nell’ispirazione di Ronda, così come certe cose dei Gang, ma anche –complici la voce e il modo di cantare di Ronda – Ruggeri (ascoltate Polvere e sabbia o la bella Ogni passo per rendervene conto) o il Battiato anni ottanta (l’inizio di Cenerentola, altro brano chiave del disco). Il disco nel complesso è piacevole e tra le note positive vi è anche una produzione abbastanza felice che contribuisce a caratterizzarne il suono.
Paolo Crazy Carnevale

ED LAURIE – Cathedral (V2 2011)
Una delle belle sorprese di inizio anno. Devo ammettere che l’occhio, o meglio l’orecchio, su questo disco mi è caduto in virtù del fatto che ho notato i nomi di alcuni miei concittadini tra i musicisti che accompagnano questo songwriter scozzese, giunto ormai alla terza prova e spinto ora da una casa discografica di un certo rilievo come la V2. Cathedral è un bel disco di una quarantina di minuti, come si usava una volta, con dieci tracce mediamente caratterizzate da una buona ispirazione. Si tratta di un disco che entra in circolo mano a mano che lo si ascolta, ben costruito, ben suonato, composto con mano felice ed arrangiato altrettanto felicemente. Nelle recensioni apparse qua e là sono stati fatti paragoni con i Buckley, con Fred Neil e Nick Drake, ma la verità è che Ed Laurie brilla sufficientemente di luce propria senza dover scomodare grossi paragoni, piuttosto, da indiscrezioni ottenute parlando con i musicisti coinvolti si scopre che se mai l’intenzione era di partire da un’idea alla Astral Weeks. Tutta un’altra cosa insomma. E le intenzioni trovano conferma in brani come Side Of A Candle e la conclusiva title track, una lunga composizione in cui fanno capolino anche le campane del duomo di Bolzano – perché il disco è stato inciso proprio nella mia città – entrate proditoriamente nei microfoni. Il suono gira attorno ad una base di basso, batteria e chitarra su cui si inseriscono sax e violino, un vibrafono, con l’aggiunta in seconda battuta di una scarna sezione d’archi e di una slide. Ma la colla di tutto è la voce di Laurie caratterizzata da una certa originalità e da un lirismo tutto suo. Tra i brani migliori, oltre ai due già citati è bene ricordare le iniziali High Above Heartache, East Wind – particolarmente ispirata – e Spirit Of The Stairway. Meno riuscita Across the Border, caratterizzata da suoni troppo stridenti che mal si mescolano col resto di questo interessante disco.
Paolo Crazy Carnevale

JONATHAN WILSON – Gentle Spirit (Bella Union 2011)
Uno dei dischi migliori tra quelli usciti lo scorso anno. Lo sto ascoltando da mesi a più riprese e di volta in volta mi sento sempre più coinvolto dall’ascolto. Ci sono brani che mi hanno impressionato da subito, ma col passare del tempo mi sembrano più familiari anche gli altri… Jonathan Wilson, a dispetto del cognome, non è uno dei Beach Boys, non è californiano, ma da anni si è trasferito sulla West Coast e per la precisone a Los Angeles, in quel Laurel Canyon che alla fine degli anni sessanta è stato un ricettacolo di artisti di levatura bestiale. Sarà l’aria, saranno i tramonti che si vedono guardando verso il mare, non lo so, ma questo lungo disco di Jonathan Wilson, offre una serie di mappe sonore degne degli illustri colleghi che hanno abitato il canyon molto prima di lui. Tredici tracce in tutto, alcune molto lunghe ed elaborate, suoni ricercatissimi che vanno a rispolverare un periodo della musica californiana che è difficile dimenticare. Forse la voce di Wilson non è memorabile come quella di David Crosby, non ha le inflessioni nasali di Neil Young o quelle gutturali di Garcia, ma è proprio da quelle parti che il cerchio va a quadrare, perché queste sembrano le influenze principali di questo disco, ci sono le atmosfere rarefatte, le ballate zuccherose, ci sono chitarre acide (Desert Raven e la title track) abilmente mescolate con acustiche delicate (Magic Everywhere e The Way I Feel), ci sono gli assoli distorti trionfali (Valley Of The Silver Moon, autentico inno conclusivo del disco) e ci sono echi di musica cosmica alla Aoxomoxoa. Il tutto senza che il disco perda un grammo in originalità e credibilità, perché per tessere questo capolavoro Jonathan Wilson si è fatto accompagnare da fior di amici, più o meno noti, il più conosciuto è Chris Robinson, ottenendo i giusti suoni e il le giuste atmosfere, registrando praticamente in casa. Difetti? Certo, uno davvero grande: l’edizione europea in cd in mio possesso ha note di copertina a stento leggibili, anche con la lente d’ingrandimento. Per fortuna esiste anche in vinile, doppio, naturalmente, vista la durata, ma non so dirvi se ci siano note più esaurienti su chi suoni, cosa suoni e dove suoni. Ma è tutto secondario, la musica è quel che conta: qui ce n’è molta ed è molto buona.
Paolo Crazy Carnevale
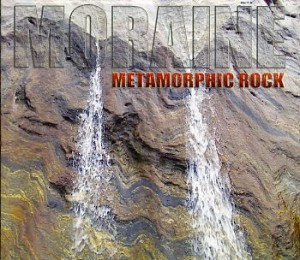
MORAINE – Metamorphic Rock (Moonjune 2011)
Tra gli artisti in forza alla casa indipendente Moonjune, con sede a New York, il chitarrista Dennis Rea è senza dubbio uno dei più prolifici ed eclettici. Negli ultimi tre anni è stato protagonista di altrettanti dischi con altrettante formazioni, esplorando territori jazz rock (in particolare con il quintetto Iron Kim Style), etnici, art rock con la formazione dei Moraine. Questo quarto disco, inciso proprio con i Moraine, è un po’ il sunto di tanto lavoro e la coronazione di tanti progetti con un bel live registrato a Bethlehem, Pennsylvania, nel corso del North East Art Rock Festival del 2010. La dimensione live si addice molto bene alla musica prodotta da Dennis Rea, che assecondato da un gruppo di musicisti preparati, su tutti la violinista Alicia De Joie (già Alicia Allen, ora sposa del sassofonista del gruppo James DeJoie) offre una performance di altissimo livello. Il repertorio del live del gruppo di Seattle va a pescare soprattutto in Manifest Density, il disco di studio del 2009, riproponendo una lunga versione di Middlebräu, un medley tra Disillusioned Avatar e Ephebus Amoebus, e ancora Kuru e Uncle Tang’s Cabinet of Dr. Caligari, ma ci s sono anche brani nuovi come Okanogan Lobe e Blues For A Bruised Planet. A impreziosire il disco, il cui missaggio è opera di Steve Fisk (Nirvana, Soundgarden), c’è poi la bella ripresa di un medley che va rispolverare le incursioni di Rea nella musica orientale del suo disco solo: Views Fron Chicheng Precipice, uscito nel 2010.
Paolo Crazy Carnevale

PURA FÈ – Tuscarora Nation Blues (Dixie Frog 2006)
Mi sono imbattuto in questo prezioso cd sull’onda della mappa di Late For The Sky cartaceo dedicata agli indiani d’America. Purtroppo l’ho scoperto solo dopo la pubblicazione di quello speciale uscito la scorsa primavera, altrimenti sarebbe entrato di diritto tra i dischi consigliati in quella sede. Cerco di rimediare ora. Ai più attenti consumatori di note di copertina, il nome di Pura Fè non dovrebbe risultare del tutto ignoto, trattandosi di un’artista che oltre ad aver partecipato a dischi delle Indigo Girls, è anche una delle componenti del trio vocale Ulali, presente tra l’altro nel Red Road Ensemble di Robbie Robertson. Pura Fè ha origini irochesi della nazione Tuscarora, portoricane e corse ed è titolare di una carriera discografica di tutto rispetto. In questo disco, ribadisco prezioso, fonde con capacità e gran gusto le proprie radici native col blues più tradizionale, realizzando un connubio riuscitissimo che ha dell’incredibile. Tuscarora Nation Blues si compone di tredici tracce per lo più acustiche quasi tutte a firma della protagonista che oltre a sfoderare una voce piena di pathos e molto duttile, suona la slide con sapienza e in qualche frangente anche il piano. Prima di questa edizione europea il disco era uscito negli States col titolo di Follow Your Heart’s Desire, con un paio di brani in meno. Pochi musicisti la accompagnano in questo blues nativo, un basso, percussioni qua e là, qualche chitarra aggiunta e canti pellerossa ad opera dei Deer Clan Singers che si innestano miracolosamente su trame blues che profumano di altri tempi. Importante nella riuscita del lavoro è senza dubbio la produzione sobria e calibrata di Tim Duffy e Sol. Delle tredici tracce non ce n’è una brutta, cosa da non sottovalutare, ma citarle tutte sarebbe dispersivo. Personalmente mi piacciono parecchio You Still Take in cui il coro nativo si infila nel finale di un brano tutto slide, Sweet Willie, forse dedicata a Willie Lowery che accompagna Pura Fè alla chitarra e al canto in tutto il disco. Going Home sembra in qualche modo imparentata col Ry Cooder degli anni settanta, mentre Follow Your Heart’s Desire, forse la perla del disco, è una ballata in cui il piano s’intreccia con una chitarra elettrica acida che ci riconduce ad atmosfere westcoastiane come nella west coast non se ne producono da troppi anni, con armonie vocali che sembrano figlie di David Crosby e Joni Mitchell. Forse non è un caso che la traccia successiva, una delle due cover (ma l’altra è un brano di Willie Lowery) del disco, sia una rilettura di Find The Cost Of Freedom introdotta da un testo originale e terminata in francese. Credetemi non esagero nel dire che questo disco è una delle produzioni più belle che mi sia capitato di ascoltare negli ultimi anni, se pur con cinque anni di ritardo sulla sua pubblicazione.
Paolo Crazy Carnevale
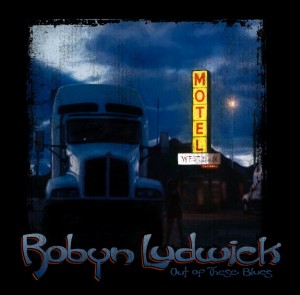
ROBYN LUDWIK – Out Of These Blues (Late Show Records 2011)
Un disco così non poteva sfuggire all’attenzione di “Late For The Sky”, non fosse altro per la bella copertina che ricalca a partire dalle tonalità della foto per finire con la grafica del titolo, quelle del capolavoro di Jackson Browne da cui la nostra rivista ed il nostro sito prendono il nome. Premesso che il contenuto del disco poco ha a che fare col cantautore californiano (ma nativo di Heidelberg in Germania!) e che la citazione si limita all’artwork del disco, ascoltando questo prodotto la prima cosa che balza all’orecchio è che si tratta davvero di un buon disco. Buono come se ne producono molti, ma titolare di un suono originale o quanto meno ben prodotto. Robyn Ludwick appartiene chiaramente alla schiera dei songwriters texani, lo si evince subito dal modo di comporre e di cantare, e penso ai texani delle ultime generazioni, non a Willie Nelson e soci. Nelle sue canzoni ci sono sicuramente le influenze di Lucinda Williams e Steve Earle, ma qua e là emergono anche radici più nere, messe in particolare luce dall’ottimo accompagnamento a base di organo Hammond del sempre grande Ian MacLagan, che si alterna alle tastiere con Gurf Morlix (responsabile come sempre anche di altri strumenti). Chitarre sobrie, voce decisa, sezione ritmica scarna e precisa, queste le caratteristiche del disco che ha dalla sua anche la presenza di un violino suonato da Gene Elders che in alcune situazioni fa tornare in mente (e non poco) quello di David Lindley per i dischi di Jackson Browne. Forse perché questa dotata cantautrice texana pare aver imparato bene la lezione dei songwriter della west coast mescolandola perfettamente con quella dei suoi conterranei. Ecco perché i certi momenti l’ascolto della title track e di Hillbilly ci fanno venire in mente certe produzioni di casa Asylum e For You Baby e Woman Now hanno un richiamo, la prima in particolare all’inizio, con lo stile del Neil Young dei primi settanta. Le dodici tracce del disco scorrono con una piacevolezza unica, forse con l’eccezione della campagnola Can’t Go Back che si discosta stilisticamente dal resto, e piace un po’ meno. Tra i brani forti si segnalano Fight Song, lenta e cadenzata, l’iniziale Hollywood che fa subito capire di che pasta siano fatti autrice e disco, Steady col B-3 che entra subito sotto la pelle fin dall’attacco. Questo è solo il terzo disco della Ludwick, ma tutto fa supporre che ce ne dovremo aspettare altri, e di buon livello.
Paolo Crazy Carnevale

![Jonathan Wilson Dixie Blur 1 (1)[265] Jonathan Wilson Dixie Blur 1 (1)[265]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2020/07/Jonathan-Wilson-Dixie-Blur-1-1265-300x212.jpg)