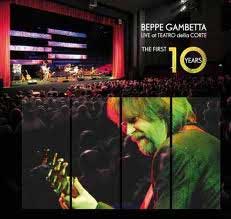Il fatto di riuscire a vivere della nostra musica non era quello che ci preoccupava. Noi eravamo sospinti dall’idea di avere una missione da compiere: rivoluzionare la musica. Eravamo persuasi del fatto di essere prossimi al compimento del nostro destino. Avevamo visto il rock uscire da una sorta di adolescenza per approdare ad una presunta maturità verso la fine degli anni ’60. Era divenuto più aggressivo, capace di affrontare in maniera più complessa la questione della condizione umana. Eravamo a quel punto preciso della storia ed ormai i riflettori erano puntati su di noi. Adesso toccava a noi raccogliere il testimone dai nostri fratelli maggiori e condurre il rock al suo destino glorioso: diventare una forma d’arte. La letteratura era morta, il jazz era morto, la scultura e la pittura erano morte dopo avere conosciuto il proprio apogeo. Una nuova forma d’arte era nata, inaudita e profondamente espressionista. Nonostante avessimo fiducia nelle nostre forze, eravamo altresì coscienti che nessuno se ne sarebbe accorto. Non ci facemmo alcuna illusione al nostro debutto: stavamo per cambiare faccia alla musica, ma nessuno lo avrebbe saputo.
(David Thomas, da un’intervista al magazine francese Jade, 1997)
Cuyahoga. A dying river. This is where we walked. Swam. Hunted. Danced. Sang.
(R.E.M., da Lifes Rich Pageant, 1985)
Cleveland, Ohio, 1975. Le acque del Cuyahoga scorrono placide nel loro letto millenario. Nulla sembra scalfire quel tranquillo moto ancestrale: non il loro aspetto, sempre più torbido ed oleoso, non il loro carico di rifiuti, di disperazione e sogni infranti. Lungo le sponde, come antichi guerrieri sopraffatti dal tempo, si stagliano i fantasmi di un passato che sembra ormai perduto: vecchie acciaierie, industrie manifatturiere, stabilimenti chimici e petroliferi della Rust Belt. Sembrano ricordare i bei tempi andati e, con la calma dei forti, attendono di rifiorire con la prossima età dell’oro. Ma difficilmente ce ne sarà un’altra. Il boom economico degli anni sessanta ha lasciato, soltanto qualche anno dopo, una città sull’orlo del baratro. Una civiltà urbana ricca ed industrializzata ha dovuto improvvisamente fare i conti con i giri di boa della Storia. Paura, disperazione, nevrosi, alienazione, soffocamento: sono i nuovi mali metropolitani e colpiscono soprattutto i più deboli e sensibili, i giovani. Chi non accetta lo status quo prova a scappare, a cercare una via di fuga reale o quella, più ingannevole e spesso letale, di qualche paradiso artificiale. Ma c’è un rifugio più sicuro, la musica. Gli echi della rivoluzione in atto a New York giungono anche da queste parti con il loro alone di leggenda ma, accanto a chi è pronto a sfogare il proprio furore nichilista, senza cercare risposte, nel punk più violento e autodistruttivo, c’è una gioventù che cerca di andare più a fondo, di penetrare il nulla che sembra avvolgere la vita reale dando sfogo alla stessa rabbia in maniera più costruttiva.
Vicino all’estuario del Cuyahoga, dalle parti di Old River Road, c’è un vecchio magazzino che apparteneva un tempo a John D. Rockfeller e che, secondo la leggenda, è stato la culla della sua immensa fortuna. Il nuovo proprietario, Jim Dowd, lo ha trasformato in un locale dall’aspetto un po’ tetro ribattezzandolo The Pirate’s Cove, il Covo dei Pirati. Se vi capita di passare da quelle parti il giovedì sera, non meravigliatevi se, accanto ai rumori della natura, mischiati al soffio della brezza serale, allo sciabordio dell’acqua contro le pareti delle imbarcazioni, ai lampi improvvisi che illuminano la facciata della vicina compagnia aeronautica Shot Penning, udirete dei suoni misteriosi che sembrano incendiare quelle visioni notturne. Provate a mettere il naso nel Pirate’s Cove. Sul piccolo palco improvvisato al centro del locale la Storia del Rock sta descrivendo un nuovo ed appassionante capitolo.
Quando Jim Dowd assoldò i Pere Ubu per il primo concerto non poteva certo immaginare quale mina sarebbe andato ad innescare, ma del resto non avrebbe avuto nulla da perdere: erano gli unici candidati! Quella sera la giovane band riunì una cinquantina di persone e tanto bastò per guadagnarsi il lasciapassare per il giovedì successivo. Ormai da quasi un anno sono l’attrattiva del Cove ed hanno diviso il palco con un sacco di band locali e di passaggio. Sono davvero giorni speciali, nell’aria si coglie tutto il peso di questa nuova onda che sembra voler travolgere ogni cosa: è emozionante vivere la Storia in diretta e sentirsene protagonisti.
David Thomas, il corpulento cantante, e Peter Laughner, allucinato chitarrista, sono due vecchie glorie della scena cittadina. Entrambi hanno militato nei Rocket From The Tombs, mitica band locale dedita ad un garage-rock grezzo e rumoroso, ebbro di miasmi psichedelici e furore proto- punk, che ha chiuso i battenti prima di consegnare al mondo una sia pur sparuta testimonianza del proprio passaggio. E’ per rimediare a questa drammatica nefandezza che i due hanno deciso di dar vita ai Pere Ubu.
David sembra essere la personificazione perfetta del protagonista della pièce teatrale Ubu Roi del drammaturgo francese Alfred Jarry (1873-1907) cui la band ha dedicato la propria epigrafe: concentrato di nevrosi e insofferenza per l’ordine costituito, anima grottesca e surreale, prodigioso interprete della malattia e delle paure del suo tempo; dopo trascorsi gloriosi come critico rock per il giornale locale (arriverà perfino a camuffarsi sotto pseudonimi diversi per non far trapelare che, in pratica, scrive tutto lui) si scoprirà cantante a mezza strada fra Tim Buckley e Captain Beefheart e, soprattutto, farà scoprire al mondo una delle voci più originali di sempre dell’universo rock. Intellettuale e poeta lisergico, amante del verbo psichedelico e fedele adepto al culto dell’espansione mentale e della liberazione della coscienza, Peter è, di fatto, figlio di un’epoca diversa trapiantato, chissà come, nella depressione nichilista di quei giorni. Troverà un rifugio nella musica ma, allo stesso tempo, una trappola mortale nei paradisi artificiali in cui sarà, sempre più spesso, costretto a traghettare le proprie illusioni.
Tim Wright, invece, era stato tecnico del suono per i Rocket From The Tombs. Quando gli è stato chiesto di imparare a suonare il basso non ha perso nemmeno un istante: si è comprato un vecchio Dan Electro a sei corde e in quattro e quattr’otto si è messo a disposizione. E’ stato ancora più facile sistemare qualcuno sulla seggiola della batteria: Scott Krauss, già meteora in diversi gruppi locali ed al momento disoccupato, proprio non aspettava altro. Tim e Scott vivono al Plaza, un vecchio residence alle porte della città. Da un appartamento non distante dalle loro camere giungono spesso rumori assordanti ed insopportabili. Del loro artefice essi conoscono solo il nome, Allen Ravenstime, e sanno che è un tipo strano che passa tutto il giorno, e ahimè anche qualche notte, a manipolare strane diavolerie elettroniche. Non potendolo eliminare decidono che è meglio farselo amico. Sempre al Plaza vive un certo Tom Herman, operaio metalmeccanico di giorno e chitarrista fallito di notte in giro per i locali della città: è proprio lui l’anello mancante per il varo della crociera inaugurale.
Per raggiungere l’obiettivo che si sono prefissi, quello di cambiare il volto della musica rock, i Pere Ubu hanno perfino elaborato una metodologia in sette punti ben definiti:
- Non fare mai prove
- Non cercare nessuno
- Non inseguire il successo
- Scegliere la prima persona con cui si viene in contatto
- Prendere sempre per buona la prima idea
- Riunire persone uniche. Le persone uniche suoneranno musica unica, magari senza nemmeno esserne capaci
- Ritardare il più possibile i Fattori di Distruzione Centrifuga, poi schiacciare il bottone.
Ora sono davvero pronti per conquistare il mondo, ma il mondo si accorgerà di loro?
Mi alzo in volo presto nella nebbia del primo mattino/in un drago di metallo imprigionato nel tempo/Accarezzo le onde di un mare sotterraneo/nella strana fantasia di un mondo da sogno. Il sole descrive un cerchio di fuoco come una volta nel cielo/il 25 è un’ombra velocissima sul verde mare lucente/Oltre la macchia pallida di una terra aliena/abbiamo solo tempo di rifugiarci nelle mani di qualche strano dio. I ragni neri della contraerea esplodono nel cielo/raggiunti su ogni lato da strani artigli contorti/Non c’è tempo per scappare, non c’è modo di nascondersi/Non si può fermare questa corsa suicida. Le strade di una città giocattolo si moltiplicano sotto i miei occhi/germogliano come grappoli di funghi in un mondo surreale/Questo incubo sembra proprio non finire/e il tempo scorre lento come se non fosse mai cominciato. 30 secondi in una corsa a senso unico/30 secondi e nessuna possibilità di nascondersi/30 secondi per Tokyo.
(30 Seconds Over Tokyo, 1975)
Un riff di chitarra asciutto e circolare di barrettiana memoria, una linea di basso che incalza su un frusciante tappeto sintetico, la voce di Thomas che narra dal profondo. Una tensione che sale attimo dopo attimo e che trova solo una piccola valvola di sfogo nelle aperture strumentali che spezzano il brano, piccole esplosioni di psichedelia free form con gli strumenti in caduta libera. Ma il solito riff ipnotico reintroduce nel vortice ed una nuova strofa getta altra benzina sul fuoco. Disperazione, angoscia e claustrofobia aumentano la loro pressione, diventano quasi palpabili; la tensione emotiva giunge a livelli insostenibili fino alla liberazione finale, con la voce allucinata di Thomas che ripete all’infinito il suo tragico refrain mentre gli strumenti esplodono ed il synth di Ravenstime sfregia la tela a colpi di lametta. Nessuno è mai andato oltre, nessuno è riuscito a rappresentare il senso apocalittico della fine e della sua ineluttabilità, a dargli un impatto visivo oltre che strumentale, come i Pere Ubu attraverso la tragica epopea del pilota che conduce se stesso ed il proprio carico di morte verso il centro del mirino. 30 Seconds Over Tokyo/Heart Of Darkness, primo singolo autoprodotto per la minuscola Hearthan Records vede la luce nel settembre del 1975 e per passare alla Storia, proprio quella con la esse maiuscola, davvero non sarebbe servito altro. Più lineare, ma non meno interessante, il retro: una danza macabra con percussioni tribali, base ritmica incalzante, chitarra sferragliante in secondo piano, progressione emozionale ed esplosione finale.
Dopo la pubblicazione del disco Ravenstime esce dalla porta senza un motivo particolare per rientrare dalla finestra nel giro di qualche mese. Viene rimpiazzato, nel frangente, da tal Dave Taylor, commesso in un negozio di dischi che ha il non indifferente pregio di essere l’unico a possedere, al pari del dimissionario, un sintetizzatore analogico EML, un modello ormai introvabile in quanto la società costruttrice ha da tempo orientato la sua produzione verso il mercato più remunerativo dei satelliti militari.
Alla fine del 1975 i Pere Ubu debuttano dal vivo al concerto di Capodanno del Viking Saloon di Cleveland con uno show zeppo di cover di Velvet, Stooges e misconosciuti gruppi garage. E’ un piccolo successo.
Sembra che io sia la vittima di una selezione naturale/o forse sono solamente scivolato nella direzione sbagliata. Non ho bisogno di una cura/ho bisogno della risoluzione finale.
(da Final Solution, 1976)
Il secondo singolo Final Solution/Cloud 149 esce nel marzo del 1976 per la medesima label che nel frattempo ha mutato il proprio nome in Hearpen. Final Solution, debitrice alla lontana della Summertime Blues dei Blue Cheer, è un garage rock dalla struttura più classica, con le consuete venature sintetiche ed una chitarra vera protagonista: sono la voce isterica di Thomas ed un lancinante assolo di Laughner nel finale, che cercano di bucare il vuoto di una generazione che giudica ormai irreversibile la propria malattia. Anche in Cloud 149 la chitarra tagliente e allucinata di Laughner recita da protagonista, in una progressione ritmica incalzante dalle tinte quasi funky. Alla luce dei fatti successivi si tratterà anche di un tragico testamento: Peter Laughner, sempre più affossato nella propria opera di auto distruzione, arriverà ad essere una palla al piede costringendo i soci a dimetterlo nel giro di pochi mesi. Morirà di overdose l’anno successivo. Entro la fine dell’estate se ne andrà, per controversie organizzative sulla struttura da dare al gruppo, anche il bassista Tim Wright, prontamente sostituito da un altro inquilino del Plaza, Tony Maimone. E’ anche il momento della prima trasferta nella Grande Mela, con alcune date nella culla del Max’s Kansas City, luogo di culto del rock newyorkese.
Prima del debutto sulla lunga distanza faranno in tempo ad essere pubblicati altri due singoli per Hearpen Records, Street Waves/My Dark Ages (11/1976) e The Modern Dance/Heaven (8/1977). Se le facciate A troveranno posto sull’album d’esordio, curiosa è l’antitesi fra gli altri due pezzi. My Dark Ages prosegue nello stile della band: un brano cupo ed opprimente che inizia lentamente per esplodere nel refrain, una voce filtrata più ubriaca del solito, che tenta svogliatamente di abbozzare qualche melodia, una chitarra che diventa acidissima quando riesce a ritagliarsi un po’ di spazio. Heaven, invece, è forse il brano più solare mai inciso dai Pere Ubu: un reggae irresistibile, scandito dalle chitarre e dai rigurgiti del synth, con una linea di basso quasi dub ed un uso delle voci nel ritornello che ricorda a posteriori i Talking Heads.
E’ proprio Street Waves che finisce nelle mani di Cliff Burnstein, boss illuminato della Mercury con l’hobby della ricerca di sangue nuovo fra gli scaffali impolverati dei negozietti alternativi. Contatterà immediatamente David Thomas, bruciando sullo scatto la concorrenza della rinomata Chrysalis, ed appositamente per i Pere Ubu arriverà a creare la sussidiaria Blank Records, al cui numero 001 di catalogo verrà finalmente pubblicato nel febbraio 1978 uno dei capisaldi dell’arte non solo rock del novecento.
The Modern Dance rimane ancora oggi, ad oltre venticinque anni dalla sua pubblicazione, l’affresco più lucido e spietato sulla decadenza della società industriale, la rappresentazione implacabile dei suoi effetti più nefasti: i sensi di alienazione, frustrazione, disagio, sconfitta che sembrano attanagliare in special modo le giovani generazioni, prigioniere di un destino che appare loro drammaticamente irreversibile. La danza moderna è quella dei superstiti di un drammatico day after sulle rovine della nostra civiltà: il bombardiere che lottava contro la sua coscienza in 30 Seconds Over Tokyo non è riuscito ad impadronirsi del proprio tragico destino ed ha vomitato il suo macabro fardello sopra la X tracciata sulla cartina. In un panorama di morte e desolazione, fra le macerie morali e materiali di una società il cui epilogo, comunque incontrovertibile, è stato soltanto accelerato dal precipitare degli eventi, si aggirano, come fantasmi, le anime dei sopravvissuti. Sembrano cullate dal vento, insieme alla polvere ed ai miasmi che si porta dietro la fine, ed il loro incedere ha qualche cosa di ritmico, di armonico: pare seguire un pentagramma che qualcuno ha tracciato nel cielo proprio accanto alle colonne di fumo. Una danza che è insieme rimpianto, speranza, liberazione, rinascita.
Musicalmente l’album prende le mosse dalla tradizione garage dei sixties, proprio da quelle officine nelle quali si era cominciato a plasmare il più puro spirito punk, per passare attraverso le radiazioni di quasi due decenni di modernizzazione del rock, arrivando, come tutte le grandi opere, a sopravanzare il suo tempo per stendere un ponte direttamente con il futuro. Ecco allora l’elettronica innanzitutto, ovvero il compendio della tecnologia applicata alla musica, con le tessiture folli del synth di Allen Ravenstime, vero protagonista dell’opera; la psichedelia, soprattutto nella sua forma più libera, quella che discende direttamente da Red Crayola, Deviants, Twink e dalle loro disordinate alchimie; l’avanguardia, figlia del blues del Capitano Cuore di Bue come dei maestri più colti della musica concreta del novecento; il rumorismo, sinfonia sinistra di una società in disfacimento, ma anche scampoli di free jazz, funky, punk, tribalismo. E la voce di David Thomas, sguaiata, sgraziata, atonale: l’urlo isterico di una vittima predestinata decisa fina all’ultimo a dire la sua.
E’ proprio il sibilo del synth ad aprire l’album, in Non Alignment Pack, per introdurre un riff di chitarra vicino alla tradizione rock and roll e sporcarlo ripetutamente con le sue folli frequenze. Sono il nuovo ed il vecchio che si incontrano e dimostrano che possono andare tranquillamente a braccetto. The Modern Dance è una cantilena alienante a ritmo di catena di montaggio, sporcata dai rumori delle macchine, dal vociare della folla, da disturbi indistinti e scandita dai rigurgiti del synth. Laughing si sviluppa fra tessiture free jazz ed introduce Street Waves, potenti linee di basso e riff garage di una chitarra secca ed abrasiva, che si libera in un bell’assolo prolungato mentre il synth tiene il tempo con le sue folate putride e perverse. Chinese Radiation inizia lenta, intimista, con un bel fraseggio di chitarra ed una voce gentile e rassicurante, poi degenera in un caos primordiale che restituisce, nel finale, l’innocenza perduta. Tocca a Life Stinks, ultimo dono della penna di Laughner, ricordare che fuori si respira ancora il punk, anche se un punk diverso da questo, allucinato, esasperato, misto ad aperture free jazz. Real World è un blues screziato dai mugugni del synth che va verso un finale in completa libertà per trovare pace nell’intimismo di Over My Head, danza lenta ed avvolgente, scandita da un lento arpeggio di chitarra e dai contrappunti del synth. Sentimental Journey è una disperata cacofonia per voce, fiati, synth, chitarra e stoviglie che vanno in frantumi, una preghiera inascoltata che sfocia nel caos annunciato dell’ennesimo esaurimento nervoso per trovare, in Humor Me, una chiusura leggera, dalla sensibilità quasi pop malgrado i soliti elementi di disturbo: almeno fino a che tengono gli schemi, prima che tutto volga nel caotico finale.
The Modern Dance vende (solo?) quindicimila copie, ma vale comunque ai nostri un tour in Europa e Stati Uniti che coincide con la pubblicazione di Datapanik In The Year Zero, prima parziale raccolta dei preziosissimi singoli del gruppo. L’influenza di questa opera prima sugli sviluppi della musica rock sarà comunque determinante: intere generazioni si forgeranno sulle sue nevrosi.
Nel novembre del 1978, ad appena nove mesi di distanza dal predecessore, viene pubblicato su etichetta Chrysalis Dub Housing, seconda prova sulla lunga distanza dei Pere Ubu. Il suono perde quasi completamente quella giocosa componente schizofrenica che aveva caratterizzato il debutto per farsi, se possibile, ancora più cupo: una discesa del maelstrom della disperazione, risucchiati nel vortice della follia in un viaggio senza ritorno verso gli abissi psichici dell’auto distruzione. E’ l’iniziale Navvy l’anello di congiunzione con The Modern Dance, uno sfrenato brano chitarristico sfregiato dalle pernacchie del synth e dalla voce ubriaca di Thomas, ma poi, come suol dirsi, la musica cambia. On The Surface, retta da un irresistibile giro del synth mostra, insieme a qualche elemento di disturbo, una sensibilità aliena quasi pop; Dub Housing è un blues spettrale lento ed avvolgente con splendidi contrappunti di sax e chitarra, mentre la succesiva Caligari’s Mirror, lenta, chitarristica, pennellata dal synth, alterna stati di trance a momenti più strutturati di strofa e ritornello. Con Thriller l’angoscia tocca un punto di non ritorno: una cacofonia post industriale condita con voci e passi sempre più vicini, rumori, percussioni, inserimenti strumentali completamente liberi ed allucinati in uno stato di anarchia crescente che culmina nel finale deturpato dal synth. I Will Wait e Drinking Wine Spodyody, sfrenate e sguaiate, introducono alla celebrazione per eccellenza del maestro di cerimonia di Ubu Dance Party, una danza surreale condotta sul libero fluire di tutti gli strumenti, con contrappunti corali quasi melodici alla voce impazzita di Thomas e le consuete intermittenze fuori frequenza del synth. Il finale è affidato a Blow Daddy-O, strumentale di impatto lisergico con vociare indistinto in sottofondo, e all’intimismo disperato di Codex, lenta, rarefatta, con armonie chitarristiche quasi Morriconiane, ultimo timido anelito di vita nel deserto pietrificato dell’anima.
Si parte subito per un tour in Inghilterra e nell’Europa continentale con supporter del calibro di Human League, Soft Boys, Nico e Red Crayola: un incontro, quest’ultimo, che si rivelerà di estrema importanza per gli sviluppi futuri della band. Nelle date di Londra l’ignaro pubblico del Magical Mistery Ubu Tour viene caricato su un pullman e trasportato, a sua insaputa, nelle cave di Chislehurts, dove il gruppo si esibisce in un suggestivo scenario naturale di grotte e pareti di gesso.
Il 1979 si apre con una curiosa performance alla 1st International Garage Exhibition in occasione della quale, giusto per gettare un po’ di fumo negli occhi della critica, sempre alla ricerca di un’etichetta e di un’agevole catalogazione, i Pere Ubu coniano per celia l’insignificante definizione di Avant-Garage (e la critica, senza rendersene conto, sentitamente ringrazia…).
Ma, bravate a parte, il periodo non è dei migliori. Le tensioni all’interno del gruppo sono lì lì per esplodere, nessuno sembra avere più voglia di lottare o di fare il più piccolo sforzo nella direzione dei compagni: il titolo provvisorio dell’album in lavorazione, Goodbye, non nasconde il suo probabile destino di epitaffio. Come sempre in questi casi, c’è anche la classica goccia che fa traboccare il vaso e, nella fattispecie, è un concerto a San Diego davanti alla bellezza di cinque spettatori. Per la chitarra di Tom Herman è davvero troppo ed il suo abbandono rischia di sfaldare definitivamente la band.
Nel frattempo, comunque, e per fortuna con un titolo diverso da quello previsto, esce, primo tassello del trittico per Rough Trade, New Picnic Time, terzo album ufficiale nella discografia dei Pere Ubu. Dopo il periodo garage e quello industriale, il lavoro segna l’avanzata nei territori della psichedelia free form, complice anche il sempre più consolidato rapporto di amicizia con il chitarrista dei Red Crayola Mayo Thompson, che ancora prima di rilevare ufficialmente il neo dimissionario, potrà vantare un ruolo di presenza attiva nell’orbita del gruppo. Le parole d’ordine sono destrutturazione, disarticolazione, astrazione, destabilizzazione, sperimentazione: in un solo termine, anarchia. New Picnic Time è il Trout Mask Replica della new wave e David Thomas è il nuovo capitano Cuore di Bue. La sua voce raggiunge agevolmente le vette più impervie ed i suoi grandi modelli, Beefheart e Buckley, sono proprio ad un tiro di schioppo; i suoi testi, complice anche la recente conversione al culto di Geova, appaiono sempre più surreali e visionari. Largo all’avanguardia quindi: accanto ai brani più classici (Have Shoes Will Walk, Small Was fast, One Less Worry, Make Hay, Jehova’s Kingdom Come), quelli che si dipanano da una potentissima sezione ritmica e da una comunque solida matrice funky/blues deturpata dalla voce sempre più ubriaca di Thomas e dagli irriguardosi sfregi elettronici del poliedrico Ravenstime, ecco le prolungate masturbazioni per synth e chitarra di 49 Guitars And One Girl, i cinguettii sintetici e le dissonanze di A Small Dark Cloud, la nenia impazzita di All Dogs Are Barking, il blues catartico di Goodbye, le violenze inflitte al synth in The Voice Of The Sand: chiamatela, se volete, musica da camera dell’era post industriale…
Con l’ingresso ufficiale di Mayo Thompson nella formazione, l’anno successivo tocca a The Art Of Walking, l’album che spaccherà in due la critica, da una parte chi lo considera un capolavoro e dall’altra coloro che ritengono sia solo un esperimento mal riuscito, e che, comunque, rimarrà il best seller nella discografia dei Pere Ubu classici. Il lavoro prosegue sulla scia psichedelica del predecessore, ma ne lima decisamente le asperità: brani dalla struttura più solida e con schemi ben definiti; più controllo, più pulizia anche negli episodi, e non sono pochi, in cui è più evidente la componente sperimentale; più ragione e meno schizofrenia. Non mancano i brani più tradizionali, quelli che si sviluppano da una matrice funky sovente plagiata da un synth sempre più primadonna (l’iniziale Go, Misery Goats, Rounder), ma più riconoscibile è la chiara radice psichedelica di episodi quali Birdies e la straordinaria Horses. Accanto a strumentali più canonici quali l’orientaleggiante Arabia ed a veri e propri incubi a due voci (Loop), si fanno strada i capitoli più sperimentali, segnati comunque da una costruzione molto più concettuale riguardo alle astrazioni passate. Stiamo parlando di Rhapsody In Pink, liquida, dilatata, con un recitativo di Thomas sopra incompiuti fraseggi di chitarra, timide pulsazioni del synth e solitarie note di un piano sgraziato; di Miles, cacofonia per voce, percussioni, organo, synth e tappeto ritmico elettronico ad intermittenza; di Lost In Art, lugubre strumentale per vocalizzi in libertà, colpi secchi alla grancassa ed efferatezze tastieristiche; di Crush This Horn, che chiude l’album con i disturbi di un synth in libertà, onde radio disturbate alla ricerca di una frequenza che, in lontananza, sembra rivelare a tratti una timida melodia.
Stranamente le esibizioni live del periodo, fra le quali alcune date con i Gang Of Four, procedono su binari del tutto opposti rispetto alle sperimentazioni dell’album, mostrando agli increduli fans un lato inedito quasi pop e goliardico. Un binomio, quello fra Arte e Pop, che non andrà a genio a tutti: anche nel gruppo, già teso per il riaffiorare di quei problemi che avevano portato non molto tempo prima ad un passo dallo scioglimento, cominciano a saltare un po’ di nervi. Il primo a farne le spese è il batterista originale Scott Krauss, che se ne andrà sbattendo la porta, sostituito dall’ex Feelies Anton Fier.
Preceduto da un singolo inedito, Not Happy/Lonesome Cowboy Dave, e dal bootleg ufficiale dal vivo 390° Of Simulated Stereo, esce nel 1982 l’ultimo atto Song Of The Bailing Man. Non un capolavoro, ma nemmeno un brutto disco per un gruppo ormai allo sbando, l’album si presenta come il lavoro più accessibile nella discografia dei Pere Ubu, quello più strutturato e marcato dalle influenze jazz del nuovo arrivato, che non fatica ad imporre il proprio punto di vista nel bailamme generale. Ne faranno le spese le individualità artistiche degli altri quattro Ubu, meno spiccate che in passato, quasi completamente risucchiate nell’amalgama generale e, soprattutto, i marchingegni elettronici dello scienziato pazzo Ravenstime, fino ad allora protagonisti assoluti delle sonorità della band. Le strutture dei brani, le linee ritmiche e strumentali sono quasi sempre vicine al jazz (The Long Walk Home, Pietrified, West Side Story), c’è posto per ritornelli accattivanti (Use Of A Dog), per qualche filastrocca allucinata (Big Ed’s Used Farms, The Vulgar Boatman Bird, My Hat). Qualche fragile ponte con il passato è ravvisabile nelle sperimentazioni di Stormy Weather, nelle divagazioni percussive e nelle aperture strumentali di A Day Such As This, nei fraseggi disarticolati di Thoughts That Go By Steam, nella conclusiva Horns Are A Dilemma, percorsa da splendidi fraseggi di tromba.
Ma il passato non torna più e, alla luce di un’ultima disastrosa tournee negli Stati Uniti, anche il presente si tinge inesorabilmente dei colori sbiaditi dei ricordi. Nel bel mezzo del 1982, anche se nessuno si cerca, nessuno si parla e nessuno prende decisioni, tutti nel gruppo hanno capito che i Pere Ubu non esistono più.
Per noi solo il tempo di una doverosa citazione: è per l’essenziale Terminal Tower, splendida raccolta dei singoli pubblicata nel 1985 da Rough Trade e recentemente ristampata, insieme agli altri album del periodo storico, dalla nostrana Get Back. E’ la rampa di lancio ideale per la vostra missione interstellare verso il pianeta Ubu.
da LFTS n.64