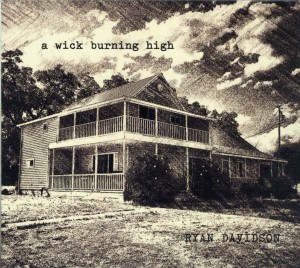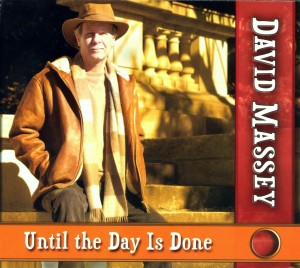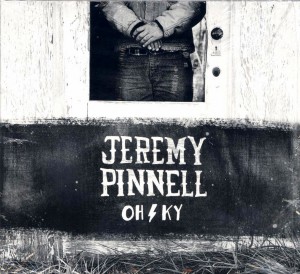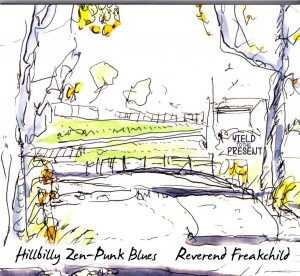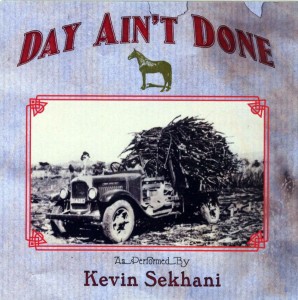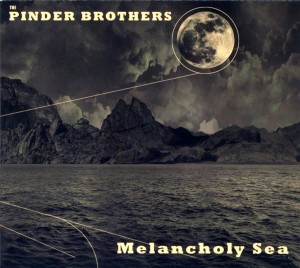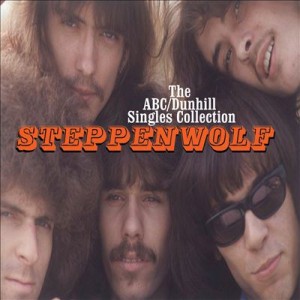GEORGE BRASSENS – Le banlieue, i carruggi e la periferia del mondo
di Marco Tagliabue
26 dicembre 2015
Eppure non danneggio nessuno
Seguendo la mia strada di uomo tranquillo
Ma alle persone per bene non piace che
Si segua una strada diversa dalla loro…
No, alle persone perbene non piace che
Si segua una strada diversa dalla loro…
(George Brassens – La Mauvaise Reputation)
Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
Con il suo marchio speciale di speciale disperazione
E tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi
Per consegnare alla morte una goccia di splendore
Di umanità, di verità
…
Ricorda Signore questi servi disobbedienti
Alle leggi del branco
Non dimenticare il loro volto
Che dopo tanto sbandare
E’ appena giusto che la fortuna li aiuti
Come una svista
Come un’anomalia
Come una distrazione
Come un dovere
(Fabrizio De André – Smisurata Preghiera)
Vorrei ringraziare George Brassens per averci dato Fabrizio De André, e poiché sulle canzoni di Fabrizio in molti abbiamo plasmato la nostra coscienza, cullato il nostro pensiero, affinato la nostra visione della vita e delle cose della vita, vorrei poter dire a Brassens che siamo davvero in tanti a custodire dentro di noi, più o meno consapevolmente, una piccola parte di lui. Non so se la cosa potrebbe fargli piacere: per un anarchico schivo ed individualista come lui, che ha sempre voluto coltivare il proprio pensiero in una sfera privata, intima, personale, questa dimensione in fondo pubblica, condivisa, collettiva, rischierebbe di suonare, anzi di stonare, come una tromba della celebrità. E, di fronte allo spettro di questa associazione sotterranea, anche se forse solo di idee, nel suo nome e nella sua “dottrina” , rischierebbe di chiosare come in quella sorta di “Avvelenata” ante litteram che è, appunto, “Les trompettes de la renommée”, chiedendo di essere lasciato in pace con le sue canzoni, di essere ascoltato solo attraverso di esse, alla larga dalla luce dei riflettori, dai titoli dei giornali, dalle vetrine sfavillanti che richiedono sempre la prostituta di turno. “Non ho il physique du role per stare in copertina/e non sono il manichino che può stare in vetrina/e non sono certo avvezzo a snodarmi i coglioni/se non per le mie donne se non per i dottori/Non è che per specchiarmi tra i fogli dei giornali/possa strimpellar note con i miei genitali/né somigliare a chi li porta come un suo blasone/nel modo in cui il prete porta il santo in processione/…/Avendo ormai sfogliato le mille e una ricetta/per diventare un bravo abituè della gazzetta/non sprecherò più il fiato per dar voce ai tromboni della celebrità/ma tornerò alle mie canzoni/Per chi le vuol sentire ne conosco una morra/sennò posso rimetterle dentro la mia chitarra/ma non pagherò il prezzo che si deve alla gloria/e tratterò l’alloro come fosse cicoria!” (trad. A.Buoninfante). E’ stato lui stesso, del resto, a metterci a parte del pericolo insito in ogni forma di associazionismo, di appartenenza a questa o quella schiera, foss’anche per la causa più giusta, quella più nobile, più condivisibile. Lo ha fatto nel modo a lui più consono, mettendo in musica i suoi versi, nella celebre “Ballade des gens qui sont nés quelque part”, la ballata della gente che è di qualche parte (“Mio Dio come staremmo bene sulla terra/se non s’incontrasse questa gente oscena/sempre inopportuna e del tutto indegna/Quelli di quel posto, di quella certa schiera/Mio Dio sarebbe bello in ogni circostanza/se non avessi fatto la razza irritante/che è la prova, infine, della tua inesistenza/gli imbecilli allegri che son di qualche parte/gli imbecilli che son di qualche città!” trad. A.Belli) e lo ha fatto, in maniera molto più netta, con una dichiarazione che non lascia il campo a dubbi o fraintendimenti e che rappresenta perfettamente, al tempo stesso, il senso più profondo del suo spirito anarchico. “Mi piace il pensiero solitario, detesto il gregge, ma questo non ha niente a che vedere con i necessari sforzi collettivi. Se ho bisogno di amici che mi aiutino a spostare una pietra, li chiamo. Non siamo stronzi se ci uniamo per trarre in salvo degli uomini sepolti in una miniera. Ma rifiuto il gruppo o la setta irreggimentata, e nessuno riuscirà a convincermi che si pensa meglio quando mille persone urlano tutte la stessa cosa. Quando ci si riunisce per pensare e dettare regole di comportamento, la setta non è lontana. (…) Il mio individualismo di anarchico è una lotta per pensare liberamente, non voglio che un gruppo mi detti legge. La mia legge, me la faccio da me. Siamo il risultato di quanto ci è stato dato, di quanto vediamo e sentiamo. Non posso pensare da solo, ma non voglio abdicare davanti al pensiero di un gruppo e neppure di un maestro.” (Brassens di N.Svampa/M.Mascioli, Muzzio, Padova 1991, pag.293). Ogni associazione, in fondo, è figlia di un credo comune, e non c’è niente di più pericoloso, di più fuorviante, di più effimero di un’ideologia, qualunque essa sia. Brassens su questo punto non ammette repliche: non c’è alcuna causa, per quanto giusta possa essere, per la quale valga la pena di morire, perché le idee cambiano (spesso il giorno dopo) ma la vita è una sola. E poi bisogna essere vivi per difendere la propria ragione, non serve a nulla portarsela nella tomba. Lo afferma senza tema di smentita, con la consueta, pungente ironia ne “Le deux oncles” (I due zii): “Tu, fido a Garibaldi e tu, fido al Borbone/udite questa mia modesta confessione/Le vostre verità e controverità/sono ormai snobbate dall’umanità/Ed a dispetto di quei grandi anniversari/che si commemorano all’ombra degli ossari/di tutti i martiri e gli eroi di quelle lotte/la gente ormai, mi si perdoni, se ne fotte/…/Non c’è una sola idea, miei cari, lo confesso/non una sola che giustifichi un decesso/Tutti coloro che hanno idee restino vivi/crepino invece quelli che ne sono privi” (trad.F.Amodei). Ed è, naturalmente, anche il tema centrale della classica “Mourir pour des idées” (Morire per delle idee), che conosciamo tutti grazie alla versione che ne fece Fabrizio De André: “Approfittando di non essere fragilissimi di cuore/andiamo all’altro mondo bighellonando un poco/perché forzando il passo succede che si muore/per delle idee che non hanno più corso il giorno dopo/Ora se c’è una cosa amara, desolante/è quella di capire all’ultimo momento/che l’idea giusta era un’altra, un altro il movimento/Moriamo per delle idee, va bè, ma di morte lenta” (trad.F.De André).
De André conobbe Brassens nel 1956 grazie a due 78 giri donatigli dal padre, di ritorno da uno dei numerosi viaggi di lavoro in Francia. Fu amore a prima vista, illuminazione artistica e politica. Gli scarti dell’umanità, gli stessi che popolavano le borgate romane di Pasolini, i carruggi del centro storico di Genova ove Fabrizio amava perdersi per ritrovare sé stesso, le banlieue parigine che facevano da sfondo ai protagonisti delle canzoni di Brassens e, più in generale, tutte le periferie del mondo, si facevano depositari di quei valori di purezza, di sincerità, di lealtà, di autenticità, che riponevano in loro le uniche ipotesi, o speranze, di riscatto politico e morale di quella stessa società che li aveva impietosamente messi da parte. Fu amore assoluto, quasi ultraterreno. Nel 1969, durante una breve vacanza a Parigi, De André preferì non assistere ai concerti che proprio in quei giorni il Maestro teneva all’Olympia per paura di scoprire un’immagine diversa da quella mitizzata, di trovare un uomo in carne e ossa sulle assi di quel palco e non un bellissimo dio greco, con la chitarra al posto della cetra: “Non ho mai voluto incontrare Brassens personalmente per mia debolezza. Era un mito e avevo paura che diventasse una persona. Se fosse crollato, mi sarebbe crollato il mondo. Volevo che restasse un mito”. De André ci consegna Brassens attraverso sei canzoni disseminate nei suoi primi dischi, “Marcia nuziale”, “Il gorilla”, “Nell’acqua di chiara fontana”, “Le passanti”, “Morire per delle idee” e “Delitto di paese”, tradotte fedelmente nel testo e nella musica, più una settima, “La morte”, che riprende il tema musicale da “Le verger du roi Louis” pur esibendo un testo estraneo a quello del brano originale. Per molti di noi, in Italia, George Brassens si è sviluppato da questo piccolo embrione, anche se la sua musa ispiratrice è innegabile in tante altre canzoni di Faber, da “Il testamento”, che non fa certo mistero di guardare all’omonimo brano del Maestro, a “Bocca di rosa” ed “Il pescatore”, che traggono linfa da “Brave Margot” e “La mauvaise reputation”, ed alla stessa “Guerra di Piero”, il cui tema centrale si potrebbe tranquillamente riassumere in questa strofa tratta da “Le deux oncles”: “Prima di metter nel mirino un tuo nemico/guarda se non riesci a fartene un amico/e non pensare che sia un atto da codardi/rinviare un colpo di fucile a un po’ più tardi” (trad. F.Amodei). Un vero e proprio maestro di pensiero che il cantautore genovese trattava, come si conviene, alla stregua di una materia filosofica: “Per me ascoltare Brassens equivaleva a leggere Socrate: insegnava come comportarsi o, al minimo, come non comportarsi. Insegnava ai borghesi un rispetto cui non erano abituati” .
E se non può certo destare scalpore la comunione di pensiero fra allievo e maestro, hanno viceversa i contorni dell’incredibile i punti di contatto fra la poetica del francese e quella, più o meno coeva, dell’epopea borgatara di Pasolini, tanto che verrebbe da chiedersi se non ci sia stato in qualche modo un interscambio culturale fra i due o, quantomeno, se fossero a conoscenza l’uno dell’altro. E’ il popolo, quello che affolla l’ultimo gradino della scala sociale, il protagonista della “commedia umana” dei due, quel popolo deriso, calpestato, messo da parte dalla vita e dai suoi discutibili protagonisti, quel popolo che si affanna per stare a galla, con mezzi leciti o illeciti, e nel quale, tuttavia, sono riposte le uniche speranze di salvezza. Di una salvezza tutta terrena, s’intende, del cui fallimento siamo testimoni noi e la nostra attuale società, quella società che nel frattempo ha sviluppato armi di sottomissione, di mercificazione, di omologazione e, diciamolo, di distruzione di massa, che Brassens e Pasolini potevano immaginare solo in parte e delle quali, comunque, non avrebbero mai potuto intuire la portata. Il popolo, lo stesso che affolla le canzoni di Brassens e le pagine di Pasolini, sono quei personaggi che di fronte ad una vita che li relega ai suoi margini, riescono sempre a trovare, con un misto di coraggio, furbizia e sregolatezza, il sistema per prendersi una piccola rivincita nei suoi confronti, per cogliere l’istante che il destino ti riserva quando meno te lo aspetti e viverlo fino in fondo per quanto piccolo esso sia. Personaggi scaltri, giocosi, goderecci, incuranti delle regole, della morale e dell’ordine costituito, come la protagonista de “L’orage” (Il temporale) che, per la paura dei tuoni, si rifugia nel letto del suo vicino quando il marito, venditore di parafulmini, è costretto ad uscire per lavoro, o come la vedova ancora calda, calda in tutti i sensi, de “La fessée” (Lo sculaccione), che non perde tempo e si consola proprio di fronte alla salma del marito, oppure ancora la tenera “Maitresse d’école” (La maestra di scuola), allontanata a causa dei metodi troppo libertini nonostante l’indubbio effetto positivo sul rendimento scolastico dei propri studenti. Del resto, una volta compresi i meccanismi che regolano la vita ed il rispetto e la considerazione del prossimo, non si può certo biasimare il povero “Orphelin” (L’orfanello), che si bea della propria condizione e di tutti i vantaggi che può trarre dalla commiserazione degli altri (“Non è una cosa strampalata/fare una lista dettagliata/di ogni favore domandato/che gli viene accordato/Traendone un gran vantaggio/certi orfanelli che coraggio/rimpiangono che di genitori/ne possono perdere due soli” trad. S.Pagano). Ma il popolo è anche il protagonista di quell’assurda guerra fra poveri nello splendido affresco sociale di “L’épave” (Il relitto umano), in cui un ubriaco, gettato inerte in mezzo alla strada, viene depredato dai passanti di tutti i suoi miseri abiti fino a rimanere completamente nudo. Solo una prostituta, mossa a pietà di lui e rossa di vergogna alla visione dei suoi genitali (“lei che, ogni sera poi, ne vede una dozzina”), si risolve a chiamare un gendarme che, con inaspettata compassione, ne copre le nudità con il suo mantello. Il popolo sono, naturalmente, anche ladri, puttane ed assassini, i veri, chiacchierati protagonisti di tanti brani di Brassens e De André. Ma il cattivo, quello vero, non esiste, ed allo stesso modo in cui una possibilità di redenzione nel brano appena citato viene offerta anche ad un poliziotto, un simbolo del potere, un rappresentante di quell’ordine costituito sempre deriso ed osteggiato, la medesima chance, ed a maggior ragione, è dovuta agli assassini pentiti di “L’assassinat” (Delitto di paese) i quali, dopo un orrendo delitto, riescono a conquistare il paradiso con qualche lacrima sincera poco prima di finire sulla forca. L’occhio del poeta guarda a loro, a tutti i reietti, senza supponenza o mistificazione, senza comprensione o pretesa di giudizio: è solo un immenso senso di umanità a guidarne la penna ed il pensiero, insieme alla speranza che anche per loro ci sia un’ancora di salvezza. E, accanto a questo sentimento, anche la certezza che esista, in ogni caso, una giustizia sociale, terrena, in grado di sovvertire le ingiustizie degli uomini e, soprattutto, quelle del potere, come ben sa il “giovane giudice con la toga” protagonista di “Le gorille” (Il gorilla), costretto a soddisfare l’appetito sessuale del bestione fuoriuscito dalla gabbia piangendo “come un vitello” e gridando ‘mamma’ “come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po’ originale aveva fatto tagliare il collo”. Questo non significa, naturalmente, che tutti i torti verranno riparati sulla terra, né tanto meno che in ogni caso sia poi destinata a subentrare la giustizia divina. La vita è fuggente e beffarda, tanto beffarda da negarti il tuo desiderio più grande proprio quando l’avevi a portata di mano, come avviene al protagonista di “Le nombril des femmes d’agents” (L’ombelico della moglie d’un agente), un vecchietto la cui ardente voluttà, scoprire quella parte nel corpo della consorte di un poliziotto, gli viene negata dalla morte un attimo prima della sospirata visione. Inutile, allora, farsi troppi scrupoli pensando all’incertezza del futuro: meglio vivere il presente in ogni sua sfumatura, coglierne ogni attimo come se potesse essere l’ultimo. Nulla dura in eterno, si supera qualsiasi delusione, qualsiasi sconfitta, ma ciò che alla fine fa sentire veramente il suo peso sono le parole non dette, le azioni mancate, i fiori non colti. Le occasioni perdute che, nel turbinio della vita, vengono dimenticate in fretta e sostituite ogni volta da emozioni più recenti, ritornano in mente nei momenti di solitudine, di vuoto, di malinconia, e fanno sentire tutto il loro peso: si pensa, inevitabilmente, che sarebbe bastato un soffio per far prendere alla vita una direzione diversa, si pensa a ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. “Ma se la vita smette di aiutarti/è più difficile dimenticarti/di quelle felicità intraviste/dei baci che non si è osato dare/delle occasioni lasciate ad aspettare/degli occhi mai più rivisti/Allora nei momenti di solitudine/quando il rimpianto diventa abitudine/una maniera di viversi insieme/si piangono le labbra assenti/di tutte le belle passanti/che non siamo riusciti a trattenere” (“Les passantes”- Le passanti, trad. F. De André). Tutto, allora, fuorché il rimpianto: l’errore piuttosto, ma non la rinuncia. Il pericolo maggiore è l’assuefazione al destino degli umili, ad una sorte che non lascia scampo: l’accettazione passiva della sventura come di un dato non modificabile, di una strada già segnata, al pari di quella del “Pauvre Martin” (Tristo Martino) che, dopo una vita di lavoro e privazioni, lo conduce invariabilmente a scavarsi la propria fossa. “Scavò lui stesso la propria tomba/per non doverlo domandar/e si calò senza parlare/per non volerci disturbar”. Il palcoscenico di una così variegata commedia umana è esclusivamente terreno, come terrena è l’unica possibilità di redenzione, per l’intera società, affidata alle mani degli umili. Brassens affronta i temi della religione e della chiesa cattolica con il consueto piglio ironico, con quel gusto per lo sberleffo che non risparmia nemmeno i testi sacri: “Ha dato la sua vita vabbé ma il suo zelo/aveva una portata da settimo cielo/ed il dolore era di certo attenuato/perché in tutte le chiese e le cattedrali/sopra i santi i papi ed i cardinali/il suo ritratto un giorno avrebbe dominato/Con il suo sacrificio salvò tutti quanti/ma al punto in cui noi siamo direi in fin dei conti/che il povero messia non ha avuto successo/il gioco, si usa dire, valeva la candela/e un mucchio di cretini e di gente di chiesa/per una causa simile farebbe lo stesso” (“L’antéchrist” – L’anticristo, trad.A.Belli). Mentre la Chiesa, con i suoi dogmi, le sue leggi, le sue regole immutate ed immutabili, è bersaglio quasi scontato delle frecce avvelenate del Nostro, la Chiesa che alimenta il senso di colpa insito nell’animo umano per preservare da ciò che è peccato secondo la sua dottrina (“La légende de la nonne” – La leggenda della suora), la Chiesa che impone ai suoi ministri sacrifici inutili ed ormai fuori del tempo (“La religieuse” – La religiosa), più complesso si fa il discorso riguardo alla vita eterna. Ammesso e non concesso che ci sia una vita dopo la morte, e che, a conti fatti, la vicenda ultraterrena non possa esser peggiore di quella l’ha preceduta, Brassens rivendica il diritto di perseguire la salvezza secondo una propria morale, lontano dalle ipocrisie e dagli stravolgimenti della fede: una morale che, fosse pure nel peccato, ha ben saldi quei principi, quei valori che differenziano l’uomo dall’animale, e che magari non sono altrettanto definiti sotto le volte ambigue di una fede esibita soltanto come un biglietto da visita: “E se l’eterno esiste, vede che in fondo anch’io/non mi comporto peggio di chi ha fede in Dio” (“Le Mécréant” – Il miscredente, trad.N.Svampa). Sono in fondo le stesse parole che urla Tito, il ladrone, dalla sua croce accanto a quella di Gesù, e che rappresentano il sigillo del suo Testamento nel ritratto che ne fece De André ne “La buona novella”. Maestro e allievo si incontrano ancora una volta per chiudere un cerchio che avremmo potuto ampliare a piacere.
Brassens è stato, in definitiva, l’inventore in Europa della figura del cantautore impegnato, quindi un padre non solo per De André, ma per generazioni di artisti di differente cultura ed estrazione. E’ colui che ha tracciato, nel nostro continente, di quel percorso umano, culturale e politico che, dall’altra parte dell’oceano, conduce da Woody Guthrie a Bob Dylan ed ai moltissimi figli che il menestrello di Duluth ha sparso per il mondo. E’ un capostipite, insomma, e probabilmente l’unica figura che meriti di essergli accostata è quella, appunto, del pioniere americano che metteva in guardia i fascisti dalle cannonate della sua chitarra. Brassens non fece nulla per farsi amare ed accettare dai suoi contemporanei. Le sue canzoni erano scarne, solo una chitarra, occasionalmente doppiata, ed un contrabbasso, qualche volta uno sbuffo di kazoo, alcuni cori sparsi qua e là, niente altro: un ascolto difficile, uniforme, “monotono”, che certo non andava incontro al gusto di un pubblico che si era appena lasciato una guerra alle spalle, che voleva vivere, divertirsi, cavalcare la rinascita, godere lo sviluppo senza pensare ad altro. Allo stesso modo le copertine originali dei suoi dischi erano molto simili e potevano generare confusione: foto in bianco e nero dell’artista ed immagini ravvicinate di parti della chitarra classica, spesso colte durante le fasi della sua lavorazione, quasi si trattasse di scatti rubati ad un liutaio. A coloro che superavano questi ostacoli e si accostavano alle sue parole, poteva andare anche peggio: sbattuti in faccia, senza pietà, c’erano quei temi scottanti che la grande maggioranza degli ascoltatori avrebbe preferito non sentire. Parole scabrose non tanto per il loro contenuto, quanto perché obbligavano il pubblico a pensare, ad affrontare situazioni di cui tutti erano a conoscenza ma che ognuno avrebbe preferito continuare a fare finta di ignorare, a tenere per sè. In questo modo non era più possibile. Brassens non soltanto non canta in coro l’inno nazionale, ma, in uno dei suoi brani più famosi, si ritrae come il pornografo del grammofono, il mascalzone della canzone, ovvero il cantore dei margini, delle oscenità che offendono il comune senso del pudore di chi, quelle oscenità, preferisce continuare a rincorrerle nel proprio focolare domestico al riparo da sguardi indiscreti. Quegli occhi che spiano e, impietosamente, rivelano al mondo quello che la cattiva coscienza dei borghesi non vorrebbe mai sentirsi dire e, per di più, con un linguaggio che allinea raffinata poesia ed eccentrico turpiloquio, sono come una telecamera puntata verso un’intimità che vorrebbe rimanere inviolata, sono una ghigliottina puntata sulla logica ipocrita di vizi privati e pubbliche virtù. “I benpensanti ed i bigotti, credono certo soddisfatti/che sarò preda al mio trapasso di satanasso/ma voglia il grande Manitù, che se ne intende un po’ di più/accogliere con un sorriso nel suo paradiso/questo pornografo del tuo grammofono/questo mascalzone della canzone” (“Le pornographe” – Il pornografo, trad. P.Capodacqua e E.D’Amato).
Paradossalmente, ma non troppo, Brassens e De André, oltre ad essere accomunati nello stesso destino di una morte prematura nel segno del solito male incurabile, dovranno subire post-mortem anche l’onta peggiore, quella di essere rivendicati come propri paladini anche da coloro i quali, in vita, furono i loro bersagli prediletti, coloro della cui considerazione avrebbero fatto volentieri a meno. Ma, tant’è, anche questo è un segno della potenza della loro Arte, che ha ormai abbattuto ogni confine per diventare un patrimonio di tutti, forse di troppi.
“George Brassens ci ha fatto uno scherzo. E’ partito per un viaggio. Alcuni dicono che è morto. Morto? Ma cosa significa morto? Come se Brassens, Prevert, Brel, potessero morire! (Yves Montand).
da LFTS n.107