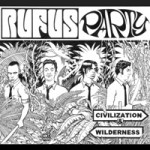BLACK COUNTRY
Black Country Communion
2010 J & R Adventures Records CD + DVD
Si tratta dell’album d’esordio di questo supergruppo! Nel novembre del 2009 al chitarrista Joe Bonamassa, che si stava esibendo al Guitar Center di Los Angeles, fu proposto di suonare con alcuni ospiti. Bonamassa, poco più che trentenne, è oggi uno dei migliori e acclamati virtuosi della chitarra blues di questo secolo: nato come chitarrista classico si innamora del blues ed esordisce a solo dodici anni suonando in tour con B.B. King, poi ha suonato con Eric Clapton e partecipato a tutti i più importanti Festivals di blues del mondo. Finora ha pubblicato quattordici album solisti. Fra gli ospiti c’erano Glenn Hughes, ex Trapeze e Deep Purple, stupendo bassista e solista e una delle più belle voci della scena rock britannica. Eseguirono dal vivo alcune canzoni, registrate da Kevin Shirley, produttore di Bonamassa. Visto il successo, Kevin propose di formare una band per alcuni tour e per incidere un album, invitando a unirsi loro alla batteria Jason Bohnam (figlio di John, batterista dei mitici Led Zeppelin) e alle tastiere Derek Sheridan, ex Dream Theathre ed ex Billy Idol band. Hughes chiamò la band Black Country ed entrarono negli Shangri La Studios di Los Angeles nel gennaio del 2010, con la collaborazione di Patrick D’Arey, uillean pipes e tin whistle, terminando le session in aprile e incidendo dodici brani che sarebbero stati pubblicati nell’omonimo album nel settembre dello stesso anno dalla J & R Adventures negli USA e dalla Mascot in GB, e prodotto dallo stesso Shirley con il trainante singolo Black Country. Tutte le song sono composte da Hughes, alcune con la collaborazione di Bonamassa, Shirley e Sheridan, tranne la stupenda e immortale Medusa, scritta da Hughes nel 1970 e pubblicata dai Trapeze, band della quale vi ho già parlato e che vi consiglio caldamente di conoscere. Ci sono brani di notevole impatto con un rock blues duro e aggressivo come Black Country, Down Again, The Revolution In Me e la chitarristica Too Late For The Sun. Poi, ballate intense e sofferte come Stand (At The Burning Tree), One Last Sound e Sista Jane, The Great Divide, ma tutte le song sono di ottimo livello e l’impatto strumentale e la voce di Hughes sono incredibili. Ho trovato una edizione a prezzo modico con allegato un DVD contenente le session in studio dei brani, interviste ai musicisti e al produttore su come è nata questa grande band, e una versione spettacolare di The Great Divide, registrata alla Riverside Arena nel tour promozionale del marzo 2010. Imperdibile! Recentemente è uscito il secondo album, Black Coutry Communion 2, altrettanto eccellente.
Daniele Ghisoni

JOE LYNN TURNER
Second Hand Life
2007 Frontier Records CD USA
Stupendo cantante rock statunitense, ricordato da noi, purtroppo, solo per essere stato il vocalist di Rainbow e Deep Purple, ma ha avuto una carriera incredibile come singer in altre grandi band, con innumerevoli partecipazioni come sessioman, autore, attore, ma soprattutto come solista di notevole vaglia, e ora vi racconterò la sua storia. Joseph Arthur Mark Liquito nasce il 2 Agosto del 1951 nel New Jersey da una famiglia di origini Italiane; alle scuole superiori forma gruppi con i quali esegue cover di artisti che andavano per la maggiore. Gli Ezra furono la sua prima band importante che lo fece conoscere al grande pubblico, poi arrivarono i Fandango, con il sound dei Deep Purple nel sangue e con due album stupendi, One Night Stand e Cadillac che vi consiglio di cercare. Dopo tour di successo come supporto a band come The Marshall Tucker Band, Allman Brothers e Beach Boys, la band si sciolse per lo scarso riscontro commerciale dei dischi. Joe (che aveva cambiato il nome) ricevette una sera del febbraio del 1981 una telefonata da Ritchie Blackmore che gli chiese di raggiungerlo nei Rainbow per sostituire Graham Bonnett. Con la band più famosa e amata del periodo Joe incide tre ottimi albums: Difficult To Cure, Straight Between The Eyes e Bent Out Of Shape, fino allo scioglimento del gruppo nel 1984 per la reunion dei Deep Purple. Inizia una carriera solista di buon livello con l’album Rescue You e con l’hit single Endlessly, nel 1988 incide Odyssey e Trial By Fire con Yngwie J .Malmsteon, ottimo chitarrista svedese. Poi l’anno seguente Blackmore lo vuole nei Deep Purple per sostituire Ian Gillan, e con la band inciderà, non per colpa sua, l’appena discreto Slaves & Masters. Col ritorno di Gillan, Turner torna on the road e la sua attività diventa frenetica: incide alcuni album solisti di buon livello come Undercover, Slam e The Usual Suspects; collabora e incide con Mothers Army (con Jeff Watson, Bob Daisley e Carmine Appice), i finlandesi Brazen Abbot, Michael Men Project, Sunstorm (gruppo tedesco davvero interessante con l’omonimo album). Forma gli Hughes Turner Project con un altro grande ex Deep Purple, Glenn Hughes, con tre album spettacolari che vi consiglio spassionatamente: HTP1, HTP2 e Live In Tokyo. Innumerevoli le sue partecipazioni a tribute album, colonne sonore televisive, sessionman nei dischi di Michael Bolton, Jimmy Barnes, Bonnie Tyler, Mick Jones, Leslie West, Riot e Billie Joel, solo citarne alcuni. Oggi gira con una nuova band, i Big Noize, col vecchio amico Vinnie Appice. Questo è il suo ultimo album ed è attorniato da ottimi strumentisti: Karl Cochran , guitars e bass, Michael Cartellone, drums, Bob Held, bass e Gary Colbett, keys. Con la coproduzione di Bob Held , incide dieci brani di sua composizione, molti dei quali in collaborazione con i musicisti che lo hanno accompagnato nella sua carriera. Love Is Life è una ballata hard rock molto intensa, Got Me Where You Want Me è molto più sofferta, Second Hand Life è uno dei gioielli dell’album, con la voce di Joe che ti entra nel cuore. In Your Eyes ha atmosfere soffuse, sensuali e intriganti. Un’altra chicca è Stroke Of Midnight, scritta con Blackmore e Glover ai tempi dei Deep Purple. Notevoli anche le ballate hard rock di Over The Top, Cruel e Sweet Obsession, mentre sono coinvolgenti Love Is On Our Side e Two Lights, quest’ultima come bonus. Un grande artista da conoscere e non vi ho mai deluso, cari coniglietti.
Daniele Ghisoni

COZMIC MOJO
Southern Frequency Club
2011 Cozmic Mojo CD
Una formazione curiosa quella dei Cozmic Mojo, un quartetto italo-texano che ruota attorno alla cantante di Austin Elizabeth Lee e al chitarrista bresciano Luca Gallina, giunti con questo lavoro alla loro terza prova discografica. A questo si aggiunga il fatto che il gruppo ha un notevole seguito in Germania ed ecco che avremo il ritratto di una formazione davvero senza frontiere. Rispetto al precedente lavoro, più orientato verso un sound texano più classico, questo nuovo CD dei Cozmic Mojo sembra aprire la strada, temerariamente e con successo, verso una musica più densa di contaminazioni, anche elettroniche, che ricordano certi esperimenti prodotti in casa Fat Possum, con la differenza che qui la tecnologia è applicata a un ambito country rock approcciato con spirito punk anziché al blues. La musica (quattordici tracce in tutto) sembra aver spostato l’asse dal Texas all’Arizona, più precisamente verso Tucson, pescando certe sonorità dai Green On Red (ascoltate l’apertura della traccia numero uno, Soundtrack) e certe altre dai Calexico (nel brano Yes ad esempio), fermo restando che quello dei Cozmic Mojo è soprattutto un progetto originale. Gran chitarre, suonate da Gallina e da Luca Manenti, col solido drumming di Federica Zanotti e naturalmente la voce di Elizabeth Lee. Ai puristi dirò subito che l’uso di certi campionamenti elettronici non guasta assolutamente, rende anzi molto attuale e fresco il suono del gruppo, che si arricchisce qua e là di partecipazioni da parte di amici al di qua e al di là dell’Atlantico, perché, trattandosi di una formazione cosmopolita, il CD è stato registrato in Italia e in Texas. La voce della Lee è molto calda e duttile, si adatta molto bene alle composizioni che lei stessa firma con Luca Gallina, che si tratti dell’ipnotica Box Song, con momenti quasi hendrixiani, o della jazzata The Clown. Blue Happiness pare celare echi zappiani in una struttura che con Zappa non ha nulla a che vedere, Longhing è sostenuta da un intreccio tra slide e chitarra effettata, Lupin, come ci si può attendere dal titolo, è cantata in parte in francese e aggiunge nell’arrangiamento atmosfere parigine che vengono regolarmente riportate in linea col resto del disco da break di chitarra acustica di tutt’altra natura. Il tutto a testimoniare quanta buona musica in sordina si produca in giro per il mondo.
Paolo Crazy Carnevale
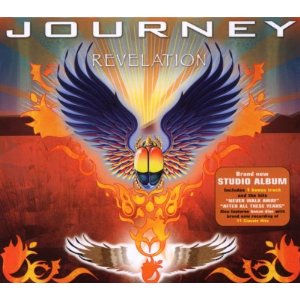
JOURNEY
Revelation
2008 Frontiers Records 2CD
In molti all’annuncio del nuovo cantante dei Journey hanno ironizzato sulla provenienza e le modalità di assunzione. Le battute sul fatto che il leader, il chitarrista Neal Schon (un passato, ormai molto remoto, nella band di Carlos Santana) si fosse trovato un nuovo cameriere, si sono sprecate. In effetti però il fatto che il gruppo, dopo le apparizioni di Steve Augeri e Jeff Scott Soto, avesse trovato nel filippino Arnel Pineda il sostituto del grande Steve Perry, attraverso YouTube dove il nostro aveva postato alcuni video con il suo gruppo, cover band dei Journey, The Zoo, poteva suscitare non poche perplessità. Invece, incredibile, Arnel sembra proprio un clone di Perry, capace di arrivare a tonalità incredibili. E Revelations è un disco niente male, beninteso per gli appassionati di un genere, l’AOR, che in Italia non ha mai goduto di troppi estimatori. Per costoro, i Journey non hanno bisogno di grandi presentazioni, gruppo che dalla metà degli anni ‘70 ha venduto quasi ottanta milioni di copie in tutto il mondo. Molti i brani da citare in questo lavoro, dall’iniziale, radio friendly Never Walk Away, nel classico stile del gruppo, a Faith In The Heartland, che già appariva in versione leggermente diversa nel precedente album, Generations. Oltre ai due musicisti già citati il gruppo è formato dal bassista storico Ross Valory, il tastierista Jonathan Cain (un passato nei Babys come peccato di gioventù) e il batterista Dean Castronovo, e chissà quanti dei fan di Vasco Rossi conoscono i Journey. Non mancano la classica ballatona strappacuore, nel loro classico stile, come After All These Years o i brani più ariosi come Like a Sunshower. Altri pezzi da novanta le trascinanti Where Did I Lose Your Love (che farà un figurone in versione live) e What It Takes To Win dall’ottima apertura pianistica, l’intensa What I Needed e la romantica, potenziale hit single, Turn Down The World Tonight. In allegato anche un secondo CD, nel quale vengono riproposti, con il nuovo singer, molti classici del gruppo, da Don’t Stop Believin’ a Open Arms, per enfatizzare la bravura di Arnel Pineta ed i parallelismi con Steve Perry. Ci rende orgogliosi il fatto che (piccola nota patriottica) il disco in questione, come il successivo, appena pubblicato Eclipse, veda la luce sotto il marchio Frontiers, label napoletana che annovera nel suo carnet anche gruppi come Whitesnake, Def Leppard e Yes. Promossi quindi i Journey, a patto che il prossimo cantante non vadano a cercarselo ad Amici.
Paolo Baiotti

MAGENTA
Home
2006 F2 Music CD + EP
I Magenta sono un gruppo gallese, di Cardiff. Questo Home è il loro terzo album in studio, pubblicato nel 2006. Home è un concept che narra la storia, ambientata negli anni ‘70, di una donna inglese, di Liverpool, che, stanca della routinaria vita nella città natale, matura il concetto che “casa” è ovunque ci si trovi. Affascinata dalla grande metropoli vola quindi negli States dove finisce invischiata in storie di droga, alcool e prostituzione. Dopo un incidente stradale, con conseguente ricovero in ospedale, trova la redenzione con un viaggio attraverso gli States, alla ricerca soprattutto di sé stessa, dove incontra una specie di sciamano nativo americano, Joe, che, portandola con se nella sua riserva, le fa capire che la vera vita, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, è a casa (home). Joe le fa ritrovare la retta via e sconfiggere i propri demoni, con il desiderio finale del ritorno al punto di partenza, là dove potrà sentirsi finalmente bene e in pace con sé stessa, in Inghilterra. L’itinerario del viaggio è dettagliatamente documentato nella piantina che occupa le due pagine centrali del libretto del CD. Quello dei Magenta è un prog moderno, con echi di Genesis, Pink Floyd, Yes e anche Rush, il tutto visto con una sensibilità femminile dovuta alla bravissima cantante Christina Booth. Il leader del gruppo, autore delle canzoni, è Rob Reed (basso, chitarra e tastiere). Gli altri componenti il gruppo, all’epoca dell’uscita di questo lavoro, erano i chitarristi Chris Fry e Martin Rosser, il bassista Dan Fry e il batterista Allan Mason-Jones. I testi sono del fratello di Reed, Steve. Su tutto comunque spicca la magnifica voce, personale e carezzevole, calda e piena di passione di Christina. Un vero angelo. Ascoltatela nell’iniziale This Life, in Moving On o nel gioiello spezzacuori Towers Of Hope, ripresa anche nella conclusiva Home. Ve ne innamorerete perdutamente. Le canzoni sono tutte belle. Le lunghe Journey e Joe sono le più canonicamente progressive. Hurt e Demons sono assolutamente floydiane (la prima mi ricorda anche i Rush), mentre in The Dream e Journey’s End oltre ai Floyd trovo echi addirittura dei Massive Attack, quelli più soft, quando si avvalgono di una voce femminile, oppure degli Archive di You All Look The Same To Me, se avessero come cantante Kate Bush. Morning Sunlight, che invece c’entra poco con il prog, potrebbe essere stata scritta da qualche cantautore americano, ed è impreziosita da delle armonie vocali quasi alla Eagles. Home Town è una ballata molto sentita e struggente. Una nota anche per la bella copertina che ritrae Christina vista attraverso i finestrini bagnati di pioggia di un taxi; un’immagine colma di malinconia che fa capire la situazione in cui si trova la protagonista del racconto (in musica). Da questo Home, che dura quasi settanta minuti, sono rimasti fuori cinque brani, per oltre quaranta minuti di musica, inclusi quindi nell’EP New York Suite, lavoro ancora più legato al prog e imprescindibile compendio all’album principale. I due CD sono infatti acquistabili separatamente oppure assieme, in cofanetto; ed è così che vi consiglio di procurarveli, in quanto inscindibili per apprezzare appieno il filo conduttore della storia. È infatti nell’EP che si narra della discesa della protagonista agli inferi degli aspetti più negativi dell’esistenza. Lavoro molto intenso, personale e intimo questo Home. Bello, bello, bello, da avere assolutamente. Attenzione però, potreste non poterne più fare a meno.
Gianfranco Vialetto
THE PIEDMONT BROTHERS PROJECT
Lights Of Your Party
2011 Flyin’ Cloud CD
Un bel passo avanti rispetto al disco d’esordio per la band/ progetto di Marco Zanzi e Ron Martin, due appassionati di musica, uno italiano, di Varese, e l’altro di quelle Blue Ridge Mountain, Carolina per la precisione, cantate nel disco in un riuscito medley tra Blue Ridge Mountain Blues e Flint Hill Special. A dispetto del fatto che si tratta di un disco realizzato giocoforza usando molto le tecniche di studio, visto che i due leader vivono su sponde opposte dell’Oceano, Lights Of Your Party brilla per una coesione un affiatamento davvero pregevoli. I suoni acustici e gli impasti vocali sono la sua forza d’urto che fa subito breccia nell’ascoltatore. Ondeggiando tra brani originali che nulla hanno da invidiare alle cover, e riproposte (scelte con oculatezza e motivazione) di brani altrui (Carolina On My Mind, A Child Claim To Fame dei Buffalo Springfield, One More Night di Dylan tra le altre), la raccolta propone una miscela musicale che brilla per spontaneità, passando dal traditional alla canzone d’autore americana, con belle iniezioni di musica irlandese e impasti vocali molto curati. Alle voci dei due ideatori del progetto (che deve il suo nome al fatto che entrambi vengono da zone pedemontane) si aggiungono quelle di Cecilia Zanzi (che si occupa del brano di Dylan), Rosella Cellamaro (alle prese col classico di James Taylor), Doug Rorrer (che affianca Ron Martin nel brano sulle Blue Ridge Mountains). L’amalgama è totale e più che del disco di un duo, come quello d’esordio, si può davvero parlare di progetto, con strumenti a corda suonati con in mente la lezione di gente come Earl Scruggs e Clarence White, organo Hammond B3 (nella bella Big Grey), fisarmonica, violino, piano e, scusate se mi ripeto, le voci! Tra le canzoni autografe, oltre alla citata Big Grey, spiccano lo strumentale Acousticharmonies, My Brother, Springtime Flowers e la title track. Menzione d’onore per il gospel conclusivo Down In Ther River To Pray.
Paolo Crazy Carnevale

UNITOPIA
The Garden
2008 Inside Out 2CD
Gli Unitopia sono un gruppo progressive australiano fondato alla fine del 1996 dal cantante Mark Trueack e dal tastierista Sean Timms. Il loro debutto discografico vede la luce però solo nove anni più tardi con il titolo More Than A Dream, ma il vero botto arriva con il successivo The Garden del 2008. Lavoro doppio con richiami, oltre ai soliti Genesis/Marillion (evidenti le affinità vocali di Mark sia con Peter Gabriel che soprattutto con Fish), anche ai King Crimson, ai Van Der Graaf Generator e ai più attuali Flower Kings, Spock’s Beard, Kaipa e Tangent. Ma ci troviamo anche accenni di jazz e world music con l’utilizzo di strumenti atipici per il genere come la lap steel guitar e percussioni tribali di ogni sorta, a carico di Tim Irrgang. Gli altri componenti il gruppo sono il chitarrista Matt Williams, la bassista Shireen Khemiani e il batterista Monty Ruggiero. Una caratteristica degli Unitopia, nome che significa, come da loro spiegato nel libretto del CD, vivere insieme in armonia in un mondo idealmente perfetto, soprattutto nelle leggi e nelle condizioni sociali, è quello di avere uno spiccato gusto per le soluzioni melodiche. Già con l’iniziale breve e intimista One Day ci si rende conto di essere di fronte a un disco fuori dall’ordinario. Dopo la splendida introduzione ecco il brano cardine dell’album, i ventidue minuti del pezzo omonimo si aprono con richiami tribali e proseguono con tali e tante variazioni da lasciare a bocca aperta, in una suite dove prog, hard, jazz, pop, world, fusion, funky e perfino musica classica si fondono in un insieme strabiliante. A completare un trittico iniziale da urlo, da stendere chiunque, ecco la magnifica Angeliqua, anche qui inizio etno, con voce femminile (della brava ospite Kiki Celarik), percussioni e fiati, per poi passare a uno stacco hard rock che si evolve nella dolcezza del cantato (alla Fish), che esplode nella piacevolezza pop del magnifico ritornello. Uno spettacolo! Gli altri brani del primo dischetto, tutti belli, tutti da citare, sono la dolce, inizialmente pianistica, ma con uno splendido crescendo Here I Am, la strumentale Amelia’s Dream che sfocia nella sognante I Wish I Could Fly e, a chiudere il tutto, la più spigliata e ritmata Inside The Power. Molti i pezzi memorabili anche nel secondo CD. Anche Journey’s Friend, l’altra suite e brano di lungo minutaggio, passa con disinvoltura dal progressive al jazz fino all’hard rock, dove la voce di Mark Trueack arriva a somigliare a quella del conterraneo Brian Johnson degli AC/DC. Give And Take potrebbe uscire da un disco del Peter Gabriel solista, con in più un ritornello piacevolmente pop che non guasta affatto. Dopo una bella ballata come Love Never Ends, con la splendida voce dell’ospite Kiki Celarik, e la breve, pianistica e classicheggiante So Far Away, il finale è per il crescendo della coinvolgente 321, brano che mi ricorda alcune cose del Fish solista. Una nota di merito all’etichetta Inside Out, che vanta nel suo carnet parecchi gruppi molto interessanti, per l’abilità nello scovare splendidi prodotti in ogni angolo del pianeta. Prog fans, fate assolutamente vostro quest’album, mi ringrazierete.
Gianfranco Vialetto

HOT TUNA
Steady As She Goes
2011 Red House CD
Se pensiamo che l’ultimo album in studio degli Hot Tuna è stato Pair A Dice Found del ‘90, preceduto da Hoppkorv del 1976, si può ritenere un evento l’uscita di Steady As She Goes. D’altra parte, bisogna ammettere che i due album citati non sono delle pietre miliari del rock californiano e che Burgers del 1972 resta il miglior disco in studio della band creata da Jorma Kaukonen e Jack Casady. In effetti, il duo proveniente dai Jefferson Airplane ha sempre dato il meglio dal vivo, a partire dal seminale omonimo esordio acustico del 1970, citando doverosamente almeno il doppio elettrico Double Dose, i due volumi Live At Sweetwater e Live In Japan del 1998. Cosa possiamo attenderci da un album in studio elettrico degli Hot Tuna? Non certo novità sconvolgenti e neppure la grinta di trent’anni fa, perchè gli anni passano e Kaukonen da tempo preferisce suonare acustico. Ma Steady As She Goes scorre veloce, ha qualche buona canzone nuova (nessuna memorabile) e cover arrangiate come sempre con gusto ed esperienza, è prodotto da un musicista di qualità come Larry Campbell negli studi di Levon Helm a Woodstock con un suono più roots che rock e conferma l’ottimo inserimento di Barry Mitterhoff (mandolino), da anni terzo membro della formazione completata dal nuovo batterista Skoota Warner. La chitarra di Jorma è meno aggressiva e psichedelica e il basso di Casady meno personale che in passato, ma l’alchimia tra i due musicisti è sempre notevole. Tra i brani spiccano la ballata Second Chances, un rock melodico con un riuscito impasto elettroacustico, l’energica A Little Faster, la grintosa Mourning Interrupted con un’elettrica pulsante, la delicata Smokerise Journey, il country-folk di Things That Might Have Been (un brano nelle corde del Kaukonen solista) e il conclusivo strumentale country-blues Vicksburg Stomp con il violino di Campbell. Da ricordare anche le due cover del Rev. Gary Davis, grande influenza del chitarrista, il rock-blues Children Of Zion e Mama Let Me Lay On You, profumata di roots country vicino al suono di The Band (sempre con il violino di Campbell). Peccato per un paio di tracce più banali, come Goodbye To The Blues e If This Is Love, che appesantiscono l’ascolto, abbassando la valutazione complessiva del disco.
Paolo Baiotti
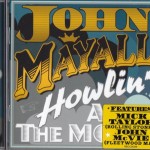
JOHN MAYALL
Howlin’ At The Moon
2011 Secret Records CD
Questo ennesimo disco dal vivo del padre del blues elettrico inglese comprende registrazioni dei primi anni ‘80 già apparse qualche anno fa nel doppio Rolling With The Blues di difficile reperibilità. Nel 1980 Mayall è in una fase non brillante della sua carriera: dopo alcuni album per la Abc la sua popolarità negli Usa, dove si era stabilito dieci anni prima, è declinata e anche musicalmente è in un momento di riflessione, lontano dalla creatività di dischi innovativi come Blues From Laurel Canyon o The Turning Point. I primi quattro brani sono tratti da un concerto a Huntington Beach del maggio ‘80 con James Quill Smith alla chitarra, Red Holloway al sax e una sezione ritmica formata da Kevin Mc Cormick e Soko Richardson, una band in grado di improvvisare con sapienza tra rock, blues e jazz. Si possono apprezzare versioni esplorative di Mexico City e Caught In The Middle decisamente interessanti e l’incisivo John Lee Boogie ispirato ovviamente dal suono di John Lee Hooker. Dopo lo scioglimento di questa band, nel 1982 Mayall decide di riformare i Bluesbreakers per un tour mondiale, richiamando alcuni musicisti con i quali aveva suonato negli anni ‘60. Rispondono all’appello il grande Mick Taylor (chitarra), John McVie (basso) poi sostituito da Steve Thompson e Colin Allen (batteria). Le altre sei tracce riguardano questo tour; quattro sono registrate negli States e due in Italia, a Roma e Lugo di Romagna. Emergency Boogie è guidata dall’armonica e dal piano del leader, con l’aggiunta degli arpeggi preziosi della slide di Taylor prima dell’entrata della sezione ritmica, mentre Rolling With The Blues è uno slow di ottima qualità nel quale spiccano gli assoli del piano elettrico e della slide, indispensabili anche nel punteggiare il mid-tempo blues di Howlin’ Moon. Ed è ancora Taylor il protagonista assoluto di Sitting Here Alone, registrato a Roma, formidabile slow blues caratterizzato dalle grintose acrobazie della slide, affiancata dall’armonica di Mayall e della conclusiva The Stumble, strumentale di Freddie King perfetto per esibire le qualità di solista dell’ex chitarrista dei Rolling Stones.
Paolo Baiotti
![early_seger[1] early_seger[1]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2011/12/early_seger1-150x150.jpg)
BOB SEGER
Early Seger vol. 1
2009 Hideout Records CD
Tra i cataloghi dei grandi artisti degli anni ‘70/ ‘80, nessuno è stato sfruttato meno di quello di Bob Seger. Una gestione assurda e inesistente, che ha avuto come conseguenza l’impossibilità di trovare (se non bootlegati) i dischi ante 1976, cioè precedenti a Beautiful Loser (e in questa scelta c’è sicuramente lo zampino dell’artista che non ha mai amato quei dischi e in parte li ha disconosciuti) e l’assenza di versioni rimasterizzate e potenziate di quelli successivi. Ora qualcosa si sta muovendo: Live Bullet, il mitico doppio che lo lanciò e Nine Tonight, altro doppio live, stanno uscendo in una nuova veste grafica con una bonus track ciascuno (che sforzo… brani già editi come b-side di singoli), mentre Seger un paio di anni fa ha pubblicato sul suo sito questa raccolta che sottointende ulteriori volumi… anche se per ora non ha avuto seguito. Ma anche qui le scelte sono piuttosto discutibili: dieci brani di cui cinque tratti dai primi album, registrati tra il 1971 e il 1973, un altro brano degli anni ‘70 con overdub recenti e quattro inediti degli anni ‘80 ritoccati in studio prima della pubblicazione. Quindi Early Seger è titolo in parte fuorviante e non riesco a capire la scelta di mischiare materiale di epoche diverse e in parte riregistrato. Per certi aspetti la parsimonia di Seger nel pubblicare estratti dall’archivio mi ricorda Bruce Springsteen di qualche anno fa. Detto questo, il contenuto musicale del dischetto è di ottima qualità. Le tracce già edite sono la cover di Midnight Rider degli Allman Brothers, più ritmata e incalzante, una splendida If I Were A Carpenter di Tim Hardin dall’intonazione gospel, una trascinante Get Out Of Denver di Chuck Berry (che diventerà un classico nella versione di Live Bullet), la ballata Someday (una delle prime grandi ballate dell’artista) e l’eccellente errebi U.M.C. (Upper Middle Class), mentre Long Time Comin’, tratta da Seven, è il brano modificato in studio con l’aggiunta di fiati e di una chitarra che lo rendono meno grezzo. Le tracce inedite sono la melanconica ballata Star Tonight registrata con la band dei Muscle Shoals Studios, la trascinante Wildfire (molto simile all’edita Roll Me Away) con Bill Payne al piano e la ballatona Days When The Rain Would Come, tratte dalle sessions di Like A Rock del 1984 (non avrebbero sfigurato sul disco) e l’incalzante errebi Gets Ya Pumpin’ del 1977, interpretato con voce negroide, con i fiati in primo piano. Brani interessanti che mettono in risalto la splendida voce dell’artista di Detroit, probabilmente non le sole outtake presenti nei suoi archivi, per non parlare del materiale live sicuramente disponibile. Speriamo che se ne accorgano e agiscano di conseguenza!
Paolo Baiotti
![marble_son[1] marble_son[1]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2011/12/marble_son1-150x150.jpg)
JESSE SYKES & THE SWEET HEREAFTER
Marble Son
2011 Fargo Records CD
L’ombra dei Quicksilver Messenger Service aleggia sul recente quarto album di questa band americana. Il gruppo è stato formato intorno al 2000 dalla cantante e chitarrista Jesse Sykes (proveniente dagli Homini) e dal chitarrista Phil Wandscher (ex Whiskeytown). The Sweet Hereafter oggi comprendono anche il bassista Bill Herzog e il batterista Eric Eagle L’esordio del 2002 con Reckless Burning è stato seguito da due altri dischi che hanno consentito al gruppo di crearsi un certo spazio nel circuito dell’alternative country con una musica intimista e rarefatta, caratterizzata dalla voce di Jesse, paragonata da qualche critico a Margo Timmins dei Cowboy Junkies. Il terzo album Like, Love, Lust & The Open Halls Of The Soul aveva mostrato una certa evoluzione verso un suono meno scarno, con una voce più aspra e una band più aggressiva, con arrangiamenti complessi e la presenza di fiati e altri strumenti, pur rimanendo in ambito folk-rock. Ma il recente Marble Son, pubblicato dopo una pausa di quattro anni, denota un deciso salto in avanti… anzi indietro, vista la forte influenza psichedelica che a tratti ci riporta alla San Francisco degli anni ‘60, quelli dei Quicksilver di John Cipollina e dei Grateful Dead del maestro Jerry Garcia, pur non ripudiando l’atmosfera e l’eleganza dei dischi precedenti e riuscendo a mantenere un ottimo equilibrio tra country, folk, chitarre distorte e riverberi, amalgamati dalla voce fascinosa della Sykes, registrata quasi in sottofondo rispetto agli strumenti. All’evoluzione del suono non è sicuramente estranea la crescente influenza di Wandscher che firma con Jesse i brani più psichedelici a partire dall’opener Hushed By Devotion, percorsa dagli abrasivi interventi del chitarrista, con fraseggi lisergici che si alternano alle parti vocali, cambi di ritmo e un finale strumentale da sballo. Marble Son è un esempio di psichedelia bucolica che rimanda ai primi Pink Floyd, mentre Ceiling’s High è una traccia quicksilveriana con un incisivo crescendo finale. Pleasuring The Divine ha una chitarra quasi heavy e fortemente lisergica che ci riporta alla Bay Area più creativa, come il formidabile strumentale Weight Of Cancer, che alterna una sezione più rilassata a un crescendo impetuoso. Infine, Your Own Kind amalgama alla perfezione la morbidezza inquietante del cantato con gli arpeggi incisivi della sezione strumentale che sboccia in una coda jammata. Gli altri brani si riallacciano al suono folk rock dei dischi precedenti, confermando tuttavia la coesione sorprendente del dischetto. Come To Mary è una ballata morbida e sognante, Servant Of Your Vision ha un cantato sussurrato e una chitarra essenziale, Birds Of Passerine è un elegante folk d’atmosfera e Wooden Roses un esempio riuscito di folk venato di psichedelia, come la morbida Be It Me Or Be It None, già pubblicata su un precedente EP. Uno degli album più interessanti di questo 2011.
Paolo Baiotti

GRAZIANO ROMANI
My Name Is Tex
2011 Panini Comics CD
A un paio d’anni di distanza dall’esperimento con cui ha messo in musica le avventure dello Spirito con la scure, il mitico Zagor, Graziano Romani ci riprova cimentandosi con un altro protagonista incontrastato degli albi a fumetti di casa Bonelli. E stavolta le sue attenzioni si sono indirizzate a Tex Willer, il re delle nuvole parlanti Made in Italy. Il disco che ne è uscito, My Name Is Tex, pubblicato dalla Panini (quella delle figurine, non la mitica casa discografica hawaiiana), è un vero e proprio attestato d’affetto al ranger Tex Willer, una dozzina di canzoni ben assortite tra brani originali firmati da Romani e alcuni ripescaggi dalla tradizione, con un occhio di riguardo per certe cose che erano finite in colonne sonore di film che il vecchio Bonelli aveva sicuramente visto e rivisto, e teneva in considerazione mentre scriveva le sue storie. L’unico appunto che si può fare è che il piglio musicale che ha sempre caratterizzato le composizioni di Graziano Romani non mi sembra sposarsi troppo con il mondo di Tex, lo dico da consumato fruitore di musica e di fumetti di casa Bonelli, a parte forse la bella resa del classico Red River Valley, frutto di una bella ricerca filologica. Per il resto, c’è la certezza che il musicista emiliano abbia messo la propria vena creativa al servizio di testi ispirati a Tex e soci: con una dedizione davvero encomiabile, i suoni del disco sono quelli giusti, la tradizione musicale nordamericana è rivisitata con gusto, le chitarre dominano, siano esse dobro, acustiche, slide. Qua e là emergono, violini, mandolini, fisarmoniche, il tutto senza mai esagerare o sbavare. E alcuni brani sono riusciti davvero bene, grazie anche all’interpretazione vocale dell’autore, al solito grintosa e sempre, come gli si riconosce praticamente da sempre, nella scia di Springsteen. Tra le cose che emergono c’è di certo la title track, ma ancor meglio sono Mephisto dominata da una tastiera insinuante, la tristissima e intensa So Long Lilyth, una ballatona dedicata alla moglie navajo di Tex, la latineggiante (con accenni al miglior Willy De Ville e al Dylan di Romance In Durango) Showdown With El Muerto. E tra le cose eccelse del disco ci sono, in chiusura Four Brave Riders e Quien Sabe Hombre, altri due brani di notevole fattura.
Paolo Crazy Carnevale

NEIL YOUNG & INTERNATIONAL HARVESTERS
A Treasure
2011 Reprise 2011/ 2009 NYA PS
Probabilmente, se Neil Young avesse consegnato un disco così a David Geffen, quando costui lo accusava di non fare dischi “alla Neil Young”, le cose sarebbero andate diversamente. A Treasure è il classico disco che Geffen e il pubblico si aspettavano dal loner canadese quando questo si alternava tra follie elettroniche, rockabilly e brutti dischi. Ma a Neil Young non si comanda, bisogna prenderlo così com’è, anche quando fa dischi poco ispirati, come gli ultimi di studio o come quelli degli anni ‘80. Questo ennesimo capitolo delle sue produzioni d’archivio non è male, non un tesoro come recita il titolo, ma almeno un tesoretto… Si tratta di incisioni dal vivo della metà degli anni ‘80, col gruppo con cui si esibì al Live Aid, quando il suo spettacolo oscillava tra un country addomesticato che avrebbe visto la propria risoluzione in Old Ways, reminiscenze dei fasti di Comes A Time (country meno addomesticato, per quanto inciso a Nashville) e sciabolate elettriche a cui Young non ha mai rinunciato. Con abbondanza di brani inediti, a partire dall’ottima Amber Jean dedicata alla figlia più piccola e dominata da un pianoforte ispiratissimo suonato dal grande Spooner Oldham. It Might Have Been proviene dal repertorio di Hank Williams e Flying On The Ground Is Wrong è un ripescaggio dai trascorsi di Young con i Buffalo Springfield. Suoni piacevoli, con l’immancabile armonica, la pedal steel di Ben Keith (scomparso lo scorso anno e produttore insieme a Young del materiale qui presentato) a dialogare con le varie chitarre del leader, sia che si tratti di Martin acustiche che della mitica Old Black. Trovano qui posto anche un paio di canzoni del trascurabile Re-Ac-Tor, che suonate dal vivo acquistano in spessore: Motor City e Southern Pacific. Tra gli inediti ci sono poi Your Fingers Do The Walking, il blues Soul Of A Woman, Nothing is Perfect (nota al pubblico per essere stata eseguita al Live Aid e trasmessa in mondovisione) e la finale ed elettrica Grey Ghosts che permette a Young di scatenarsi adeguatamente. Un disco forse non indispensabile, ma certamente piacevole. In attesa di altri “veri” tesori dagli archivi segreti del canadese.
Paolo Crazy Carnevale

THE STRANGLERS
Suite XVI
2006 Liberty/Emi CD
Gli Stranglers sono stati uno dei gruppi di punta del punk/new wave inglese storico. I loro primi album sono imprescindibili in qualsiasi discoteca degna di tal nome. Poi, diciamo da Dreamtime in avanti, una serie di dischi tra l’inutile e l’imbarazzante ne ha un tantino minato la reputazione. Nel 1990 arriva la defezione del chitarrista e cantante Hugh Cornwell, sostituito da John Ellis alla chitarra e da Paul Roberts al microfono, con i quali vengono incisi alcuni discreti lavori. Nel 2000 se ne va anche John Ellis, rimpiazzato da Baz Warne e nel 2006 esce anche Paul Roberts, così il gruppo torna alla sua classica formazione a quattro con, oltre all’ultimo arrivato Warne, i tre membri fondatori Jean Jacques Burnel al basso, Dave Greenfield alle tastiere e l’anziano batterista Jet Black. Baz Wourne, oltre a essere un ottimo vocalist, sembra aver portato una ventata d’aria fresca al gruppo e, nel 2006, vede la luce questo lavoro, l’ultimo a tutt’oggi, intitolato Suite XVI, gioco di parole con sweet sixteen, loro sedicesimo album in studio che, diciamolo subito, è un prodotto di tutto rispetto. Il basso pulsante di Burnel (leader con Greenfield) è in primo piano fin dall’iniziale Unbroken, che ci riporta ai fasti degli esordi. Molto bella anche la successiva Spectre Of Love, brano contrappuntato dalle fantastiche tastiere di Greenfield, che mi ricorda nel ritornello (avrò bevuto una pinta di troppo?) la meravigliosa e inarrivabile Under The Milky Way dei Church (una delle più belle canzoni di tutti gli anni ‘80), solo suonata al triplo della velocità e con attitudine punk. She’s Slipping Away rimanda dritti all’esordio Rattus Norvegicus, con le tastiere che copiano leggermente la loro Sometimes, il tutto riletto ovviamente in chiave moderna. Ascoltate anche il lavoro al basso in chiusura, bellissimo! E sempre con il quattro corde in evidenza parte Summat Outanowt, new wave tra No More Heroes e Black & White. Si prosegue con un altro brano fantastico, la ballata Anything Can Happen,dove voce e keys mi ricordano alcune cose del Nick Cave di The Good Son, registrato in Brasile, con anche influenze di bossanova. See Me Coming mixa il punk del 1977 con la Madchester di Stone Roses e Inspiral Carpets e già nel 2004 aveva fatto da colonna sonora a un cartone animato giapponese ispirato al romanzo Il Conte di Montecristo. Bless You è l’altra ballata dell’album, autentico capolavoro un po’ fuori dai consueti canoni degli Stranglers, con un finale quasi blues e un Baz Warne ispiratissimo, proprio l’uomo giusto per il ruolo lasciato vacante da Cornwell. A Soldier’s Diary è puro punk alla Stranglers (ah! Grande Greenfield), mentre con Barbara si sconfina nel pop, con una canzoncina piacevolissima e per niente banale. E a questo punto arriva una sorpresa, una cosa che non ci si sarebbe proprio aspettati. I nostri uomini in nero (dal titolo The Men In Black, vecchio album del 1981) se ne escono con I Hate You, un country che potrebbe essere stato interpretato benissimo dall’Uomo in Nero per eccellenza, Johnny Cash. La chiusura è affidata a Relentless, epica cavalcata con chitarra western su una ritmica e un cantato decisamente berlinesi. Grande congedo. Vabbè, le ho citate proprio tutte in una specie di lista della spesa ma, se non si fosse capito, la band è proprio in forma e non c’è un solo brano da scartare. Una gradita sorpresa; bravi davvero, anche perché pensavo di averli persi per sempre. Invece, gli Stranglers sono tornati con un ottimo album, e non conceder loro una possibilità di ascolto, solo perché considerati ormai sorpassati o bolliti, sarebbe oltremodo sciocco e ingeneroso.
Gianfranco Vialetto

VARIOUS ARTISTS
Bridge School Benefit 25th Anniversary Edition
2011 Reprise 2CD/3DVD
Bravo Mr. Young. Dopo averci tenuti col fiato sospeso per anni e con la voglia di ascoltare qualcosa di consistente dai concerti di beneficenza che annualmente organizza per sostenere il progetto benefico che lui e la moglie hanno fondato, finalmente ci concede qualcosa. Certo c’era stato un CD negli anni ‘90, e poi aveva messo su i-tunes una lunga serie di brani, ma per chi ama il supporto e lo preferisce alla musica virtuale, questo è il primo prodotto realmente soddisfacente. Con copertina totalmente identica, con prezzi davvero ottimi, la Reprise ha pubblicato un doppio compact disc e un triplo DVD, con una bella selezione di brani che devono la propria unicità al formato quasi unplugged messo in scena per l’occasione. I due prodotti non coincidono quanto a contenuto, o meglio, coincidono solo in parte. Per quanto riguarda l’audio è sempre notevole, bei suoni acustici, performer per lo più degni di nota, dai vecchi dinosauri alle nuove leve, nessuno escluso. Qualcuno si adatta meno al formato acustico (i Metallica, ad esempio) altri si scoprono invece notevoli in questa veste (Who e Sonic Youth), ma tutti fanno la loro parte, qualcuno è decisamente fuori contesto (il vecchio Tony Bennett nella versione CD oppure il vituperabile Billy Idol in quella video) ma nell’insieme saltano fuori delle belle cose. Neil Young, padrone di casa è presente con due brani per conto proprio, una spettacolare Love And Only Love sul compact e Crime In The City sul DVD, nella versione audio è anche con CSNY alle prese con una memorabile Deja Vu e su tutti e due i formati accompagna i REM nel pezzo forte del disco, una Country Feedback da urlo, e si fa vedere con Brian Wilson nell’esecuzione di Surfin’ USA. Bruce Springsteen apre in tutti e due i supporti con una solitaria Born In The USA, ci sono poi Pearl Jam, Dave Matthews Band, No Doubt, Gillian Welch, Sarah MacLachlan, Thom Yorke dei Radiohead che omaggia Young con una intensa After The Goldrush. Tra le cose migliori abbiamo una Patti Smith da antologia con People Have The Power, una versione acustica di Heroes con un insolito David Bowie, Nils Lofgren, un Dylan d’annata con Girl From The North Country accompagnato da G.E. Smith, Devendra Banhart con Bert Jansch come ospite (ma lo si vede appena), Paul McCartney, l’immensa Bonnie Raitt, i Pretenders con quartetto d’archi, James Taylor in formato musica da camera, uno spettacolare Tom Waits e molti altri. Le riprese video non sono forse il top, ma probabilmente erano state effettuate per uso non commerciale, in alcuni casi comunque sono più che apprezzabili. Nella confezione DVD, il terzo dischetto è occupato da un documentario sul Bridge Benefit.
Paolo Crazy Carnevale



![Neil Young Colorado[80] Neil Young Colorado[80]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2020/03/Neil-Young-Colorado80-300x300.jpg)
![Cover[922] Cover[922]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2018/08/Cover922-300x300.jpg)
![NY 2017 the Visitor 1[677] NY 2017 the Visitor 1[677]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2018/03/NY-2017-the-Visitor-1677-300x212.jpg)


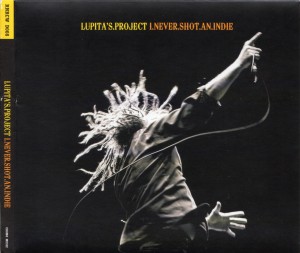






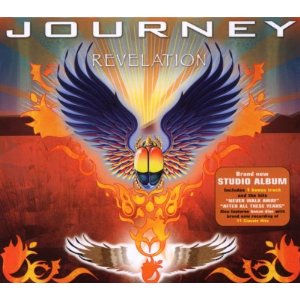



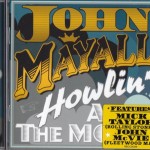
![early_seger[1] early_seger[1]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2011/12/early_seger1-150x150.jpg)
![marble_son[1] marble_son[1]](http://www.lateforthesky.org/wp-content/uploads/2011/12/marble_son1-150x150.jpg)