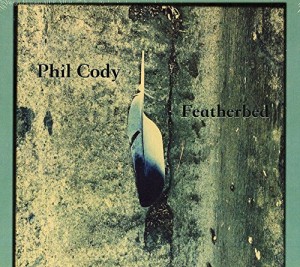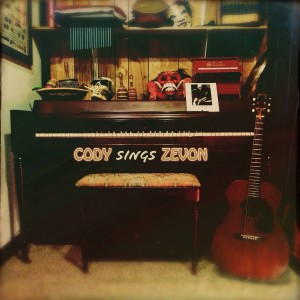PHIL CODY – Featherbed
di Paolo Crazy Carnevale
29 settembre 2015
PHIL CODY
Featherbed
(Back & Belly Recordings 2015/IRD)
Lo avevo auspicato nel reportage uscito sulla versione cartacea di “Late for the Sky” dedicato al tour italiano che la Phil Cody Band ha affrontato la scorsa estate ed ora è una bellissima realtà, anche se dimezzata: Phil ha infatti optato, anziché per un intero CD nuovo di zecca, per un EP di sette tracce, cosa che pare vada di moda recentemente negli States. Amen, evidentemente il songwriter dell’Ohio, ma da anni losangeleno a tutti gli effetti, preferisce centellinare le sue canzoni.
Cody dopo essere stato senza produrre nulla per quasi quindici anni era tornato a far parlare di sé lo scorso anno quando, per l’italica Appaloosa, aveva dato alle stampe un personale omaggio a Warren Zevon, Cody Plays Zevon, non un tributo qualunque, ma un atto d’amore nei confronti di un artista che era anche suo amico, uno per cui aveva aperto numerosi concerti negli anni novanta e che quindi conosceva profondamente, per non dire a menadito.
Al disco ha fatto seguito il suddetto tour con tutta la band, poi nella primavera di quest’anno Phil è tornato per un altro breve tour in solitudine per presentare questo nuovo lavoro. Ed è il caso di dirlo: evviva! Il tributo a Zevon era bello e intimo, ma diciamocelo, avevamo bisogno di una raccolta di canzoni nuove e ora che le abbiamo possiamo dire con sicurezza che Phil Cody c’è davvero ancora.
Featherbed, per quanto composto di appena sette brani (uno dei quali ripreso due volte) ci conferma la statura di Cody come autore e artista a tutto tondo: checché ne dicano i detrattori, quelli che non riescono a staccarsi dal ricordo del suo primo disco (The Sons Of Intemperance Offering, Interscope 1996), quelli che sostengono che Cody poi non ha saputo più essere all’altezza di quel debutto. Pretendere da Phil un altro disco come quello sarebbe come pretendere che Neil Young continuasse a rifare Harvest. Per quanto mi riguarda sono convinto che anche Big Slow Mover (del 1999) fosse un buon disco, tutt’al più penalizzato dal fatto che ci fossero due tipi di produzione ben distinti, ma era buono il disco ed erano buone le canzoni.
Le carte vincenti di Featherbed sono diverse, a partire dalle canzoni e dall’ispirazione per arrivare alla produzione unitaria e, non ultima, la scelta di usare, finalmente, i musicisti della band con cui Phil suona dal vivo quando lo fa. La Featherbed Band è infatti composta da Steve McCormick, Roger Len Smith, Bryan “Smitty” Smith (i tre compagni di tour), Andy Kamman, Rami Jaffe (proprio l’ex Wallflowers ed ora Foo Fighters a tempo quasi pieno) e Eric Heywood (uno dei più talentuosi artigiani della pedal steel della generazione di Cody e soci). Il suono è corposo, la registrazione di base è stata fatta nello studio di Jaffe dalle parti di Hollywood, ma la lavorazione vera e propria, le aggiunte, le rifiniture sono opera di McCormick che ha lavorato sodo con Phil nel piccolo studio di Mar Vista, praticamente Venice Beach. E giustamente McCormick è accreditato come produttore, perché il lavoro suona davvero alla grande proprio al lavoro che Steve ha fatto sulle canzoni.
Si parte con una vibrante cover di St. James Infirmary: il traditional riletto con sapienza da Phil e dal gruppo (reso particolarmente bene nei concerti dello scorso anno), con chitarre decisamente azzeccate, dall’elettrica di McCormick, che si occupa anche delle acustiche e del mandolino, alla pedal steel di Heywood. Di seguito arriva la title-track, un brano dalla classica andatura alla Cody, con Jaffe che spennella di hammond tutto il sottofondo, un’armonica sgangherata (potrebbe essere lo stesso Cody, ma tra gli ospiti figura il nome del “barone” Stan Behrens, armonicista e sassofonista dei Canned Heat negli anni novanta) e poi ancora le grandi chitarre il vero marchio di fabbrica di questa produzione: un’elettrica baritonale, la steel e il mandolino che emerge qua e là. Julianna per contro è un brano intimo, struggente, aperto dall’elettrica su cui entra la voce di Phil e poi ecco innestarsi le tastiere e la steel. Sinceramente non riesco a capire come queste nuove canzoni e questi suoni possano non piacere a qualcuno, eppure in rete mi è capitato di leggere commenti molto freddi a riguardo.
Moorestown è ancora più lenta e struggente, era un brano dei Red House Painters, l’arrangiamento ordito da McCormick ricorda molto certe cose di Daniel Lanois ed il pezzo è decisamente riuscito. Wild Bunch (Rides Again) è invece un divertissement del gruppo che sforna uno strumentale dall’andazzo spaghetti-western con i fiati di Behrens. Prima della fine (la ripresa di Featherbed in una breve proposta a cappella) c’è un altro brano molto alla Cody, No Long Goodbyes cantato con convinzione e con Eric Heywood che fa garrire le molte corde del suo strumento a pedali, sulla sezione ritmica incalzante e ancora quell’armonica soffiata come solo i grandi sanno soffiarla quando si tratta di abbinarla ad una musica che non sia il classico blues.
Non fidatevi dei detrattori, concedete questa chance a Phil Cody, è un consiglio da amico.